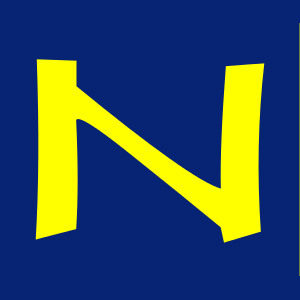Beati Paoli
di Luigi Natoli
prologo, capitolo 1
| Italiano | English |
La sera del 12 gennaio 1698, due ore prima dell'Avemaria, la piazza del Palazzo Reale di Palermo si empiva di una folla immensa, ondeggiante, varia, che si accalcava dietro le file della fanteria spagnola, schierata fra i due bastioni costruiti dal cardinale Trivulzio e il monumento di re Filippo V. Perpendicolarmente alla linea dei soldati, e con le spalle al quartiere militare degli spagnoli, erano ordinati tre squadroni di cavalleria, gente estera raccogliticcia, che, per tradizione, si chiamava dei Borgognoni.
In uno spazio sufficiente lasciato sgombro dinanzi al monumento, sorgeva un palco di legno coperto riccamente di velluto cremisi e verde, e chiuso in cima da una finta balaustrata di legno inargentato, a chiaroscuro.
Il lungo loggiato dalla ringhiera di ferro, corrente, come esterno corridoio pensile, dinanzi agli ampi finestroni del Palazzo Reale, era coperto di arazzi; e arazzi pendevano sul muro, fra un'apertura e l'altra, con effetto bellissimo. Tutti i finestroni erano aperti sebbene la stagione rigida non lo comportasse e nel vano di ognuno di essi scorgevasi un alto candelabro, con le sue torce, apparecchiato per la luminaria; ma quello di mezzo, sopra la grande aquila marmorea che stende le ali sull'arco del grande portone, era coperto di un ampio baldacchino di velluto porpora, ornato di lunghe frange d'oro e con nel campo le armi del re di Spagna e, sotto, quelle di sua Eccellenza don Pedro Colon de Portugal de le Cueva Enriquez, grande Almirante e Adelantado maggiore delle Indie, per diritto ereditario, come discendente di Cristoforo Colombo, duca di Veraguas e de la Vega, marchese di Xamaica, conte di Gelves e Villamico, marchese di Villanova dell'Ariscal, signore di Torrequemada, Alamedano, Alamedilla, e, finalmente, Vicerè e capitano generale del regno di Sicilia per sua maestà Carlo II. Sotto il baldacchino erano stati posti due seggioloni alti, troneggianti, e altre seggiole e sgabelli erano schierati lungo il loggiato, che, naturalmente, aspettavano di essere occupati.
Di palchi, come quello rizzato davanti al monumento di Filippo IV se n'erano costruiti altri due nella città; uno dinanzi al palazzo del Pretore, addossato alla magnifica fontana; l'altro nella piazza della Marina, dinanzi l'antico Steri dei nobili e magnifici Chiaramonte, nel quale s'era annidato il Sant'Offizio; ma d'intorno a questi altri palchi non c'era quasi nessuno, almeno per ora, giacchè tutta Palermo curiosa e festaiuola s'era riversata nella piazza del Palazzo Reale, dove lo spettacolo era più solenne, perché vi assisteva il Vicerè con la Viceregina e la nobiltà.
Veramente non si trattava di uno spettacolo, ma di una cerimonia ufficiale.
Il 20 settembre dell'anno innanzi, composta la contesa tra la Francia e la Spagna, si era conchiusa formalmente e durabilmente la pace, nel castello di Rijsvvijk in Olanda. La pubblicazione di quella pace, comunicata dalla Corte di Madrid, avveniva appunto quella sera di gennaio, non certamente con molta prestezza. E avveniva con le forme volute dal cerimoniale, cioè per ministero del nobile signor don Vincenzo Perino, bandi tore dell'illustre Senato palermitano, del tribunale del regio Patrimonio e del S. Offizio, nei luoghi soliti, regis personantibus tubis cioè al suono delle regie trombe. E verso le ventidue ore e mezza d'Italia, s'intese infatti un suono di trombe, di pifferi e di timballi, giù dal Càssaro, che fece voltar le teste e mareggiare la moltitudine. E allora il loggiato del Palazzo Reale si empì di signori, e sua Eccellenza e la Viceregina, con la maestà del grado, presero posto sotto il baldacchino. Via via che il suono si avvicinava, la folla che gremiva la piazza si apriva per lasciare libero il passo alla cavalcata del banditore, giacchè in quel cadere della monarchia spagnola, le pompe e le prerogative famose si erano moltiplicate, e il signor banditore, non contentandosi del semplice don, premetteva da sè, dinanzi al suo nome nella "certifica" dell'eseguito bando, l'epiteto di "nobile".
Forse aveva ragione; se l'idea di nobiltà nel senso sociale, si associa a un retaggio di padre in figlio, i Perino erano nobili. L'ufficio di banditore della città era un privilegio del loro casato fin dal secolo XV, e si mantenne costante ed ereditario per circa quattro secoli. Così la pompa con la quale esercitavano il loro ufficio s'era andata via via aumentando.
Il nobile signor Vincenzo Perino veniva preceduto dai musici della città, a cavallo; i pifferi innanzi, poi i timballi ed i tamburi, all'ultimo le trombe. I timballi erano una specie di tamburi moreschi; ogni suonatore ne portava due, uno per parte dell'arcione, e li suonava alternativamente o all'unisono. Dopo le trombe venivano i connestabili della città col bastone in mano, il mazziere con la sopravveste rossa e l'aquila palermitana sul petto e sul dorso, poi l'alfiere con lo stendardo della città, di metà cremisina, a nappe d'oro e l'aquila d'oro coronata; in fine cavalcava lui col bando arrotolato in mano, grave e solenne.
La cavalcata attraversò il piano del Palazzo e giunse al palco; il signor Vincenzo Perino smontò, salì sul palco, si tolse il cappello, fece le tre riverenze d'uso al Vicerè, e, ricopertosi il capo, svolse il foglio sul quale era stampato il bando. Allora le trombe squillarono; tutti gli occhi si volsero, il silenzio chiuse tutte le bocche e sulla moltitudine corsero le parole, scandite enfaticamente, che annunziavano la pace e invocavano la benedizione del Cielo.
Veramente, soltanto i più vicini poterono udire quelle parole; su al Vicerè alla nobiltà non saliva che un ronzio, e ai lontani non giungeva neppure quello; essi non vedevano che il gesto col quale il banditore accompagnava la lettura, ma non importava; la folla s'era adunata per vedere l'apparato, i soldati, la nobiltà; quanto alla pace non le interessava. Erano avvenute così lontane quelle guerre! e quella pace ne diminuiva i balzelli, ne aumentava la quantità di frumento necessaria per avere pane di buon peso e a poco prezzo.
Le trombe intanto squillarono tre volte, i soldati spararono a salve, i Borgognoni levarono in alto le spade; indi don Vincenzo Perino, disceso dal palco, rimontò a cavallo e col suo corteo attraversò di nuovo il piano del Palazzo, per andare a ripetere la lettura dagli altri due palchi. La folla gli tenne dietro. Il Vicerè e la Viceregina rientrarono; gran parte dei signori rientrò anch'essa, qualcuno indugiò sulla loggia a vedere la piazza; i fanti ritornarono nel quartiere, i Borgognoni uscirono dalla Porta Nuova e per lo stradone suburbano si avviarono alla loro caserma, presso il castello normanno della Cuba; nella piazza rimasero dei gruppi sparsi qua e là, che aspettavano il passaggio dei magnifici cocchi dorati della nobiltà che tornava dalla cerimonia.
Tramontava.
Era uno di quei tramonti in un cielo terso e luminoso, come si vedono soltanto a Palermo. Dietro Monte Cuccio acuto e arido, il cielo pareva d'oro, ma su su diventava roseo e dalla parte opposta il roseo moriva in una dolce tinta viola. La punta piramidale di Porta Nuova pareva d'oro ,d'oro le quattro torri della Cattedrale e i campanili; nell'aria e nella luce vi era come un tenue riflesso di quell'oro. Qualche signore usciva dal Palazzo Reale a cavallo e faceva caracollare la bella bestia bizzarramente; altri meno amanti di esercizi cavallereschi, preferivano lasciarsi portare in portantina, con un codazzo di servi e di schiavi, ma le dame preferivano la carrozza alla portantina. Carrozze grandi come una stanza, dipinte a fiori, rabeschi, putti, emblemi, con ricche dorature, chiuse da tende di finissima seta, sormontate da cinque pennacchi simili a cinque bioccoli di nuvole strappati al cielo, tirate da quattro o da sei cavalli d'un colore, dalle lunghe code, dalle criniere arricciate e ornate di nastri; con finimenti di cuoio e d'argento e ricchi pennacchi di finissime piume. Sulla serpa, coperta da una specie di gualdrappa di velluto con lo scudo della famiglia d'oro o d'argento smaltato, torreggiava il cocchiere in una livrea che avrebbe fatto arrossire di vergogna le uniformi ricchissime dei generali napoleonici; e agli sportelli e dietro la carrozza uno stuolo di lacchè, di staffieri, di volanti.
Lo sfilare di siffatte carrozze era per se stesso uno spettacolo di lusso e di magnificenza che allettava e richiamava la folla dei curiosi i quali, non potendo possederne, si consolavano a vedere quelle degli altri, con in fondo un certo sentimento di orgoglio cittadino.
Fra gli ultimi a rientrare nella gran sala del palazzo, dove sua Eccellenza faceva servire dei rinfreschi, fu un giovane cavaliere di aspetto fine e delicato, ma, forse, troppo serio. Si chiamava don Raimondo Albamonte. Non aveva ancora trent'anni; era alto, snello, nervoso; il volto pallido, ma come invaso da una nube fosca, che poteva parere tristezza, se un certo improvviso lampeggiare degli occhi non avesse fatto pensare al corruscare dei lampi lontani in un cielo nuvoloso. Le labbra sottili si disegnavano appena e la bocca pareva piuttosto una lunga ferita non ancora rimarginata: due lievi e bruni baffetti vi distendevano una piccola ombra, ma le mani e i piedi parevano quelli di una fanciulla: le sue mani bianchissime, piccole, sottili, affilate, dalle unghie rosee, elissoidali, si confondevano e quasi sparivano tra i pizzi finissimi delle due manichette. Egli pareva che ci tenesse; aveva infatti un gesto molle e grazioso per mettere la mano in mostra, sollevandola per discostare dalla fronte i riccioli della parrucca, che la moda francese andava diffondendo.
Con tutto ciò egli non aveva nulla di femmineo. Forse, esaminando bene l'angolo della mascella e la curva della bocca, un occhio scrutatore d'anime avrebbe potuto sorprendervi una certa durezza fredda ed egoista; forse anche qualcosa di felino, pazienza cioè e ferocia: ma per la maggior parte delle persone egli era un bel giovane un po' antipatico.
Era fratello cadetto del duca della Motta e vantava tra i suoi maggiori quel Guglielmo Albamonte, che era stato fra i tredici campioni italiani di Barletta, e che insieme con Francesco Salomone era stato fra quelli che avevano assicurato la vittoria italiana ma del vanto poteva gloriarsi più il duca suo fratello che lui, don Raimondo. Infatti il duca, colonnello di un reggimento, dopo una breve dimora a Palermo, era ripartito da circa otto mesi per la guerra, mentre don Raimondo, che avrebbe potuto benissimo comprare almeno una compagnia e formarsi uno stato, aveva preferito gli studi ed aveva conseguito la laurea dottorale a Catania, la sola università che in Sicilia, allora, conferiva la laurea in giurisprudenza.
Aveva qualche ambizione? Era così chiuso, così impenetrabile che nessuno aveva mai potuto sorprendere in lui qualche aspirazione, ma certo aveva nei modi e nella parola qualcosa di imperioso, una specie di gesto dominatore, maggiore di quanto lo comportasse la sua condizione di cadetto. Ma non pareva volesse entrare nella magistratura.
Nobile, fratello di un ufficiale di sua Maestà che aveva combattuto in quelle guerre di cui quel giorno si celebrava la fine, era stato invitato da sua Eccellenza il Vicerè, per godere lo spettacolo della cerimonia dal Palazzo Reale ed era rimasto in un canto del lungo loggiato col gomito appoggiato alla ringhiera e gli occhi vaganti su quel mare di teste, che ondeggiava nel vasto piazzale, forse senza percepire nulla.
La mattina, un amico venuto da Napoli con una tartana gli aveva recato una notizia che l'aveva rimescolato come un sasso che, cadendo improvviso nel fondo limaccioso di un pozzo, turbi la limpidezza dell'acqua facendo assommare la belletta. Forse lì, dinanzi alla vasta piazza, alla vista di quei soldati, la notizia lo aveva nuovamente conturbato; perciò egli era rimasto al suo posto, silenzioso, quando tutti erano rientrati, nè si era accorto di essere solo se non quando un valletto gli si avvicinò con un vassoio per offrirgli delle confetture.
Rientrò e si avvicinò al duca di Veraguas, serbando il suo contegno freddo e serio, e si mescolò al gruppo di signori che in quel momento parlavano con sua Eccellenza degli effetti di quella pace, nella quale qualche politico ravvisava già preparata la futura successione al regno di Spagna. Il Vicerè si accorse del cavaliere Albamonte e gli fece cenno di benevolenza e come don Raimondo gli fu dinanzi, gli rivolse la parola.
"E la signora duchessa?"
"Vostra Eccellenza sa che si trova già prossima".
"Lo so, e la Viceregina ha avuto la premura di mandare a chiedere notizie stamattina".
"Mia cognata è grandemente grata dell'onore che sua Eccellenza le ha fatto... Io l'ho lasciata che pareva si disponesse, per cui mi è parso prudente avvertire la signora Anna, la mammana".
"Il duca deve essere soddisfatto di avere affidato alle vostre cure la signora duchessa".
"Crede vostra Eccellenza?"
"Come no!..."
"Gli è, Eccellenza, che stamattina ho ricevuto una notizia assai cattiva ed ero quasi per chiedere la grazia di dirmi se vostra Eccellenza ha ricevuto lettere in proposito..."
"Quale proposito?"
"Sul conto del mio signor fratello, il duca della Motta".
"Nessuna. L'ultimo corriere non faceva alcuna parola di vostro fratello; che notizia avete ricevuto, e da chi?"
"Da! cavaliere fra Marcello de Oxorio, venuto da Napoli stamane con una tartana, il quale aveva saputo a Roma, da persona dell'ambasciata di sua maestà Carlo II, Dio guardi, che il duca mio fratello forse è morto."
"Oh, non è possibile!"
"Creda, Eccellenza, che sono stato tutto il giorno in una profonda agitazione..."
"Non ve ne do torto, ma non credo alla notizia. Deve essere un errore. Credete che trattandosi di un personaggio di qualità, come il duca della Motta, non mi avrebbero comunicato una simile sventura, se realmente fosse avvenuta?"
"Questo è vero, ma..."
"Eh, no! prima di ogni altro dovrei saperlo io."
Don Raimondo parve rassicurarsi: infatti quelle ragioni erano abbastanza convincenti e la notizia, così come gli era stata data, senza alcun particolare, poteva essere, anzi aveva tutta l'aria di una invenzione. Tuttavia qualcosa, come un dubbio, gli rimaneva in fondo al cervello.
"E se fosse vero? Se l'ambasciatore di Spagna aspetta la partenza del corriere di Roma per mandare la notizia ufficiale?".
Era evidente che fra Marcello de Oxorio, cavaliere di Malta, e in relazione con la società spagnola e con l'alto clero di Roma, aveva attinto la notizia, per quanto imperfetta, a una fonte sicura: e di duchi della Motta, colonnelli di sua Maestà Cattolica, non ve n'era certo una dozzina. Egli non riceveva notizie del fratello da circa tre mesi, tempo abbastanza lungo, che aveva tenuto e teneva in angustie la duchessa donna Aloisia e poichè le azioni di guerra erano già finite da oltre quattro mesi, non si capiva perché il duca non avesse mandato sue notizie e non avesse avvisato il suo prossimo ritorno.
"Se veramente mio fratello fosse morto?".
In verità il dubbio, per quanto tormentoso, non sembrava che toccasse in lui le corde della tenerezza fraterna. Un lieve corrugare di sopracciglia rivelava appena un pensiero insistente, ma nel rimanente il suo volto era impenetrabile.
Dopo un istante don Raimondo prese congedo e se ne andò.
Nell'anticamera trovò uno dei valletti di casa Albamonte, che era giunto allora allora in cerca di lui.
"Ebbene?" gli domando vivamente appena lo scorse.
"Eccellenza, ha i dolori, e sono corso..."
"Sta bene. Va' giù a chiamare la mia sedia."
Intanto che don Raimondo si faceva mettere sulle spalle un pesante mantello, il valletto scese precipitosamente le scale, cosicchè quando il cavaliere giunse ai piedi della scala, trovò la portantina pronta con lo sportello aperto, gli stafizeri con le torce accese, i portantini con le cinghie al collo.
"Presto a casa!" ordinò.
La duchessa dunque aveva i dolori del parto; una creatura stava per venire alla luce, forse un maschio, un erede. Se suo fratello era veramente morto, ecco chi l'avrebbe continuato. Il duca è morto, viva il duca! - così come alla Corte di Francia! Quella gravidanza era proceduta nella solitudine e nel silenzio. Il duca don Emanuele era venuto l'anno innanzi nel mese di marzo, per passare qualche mese con la moglie che aveva dovuto lasciare dopo due mesi di matrimonio per andare in guerra, e non la rivedeva da oltre sei mesi. Si era fermato a Palermo fino al mese di maggio; nei primi di giugno era ripartito, ma donna Aloisia recava nel fecondo seno il frutto di quella fugace luna di miele.
In quella parentesi aperta, come una rosea dolce oasi, fra le asprezze della vita del campo, egli aveva gettato la gemma del nuovo ramo nell'albero genealogico degli Albamonte. Ed ecco il ramo ora rampollava e si apriva in fronda novella al sole. "Sarebbe stata una femmina?". Questa idea faceva repentinamente brillare gli occhi di don Raimondo.
Il palazzo del duca della Motta sorgeva nella strada di S. Agostino, presso la piazzetta del convento della Mercede; era un antico edificio sormontato da una torre, conosciuta allora col nome di "torre di Montalbano", la quale era forse una delle antiche torri occidentali della città, incorporata con l'estendersi delle mura in una casa signorile. Del palazzo e della torre, ricordati nelle vecchie topografie, non rimane più vestigio, ma nel 1698, sebbene i pesanti balconi dalle ringhiere di ferro battuto e dalle mensole massicce, e il grande portone sopraccarico di cartocci di stucco ne avessero deturpato il carattere, serbava la sua massa imponente e troneggiava fra le altre case della contrada.
Il tragitto dal Palazzo Reale alla "torre di Montalbano" non era perciò lungo; bastava attraversare il piano della Cattedrale, scendere per la strada di S. Agata alla Guilla e tirare diritto oltre la chiesa di S. Cosmo, per la strada di Porta Carini, fino all'angolo della strada di S. Agostino. Due portantini robusti, come quelli che aveva il cavaliere Albamonte, potevano percorrerla in dodici o quindici minuti.
Don Raimondo trovò il palazzo in quella specie di disordine frettoloso che la nascita di una nuova creatura getta nell'animo di tutti. V'era nell'andare e venire dei servi, nel silenzio, nel sussurrio sommesso, nei gesti, quell'aspettazione di un evento che pare assorba in sè ogni energia dello spirito, tanto questo fatto, così comune e così meraviglioso, empie di sè l'animo umano e quel perpetuo rinnovarsi delle forme sorprende col profondo mistero dell'infinito. Don Raimondo attraversò l'anticamera e alcune sale con l'animo sospeso, non osando interrogare nessuno, sperando di cogliere qualche parola o un segno rivelatore. Si fermò in una sala non potendo andare oltre, perché la porta che avrebbe dovuto attraversare era chiusa. Sopra un doppiere ardevano due candele e diffondevano una luce blanda che moriva negli angoli e nell'alto soffitto, dove brillava tenue qualche doratura, come una stella. Era una specie di studio, o almeno poteva figurare per tale, in grazia di una grande scrivania e di un grande scaffale pieno di libri; giacchè veramente don Emanuele Albamonte non era uomo di studi, e di opere letterarie, fra quei libri legati in cuoio o in pergamena non possedeva che due poemi, i più comuni e più letti in quei tempi: la Gerusalemme e l'Adone ma v'era il trattato della Giostra di don Vincenzo Auria, come più rispondente alle inclinazioni di don Emanuele.
Un grido, smorzato dalle porte chiuse, riscosse don Raimondo; una sensazione strana gli percorse i capelli e si sentì un umidore alla fronte. Udì poco dopo aprirsi una porta e un passo attraversare la stanza chiusa; indi vide aprire la porta dinanzi alla quale si era fermato, ed uscirne una cameriera, che al vedere li un uomo, non riconosciutolo subito, gettò un piccolo grido di spavento.
"Ebbene?" domando don Raimondo.
"Ah! è vostra Eccellenza? M'ha fatto paura..."
"A che siamo?" ripetè impaziente il cavaliere Albamonte.
"Non ancora" rispose la cameriera, e attraversò la sala e si dileguò frettolosa.
Dalle porte socchiuse passavano più distinte le voci e i rumori: fra la camera e lo studio v'era di mezzo una stanza, nondimeno il silenzio della notte pareva abolire quella distanza. Don Raimondo udì un altro grido più angoscioso, più lungo, quasi strozzato; poi la voce di donna Aloisia gemere disperatamente:
"Vergine addolorata!... Aiutatemi Voi."
E immediatamente la voce della mammana (levatrice) recitare con monotona cadenza l'orazione, con la quale le levatrici in quel tempo aiutavano con fede il parto:
"Santo Liberto creatura al letto.
Santo Nicola creatura fuori.
Santa Leonarda una doglia lesta e gagliarda.
Madre Sant'Anna una buona doglia e una buona figlianna".
E poi una esortazione: "Forza e coraggio, Eccellenza."
Successe un istante di silenzio, che parve a don Raimondo lungo un secolo. La cameriera ritorno.
"Dove andate?"
"A far suonare l'Ave Maria di grazia."
"E dunque difficile il parto?"
"Non so..."
La cameriera rientrò nelle stanze della gestante e di nuovo il silenzio grave e pieno di aspettazione avvolse il palazzo. Poco dopo la campana grande del vicino convento della Mercede suonò nove flebili tocchi: era l'Ave Maria di grazia, cioè un invito a tutti i fedeli di pregare fervidamente la Vergine per facilitare un parto giudicato difficile e pericoloso; pia usanza, nella quale la superstizione si vestiva di una dolce poesia di fraterna carità nei dolori, e sul nascituro accumulava nello stesso istante la preghiera e l'augurio di cento cuori ignoti e perduti nell'ampiezza della città.
Don Raimondo rabbrividiva. Chi poteva prevedere quello che sarebbe avvenuto? Ecco un altro gemito squarciare improvvisamente il silenzio.
"Forza e coraggio, Eccellenza: madre Sant'Anna, aiutatela voi!... San Francesco di Paola..."
Due, tre urli tra rabbiosi e angosciosi, che non avevano più nulla di umano, si susseguirono a breve intervallo; poi più nulla. Don Raimondo sudava, con le mani appoggiate alla scrivania, l'orecchio teso, tutta l'anima sollevata e raccolta nell'orecchio. Le porte tornarono ad aprirsi: la cameriera uscì col volto lacrimoso: don Raimondo le domandò con ansia febbrile:
"Ebbene?"
"Un maschio, Eccellenza, bello quanto il sole!"
E andò via: e quasi nel tempo stesso, dagli usci socchiusi giunse all'orecchio del cavaliere Albamonte un piccolo vagito, il saluto alla vita, l'entrata al mondo del nuovo arrivato, il grido rivelatore col quale quel piccolo involucro di carne senza coscienza, diceva: Un altro uomo è nato! Don Raimondo non rispose, non si congratulò; un pensiero soltanto gli attraversò la mente: era nato il nuovo duca della Motta; anche se la notizia datagli da fra Marcello de Oxorio era vera, don Emanuele si continuava in quel suo erede. Don Raimondo rimaneva ancora, e sempre, un semplice cadetto senza fortuna, un numero, un soggetto, dinanzi a quel piccolo essere, la cui culla era sormontata dalla corona ducale.
Sempre?
Forse.
Non dicevano gli antichi che l'avvenire stava sulle ginocchia di Giove?