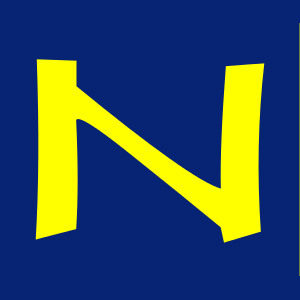Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 1
| Italiano | English |
La strada di Mezzomonreale, che per oltre tre miglia corre diritta dalle falde del colle Caputo alla Porta Nuova di Palermo, era nel secolo XVIII per un buon tratto, dalla Porta fino al convento dei Cappuccini, fiancheggiata da grandi e ombrosi alberi, fattivi piantare da Marcantonio Colonna durante il suo viceregno. Alcune fontane, delle quali ancora ne avanza qualcuna, ornavano il largo viale, e dei sedili offrivano comodi riposi all'ombra. Di qua e di là, oltre i muri che fiancheggiavano la strada, oltre le case rare, si stendevano orti, prati e agrumeti, sorgevano ville magnifiche, qualche chiesa lanciava sopra il verde il suo campanile svettante, il vetusto e grigio palazzo della Cuba torreggiava, triste e solitario superstite di una grandezza scomparsa, ridotto a caserma di cavalleria.
Questo stradale era in quei tempi una delle passeggiate favorite dai cittadini di Palermo, specie nelle ore vespertine e nelle prime ore notturne, nelle quali le ombre avvolgevano di mistero i convegni degli innamorati. Nel pomeriggio la strada era percorsa da portantine e carrozze rilucenti di dorature, sormontate da grandi pennacchi svolazzanti, e da una parte e dall'altra da modesti borghesi e popolani, che non potendo concedersi il lusso di essere trasportati dai piedi altrui, si compiacevano di riconoscere e ammirare gli equipaggi, che fragorosamente andavano e venivano fra Porta Nuova e la fontana dei Cappuccini. I giovani signori preferivano andare a cavallo, caracollando fra le carrozze e le portantine, per fare mostra della loro abilità e sfoggiare la ricchezza del loro abbigliamento.
Le carrozze di quel tempo erano ben diverse da quelle odierne così svelte e leggere; erano pesanti macchine, sorrette da cinghie di cuoio sopra ruote tozze e massicce, veri monumenti ambulanti; avevano nondimeno qualcosa di magnifico e di imponente. Erano tirate da quattro, sei, talvolta anche otto cavalli, tutti d'un manto, attaccati a due a due, con bardature e finimenti ricchissimi, con pennacchi dai vivaci colori sulla testa. La qualità e i mezzi del signore si rivelavano nella ricchezza delle sculture, nella bontà delle decorazioni pittoriche, spesso affidate ad artisti di grido, nella profusione dell'oro. Uno, quattro o cinque pennacchi sormontavano la cupola; tendine di seta con frange d'oro pendevano nell'interno, tappezzato di cuoio o di velluto. Il cocchiere troneggiava e veramente la cassetta su cui sedeva, coperta da una gualdrappa di velluto, con le armi della casa in argento e oro massiccio cesellato, pareva un trono, o un altare; ed egli un nume, nella sua ricca livrea, e nel gesto solenne col quale teneva le redini. Due o tre lacchè, in livree non meno ricche, stavano ritti dietro la cupola della carrozza, tenendosi a delle maniglie; e dinanzi ai cavalli, e ai fianchi della carrozza andavano i volanti, trotterellando, in pugno le torce, che all'Ave avrebbero acceso per rischiarare la strada al padrone, costretti a gareggiare col passo dei cavalli, a scansare cento volte l'urto di altri volanti e di altre carrozze o le zampe dei cavalli caracollanti.
Nè meno ricche erano le portantine: graziosi ninnoli, al paragone delle carrozze, di seta, d'oro, di pitture, trasportate da servi in magnifiche livree, circondate anch'esse di volanti. Fra esse se ne vedeva qualcuna più semplice, anzi sobria; o era da nolo, o apparteneva a qualche medico o prete.
La passeggiata in quel principio di secolo aveva dunque un aspetto di magnificenza e di ricchezza, e una varietà di colori e di luccichii, di cui difficilmente oggi possiamo farci una idea.
In mezzo a questa magnificenza s'insinuava talvolta qualche carretto, o qualche "redine" di muli carichi di sacchi di frumento o di otri, che attardatisi per la strada, giungevano a Palermo sul tramonto e si fermavano dinanzi a una taverna. I volanti, insolenti e soverchiatori, ributtavano da una parte carri e muli, quando non facevano in tempo a lasciare libero il passo; nè si davano pensiero se qualche sacco andava per terra e il grano si spandeva.
Appunto nell'ora del passeggio, e quando più risplendeva la pompa lussureggiante dei signori, in un pomeriggio di settembre del 1713 scendeva dalla strada di Monreale, verso Palermo, un giovane cavaliere, il cui assetto stonava maledettamente con quell'apparato di ricchezza, e più con la espressione del volto.
Non era infatti possibile immaginare nulla di più grottesco e di più caratteristico. Un cavallo da contadino, dal collo agro, dalle gambe nodose, i fianchi magri e ossuti, la criniera rada e ispida, aveva avuto l'onore di una sella guerresca, con gli arcioni alti, le staffe larghe, le fondine delle pistole istoriate di cuoio a colori, fermata sopra una gualdrappa di velluto rosso cupo ricamata e frangiata; ma la povera bestia non pareva compresa dall'onore toccatole, e andava con un passo da somaro, scuotendo la testa umile e dimessa. Su questo cavallo torreggiava un giovane robusto, di bello e fiero aspetto, vestito di una specie di casacca, il cui taglio ricordava forse i suoi avi, con stivali di cuoio alti fino alla coscia, e in capo un cappellaccio contadinesco, ornato di una piuma inverosimile. Il mantello di panno azzurro cupo, rotolato e ripiegato, gli giaceva attraverso l'arcione e su di esso poggiava un vecchio archibugio e un sacchetto. Un'antica spada, lunga, dall'elsa larga e traforata, gli pendeva dal fianco, battendo sulla sella ritmicamente; e i sacchetti per le polveri e per le pallottole gli pendevano dietro le reni. Non aveva la parrucca dai lunghi anelli riccioluti, ma una folta capigliatura bruna spiovente a ciocche ondeggianti e incolte sulle tempie e sulle spalle. Tra la povertà e la stranezza dell'abbigliamento e la nobiltà delle fattezze v'era un contrasto non meno violento e comico di quello che fosse tra la meschinità apocalittica del cavallo e la bardatura signorile e guerresca.
Entrando in mezzo al lusso degli equipaggi, tra i bei cavalli caracollanti, cavalcati da giovani signori azzimati, profumati, inappuntabili, il giovane cavaliere non sembrò vergognarsi, ma tentando coi lunghi sproni e con certi strattoni delle redini di infondere un po' di vivacità alla sua rozza stanca, infangata, teneva il capo eretto con aria spavalda e quasi di sfida, senza curarsi degli sguardi curiosi e beffardi e dei motteggi, salaci, coi quali era accolto il suo passaggio. Aveva oltrepassato il Convento della Vittoria, scansando, o per caso o di proposito, ogni urto, quando si vide venire di fronte, di buon trotto, due cavalieri, che pareva andassero allo sportello di una magnifica carrozza tirata da sei cavalli bianchi. Uno dei cavalieri, chinandosi talvolta sul collo del cavallo e volgendo il viso, pareva parlasse con qualcuno dentro la carrozza.
Il cavaliere campagnolo anche questa volta cercò di tirarsi da parte, ma la sua rozza non ebbe una sollecitudine proporzionata alla nobile furia con la quale gli venivano addosso i due cavalieri, sicchè uno dei due eleganti, strisciando al lato della rozza, urtò con la caviglia contro la staffa massiccia del giovane, col fianco contro il calcio dell'archibugio e si fece uno strappo alla falda del vestito, impigliatosi nella punta metallica del calcio.
L'elegante cavaliere si voltò infiammato di sdegno, senza trattenere il cavallo, gridando, nel tempo stesso che il giovane a sua volta, fermando la rozza vacillante, si voltava anche lui: i due gridi si incrociarono come due lame: "Villano!"
"Mascalzone!"
Nel frastuono dei cocchi e dei cavalli e nella furia con cui passavano, l'incidente passò quasi inosservato; i sei cavalli bianchi continuavano il loro trotto, e i due cavalieri, che, forse, di urti ne davano e ne pigliavano con frequenza, seguitarono a caracollare accanto alla carrozza. Ma lo strano viaggiatore non parve pigliasse la cosa con tanta leggerezza. Voltò indietro il ronzinante, e cacciandogli i lunghi sproni nei fianchi, furiosamente, lo spinse per rincorrere la carrozza e i cavalieri.
Non gli fu necessario percorrere troppo cammino; perché la carrozza, giunta alla fontana dei Cappuccini, ritornava indietro, cosicchè il bel cavaliere grottesco si trovò ben presto di faccia ai due eleganti.
Questa volta sbarrò loro il passo, piantandosi sulla loro strada, col pugno sul fianco, il capo eretto, e il cappellaccio calcato sopra un occhio: "Signore!" gridò, costringendoli a fermarsi, e volgendosi a quello che lo aveva urtato "poco fa vi ho dato del mascalzone. M'accorgo di avere errato, e ve ne domando scusa..."
"Sta bene... levatevi dai piedi adesso..."
"Un momento; ve ne domando scusa, e rettifico: voi siete un imbecille."
A questa uscita il gentiluomo arrossì di collera, e spinto il cavallo, gridò: "Villanaccio malcreato! ti farò insegnare dai miei servi il rispetto che si deve ai pari miei..."
"Perbacco, signore!... Avete dunque dei servi per tutori della vostra dignità e del vostro coraggio?.."
L'altro gentiluomo allora intervenne, cacciando il suo cavallo in mezzo, con visibile impazienza: "Andiamo, principe! vi sembra degno di un par vostro scendere a tu per tu con un pezzente, che basterebbe guardare per riderci sopra?... Andiamo!..."
"Capperi, signore; ecco una cosa che ci differenzia: voi ridete per cose insignificanti, come sarebbero i cenci: io rido di ben altre miserie d'un ridicolo più elevato; per esempio, rido di voi! E poichè vi ho detto quel che volevo dirvi, vi sono umilissimo e devotissimo servitore, e vi lascio in libertà."
Si tolse il cappellaccio con comica gravità, scotendo la folta capigliatura in due inchini burleschi, e voltata la briglia si trasse da parte, fra il dispetto e lo stupore che mal si celavano sotto la maschera disdegnosa e superba dei due signori.
Poi, a un tratto, come risovvenendosi di qualche cosa, aggiunse: "A proposito, se mai lor signori avessero qualche cosa da farmi sapere, io mi chiamo Blasco da Castiglione, e vado ad albergare nella locanda del Messinese ."
Ma i due gentiluomini lo guardarono con superbo disdegno, e spronati i cavalli per raggiungere la carrozza che si era fermata e dal cui sportello si sporgeva una graziosa testa di donna, gli dissero, passando: "Ti manderemo gente degna di te."
Il giovane li seguì con l'occhio, sorridendo ironicamente, e calcatosi con un pugno il cappello sulla fronte, riprese la strada, dicendo fra sè giocondamente: "Per bacco! pare che questi gentiluomini abbiano spada di legno inargentato... Intanto, Blasco mio, eccoti una prima avventura alle porte della capitale: "prima sedes, corona regis et regni caput", come diceva padre don Giovanni mio maestro... Povero padre don Giovanni!... dove sarà ora?".
Spronò il ronzinante, mentre si frugava in tasca, come per rassicurarsi che qualche cosa c'era ancora.
"C'è, - disse fra sè; - questo è l'unico filo per rintracciare la mia famiglia... Vediamo, dunque: scenderò alla locanda del Messinese, vicino al teatro dei Musici. Dove sarà il teatro dei Musici? Poi andrò a S. Francesco dei Chiovari a cercare padre Bonaventura, e gli darò la lettera... se padre Bonaventura sarà ancora vivo! Contiamo: sono passati... sei... dieci... quindici anni!... quindici anni!... Non pare vero! e ne abbiamo fatte, o meglio, ce ne hanno fatto fare pazzie; ora, Blasco, è tempo di mettere giudizio".
Entrò da Porta Nuova, dove i gabellieri vollero frugare nel sacchetto, se mai vi fosse qualcosa da far pagare. Che diamine poteva nascondere in quel sacchetto, nel quale c'era appena una camicia, un farsetto, due paia di calze e un fazzoletto finissimo ornato di magnifico pizzo? Toh! e non ci poteva essere del tabacco? Lasciò fare, sbuffando: pareva che i gabellieri lo menassero in giro. Egli si sentiva pizzicare le mani, e forse i suoi occhi dovettero illuminarsi di una luce tanto sinistra, che i gabellieri lo lasciarono andare.
Percorse il Cassaro, sorpreso alla vista dei palazzi, del Duomo, dei grandi e magnifici edifici che fiancheggiavano la nobile strada: ma giunto ai Quattro Canti si fermò irresoluto, non sapendo da che parte piegare.
Quei quattro prospetti, uguali di grandezza, di architettura, ornati di vasche, di statue, di emblemi, oltre ad empirlo di stupore, lo imbarazzarono. Domandò la strada, e così guidato un po' dalle indicazioni, un po' dalla sua stessa iniziativa, giunse finalmente alla locanda del Messinese, che si trovava in una piazzetta, che ancora conserva il nome con una lieve mutazione del genere, in una stradetta contigua al teatro dei Musici o di Santa Cecilia.
Una piccola insegna, simile a una bandiera, su cui era dipinta una bottiglia con due bicchieri in bianco e rosso, gli indicò la porta che anche senza quella insegna, forse, sarebbe stata ugualmente riconoscibile da due banchi posti di qua e di là della strada, e dall'aspetto dell'oste, grasso, lucido, con un grembiule dinanzi, nel quale si asciugava le mani tozze e pelose.
Lo scalpitare del cavallo sui ciottoli aveva forse richiamato la sua attenzione, ma l'aspetto del cavallo e del cavaliere non gli parvero tali da meritarsi più che un saluto di convenienza.
Il giovane non gli badò. Era di buon umore e aveva fame; due cose che non danno modo di accorgersi delle sgarberie altrui.
Gettando le redini al mozzo della stalla, gli gridò: "Bada, figliuolo, che questo è un cavallo di gran pregio: te lo raccomando, non mi rubare sull'avena..."
L'oste e il mozzo guardarono la rozza con aria beffarda, ma il giovane aggiunse con grande serietà: "lo stesso cavallo che cavalcò il conte Ruggero quando tolse Palermo ai Saraceni."
Alcuni minuti dopo, seduto a una tavola della taverna, mentre rosicchiava una costoletta di maiale si faceva istruire dall'oste sulla strada da percorrere per andare a S. Francesco, e se a quell'ora avrebbe trovato padre Bonaventura.
Il convento era a due o tre minuti di distanza.
Blasco da Castiglione, ormai rifocillato, si affrettò a recarvisi; tanto gli serviva per sgranchire le gambe. Uscì dalla taverna, rumorosamente, salutando con uno scappellotto il mozzo, dinanzi la porta, e accompagnato da una osservazione dell'oste: "Ha da essere un bel matto!".