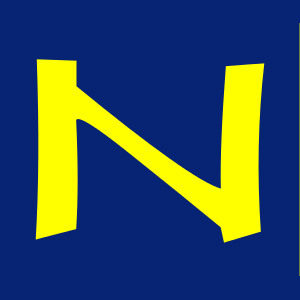Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 6
| Italiano | English |
Il duca della Motta, membro della Deputazione del Regno, principalissimo istituto al quale spettava l'esecuzione delle leggi e la difesa dei capitoli o statuti della monarchia, stava nel suo ampio studio, seduto in un seggiolone a bracciuoli, tappezzato di cuoio verde a fiorami d'oro, dinanzi a una grande scrivania i cui quattro piedi, tra un complicato accartocciarsi di fogliame rappresentavano dei grifoni da le zampe leonine. Fasci di carte, quali chiuse in custodie di cartone foderato di pergamena, quali legati con nastrini verdi, stavano ammonticchiati di qua e di là, lasciando appena libero lo spazio a un vassoio, sul quale troneggiava un calamaio di bronzo. Altre carte, un po' più ordinatamente, giacevano sopra un altro tavolino, posto presso il finestrone. Intorno alle pareti si levavano grandi scaffali di legno intagliato, pieni di libri grandi e piccoli rilegati in pergamena o in cuoio, quali col titolo scritto per il lungo in caratteri neri gotici, quali in caratteri d'oro. Sopra gli scaffali qualche mezzobusto, riproduzione di antichi marmi, qualche globo ingiallito; e sull'alto delle pareti, vecchie tele annerite, nelle quali lampeggiava qualche tono chiaro di carni color avorio, o di lini bianchi. Il colore del legno e delle tappezzerie, la severità degli intagli, la luce velata e il silenzio, davano alla sala un senso di austero raccoglimento, come in un tempio. Vi era come l'odore delle alte cose dell'intelligenza; quel non so che di indefinibile che soggioga lo spirito e lo invita a pensare, e gli infonde la febbrile curiosità di sapere.
Don Raimondo Albamonte, duca della Motta, aveva riputazione di dottrina giuridica, e pareva l'erede di quella grande tradizione di giuristi siciliani che risplendeva dei nomi di Giovanni Naso, del Viperano, di Luca Barbieri, di Vincenzo Percolla, del Corsetto, del Muta e del Cutelli raccoglitori e commentatori del diritto patrio. Chiamato volta per volta a coprire gli alti uffici della magistratura, era stato presidente della Gran Corte Civile e di quella Criminale, e ora, da due anni, assunto alla Deputazione del Regno, per la protezione del vicerè don Carlo Antonio Filippo Spinola e Colonna, marchese de Los Balbases, al quale era stato di grande aiuto nei processi per i torbidi del 1708.
Nei quindici anni trascorsi, il suo volto si era fatto più severo, più pallido, gli occhi tenebrosi. La pratica dei processi criminali e delle torture aveva accentuato maggiormente la durezza della sua mascella, e immobilizzato la maschera fredda del suo volto impassibile. La rigidità delle sue maniere, la inflessibilità del suo volere, nei rapporti di ufficio, verso gli uguali e gli inferiori, gli avevano acquistato una riputazione di integrità, della quale egli si gloriava; pronto per altro a deporla nel gabinetto del Vicerè, e, senza parere, a tramutarsi in strumento della volontà regia.
Divenuto duca, per mancanza di eredi diretti del fu suo fratello, e raccolta nelle sue mani una ingente eredità, l'aveva accresciuta con due ricchi matrimoni, ! mettendo a profitto anche la sua carica, in quanto gli dava modo di gettare le mani sopra qualche patrimonio contestato o di acquistare per poco beni confiscati. Ma sapeva, anche in questi casi, serbare la sua apparenza austera, e nessuno dubitava della sua riputazione, alla quale egli teneva.
Alla vigilia dei grandi avvenimenti che si sarebbero svolti nel regno, egli teneva a conservare quella considerazione, mirando a ben più alto posto. Infatti con tutte le forze, tutti i raggiri della sua ambizione, brigava per essere nominato presidente del real Patrimonio.
Aveva contratto il primo matrimonio, appena riconosciuto il diritto alla investitura dei feudi, con una Branciforti; ma tre anni dopo la duchessa morì, lasciandogli una figliuola di due anni. Don Raimondo rimase vedovo sei anni, in capo ai quali riprese moglie: una La Grua, nobilissima e ricchissima, che però era di ventidue anni circa più giovane di lui. Questo secondo matrimonio, del quale il capriccio e l'interesse erano stati gli autori era rimasto infecondo.
In quei giorni, per ragione del suo ufficio, aveva un gran lavoro: la Deputazione del Regno infatti doveva mettere il palazzo reale in condizione di potere degnamente ricevere il nuovo re di Sicilia, Vittorio Amedeo, duca di Savoia. Dopo quattro secoli, era la prima volta che l'antica reggia normanna schiudeva le sue stanze a un re e non si trovava in condizioni tali da poterlo accogliere con decoro. Molte stanze erano cadute quasi in rovina, le tappezzerie a brandelli, le pitture rose dall'umido, i mobili guasti dalla vecchiaia.
Sebbene il Senato avesse avocato a sè l'arredamento degli appartamenti reali, nondimeno il compito spettante al Patrimonio non era indifferente; e, poichè si dava come imminente o come già avvenuta la partenza per mare di Vittorio Amedeo da Villafranca (presso Nizza) per la Sicilia, il lavoro ferveva; e don Raimondo, che naturalmente voleva ingraziarsi il nuovo re, vi si era dedicato con energia giovanile.
Del resto un certo entusiasmo era in tutti gli spiriti. L'indipendenza del regno, per quanto assicurata da Statuti, cui tutti i monarchi si erano chinati e avevano giurato osservanza, non si poteva dire compiuta fino a che esso non avesse avuto re propri e questo desiderio aveva avuto già i suoi martiri. Il sogno di tanti secoli e di tanti petti generosi, dunque, stava per avverarsi, e ciò bastava per infondere in tutti i cuori le speranze di una rinascita della gloriosa monarchia di Sicilia.
Il regno di Sicilia era stato concesso a Vittorio Amedeo di Savoia per l'atto del trattato d'Utrecht. È noto che la successione di Filippo di Borbone, nipote di Luigi XIV, al trono di Spagna, per la morte di Carlo II, non era stata accolta favorevolmente dalle Potenze, che in questo fatto vedevano un accrescimento della potenza della Francia, o meglio della sua monarchia, e quindi una più sicura e temibile egemonia. Ne era quindi scoppiata una guerra, che si disse di successione. La Austria, collegatasi con l'Olanda e con l'Inghilterra, mosse contro Luigi XIV; Vittorio Amedeo parteggiò per la Lega, e il Piemonte diventò il teatro principale di una guerra lunga e sanguinosa che non riuscì favorevole alle armi francesi. La pace di Utrecht, ponendo fine alle stragi e alle competizioni, accomodava l'Europa a soddisfazione delle brame dinastiche. Riconobbe la Spagna a Filippo V; diede la Lombardia, Napoli e la Sardegna all'imperatore di Austria, e la Sicilia con la corona regale a Vittorio Amedeo. La dinastia dei Borboni guadagnava un trono, ma la monarchia spagnola perdeva il dominio di mezza Italia, a beneficio della dinastia d'Asburgo.
Anche la Sicilia aveva sofferto per le vicende della guerra. A custodia dell'isola, Filippo V aveva mandato un corpo di spagnoli, francesi e irlandesi, affamati, malvestiti, predoni più che soldati: n'erano seguite sommosse, cospirazioni, supplizi. Il regno, afflitto dalle carestie, agitato, senza certezza, diviso tra i partigiani dell'antica dinastia e quelli della nuova, commosso dai sognatori di una restaurata indipendenza da ogni soggezione straniera, in quegli ultimi anni era stato sconvolto da un interdetto provocato dal vescovo di Lipari; e l'interdetto aveva armato la potestà civile contro il clero partigiano della Curia, e gettato le popolazioni in un grande sgomento religioso.
Si capisce che, in queste condizioni, la restaurazione del regno di Sicilia con un re proprio, illudendo i regnicoli che il nuovo re avrebbe naturalmente trasportato la sede nel dominio di maggiore dignità, appariva come la fine di uno stato penoso, il risorgimento del regno, l'inizio di una nuova era, la tranquillità delle anime, la ricchezza e la gloria.
A nessuno, nel rifiorire di tante speranze, passava per la testa che Vittorio Amedeo, dello Stato che gli poneva sul capo la corona regale, avrebbe fatto una provincia di un ducato.
Don Raimondo Albamonte, duca della Motta, era dunque in quei giorni grandemente affaticato, ma quella mattina aveva altre ragioni per impensierirsi: sulla sua scrivania aveva trovato una lettera stranissima della quale nessuno seppe dire la provenienza, nè chi l'avesse portata.
La lettera non conteneva che alcuni brevi versetti:
"Quid detur tibi, aut guid apponatur tibi ad linguam dolosam?
Sagittae potentis acutae; cum carbonibus desolatoriis
Custodiens parvulus Dominus
Dominus solvit compeditos
Dominus pupillum suscipiet, et vias peccatorum disperdet.
Ricordati di Emanuele."
La lettura di questo nome gli aveva dato la chiave per spiegarsi le allusioni di quei versetti staccati dai salmi e messi insieme; ma gli aveva nel tempo stesso fatto correre un brivido nel sangue. Già da qualche tempo, ogni tanto, gli giungeva una lettera misteriosa, con una frase, un motto, una minaccia: naturalmente le attribuiva allo spirito di vendetta di coloro che dalle sue sentenze venivano colpiti, e non ne faceva caso; ma quel nome lanciato ora, come una bomba, gli spiegava l'occulta e persistente persecuzione, e lo sgomentava. C'era qualcuno che possedeva il suo segreto? Pensò ad Andrea. Ma Andrea era stato condannato al remo, per trent'anni e si trovava sulle galere.. E poi, che sapeva Andrea? Bisognava indagare e andare fino in fondo, per scoprire la origine, la provenienza di quelle lettere anonime: e non c'era che un uomo capace di tanto, un algozino astuto e audace, del quale la giustizia si avvaleva in tutte le occasioni più ardue. Si chiamava Matteo Lo Vecchio.
Don Raimondo aveva mandato a chiamarlo, e lo stava aspettando nel suo studio, quando gli venne annunziata la visita del padre Bonaventura da Licodia.
La visita di un frate, specialmente in una casa signorile, non era un avvenimento insolito; nè esponeva il visitatore alle insolenze della servitù. Indossare un saio e avere i lombi cinti d'un cordiglio, era un lasciapassare che induceva a rispetto e a riverenza anche i padroni, per i quali, del resto, mostrarsi devoti e stretti alla Chiesa era una moda.
Padre Bonaventura fu dunque fatto passare ed accolto da don Raimondo con un premuroso: "Venga, venga, padre..."
Gli indicò un seggiolone presso il tavolino, e gli domandò con piacere: "A che debbo la fortuna della sua visita?"
"Vengo" rispose il frate "a implorare la protezione di vostra Eccellenza per un giovane, sapendo di non poterlo affidare a signore più generoso, più benigno e potente di vostra Eccellenza."
Don Raimondo s'inchinò, mormorando: "Ella esagera quel poco merito, che, per grazia di Dio, potrò avere..."
"Il nostro convento conosce per prova la liberalità e la pietà dell'Eccellenza vostra..."
"E codesto giovane?... È un novizio?"
"Tutt'altro, Eccellenza; credo anzi che sia più adatto per comandare una compagnia di soldati, che per recitare i salmi; forse vostra Eccellenza avrà sentito qualche cosa...
Fu un gesto che suscitò un po' di rumore... Sa, quel giovane regnicolo che bastonò il caporale e le guardie del capitano di città alla locanda del Messinese..."
"Ah! difatti, ho sentito qualche cosa... mi pare che abbia osato offendere il principino di Iraci e il marchesino di Santa Croce?..."
"Così parrebbe alle apparenze... ma la gioventù... e una gioventù bollente, Eccellenza, merita qualche compatimento."
"È un nobile il suo giovane?"
"È... è figlio naturale di un gran signore..."
"Ed è vivo il padre?"
"Eccellenza no: il giovane è solo; io lo raccolsi dalle braccia della madre, uccisa dal terremoto di Catania..."
Don Raimondo stette un po' e disse: "Suppongo che sia stato arrestato, e che lei viene a intercedere per lui."
"Eccellenza no. Da questo lato il giovane non corre alcun pericolo: l'illustrissimo signor capitano di città, per bontà sua, si degnò accogliere la mia preghiera..."
"E allora?"
"Ecco, io sono venuto a pregare vostra Eccellenza di metterlo sotto la sua protezione, per ottenergli un impiego degno del suo rango... Se egli avesse avuto inclinazione alla vita claustrale, non verrei a disturbare vostra Eccellenza: sebbene so per prova che quando si tratta di far del bene, vostra Eccellenza è lieto, e le si fa piacere... Se me lo permette, io glielo presenterò..."
"Ma quando vorrà, padre; lo conduca, vedremo quel che si potrà fare di lui..."
Padre Bonaventura si alzò, inchinandosi e ringraziando.
"Vostra Eccellenza farà un'opera di carità maggiore di quella che crederà, e Dio gliene terrà conto..."
"A proposito, se non è un segreto di confessione, di chi è figlio?"
Il frate fu sul punto di dire, ma si trattenne: "Vostra Eccellenza mi perdoni..."
"Non importa, non importa lei mi assicura che il padre era un" signore..."
"Di nobiltà, oserei dire, pari a quella degli Albamonte..."
"Tanto meglio, e la madre?.
"Non era nobile. Piccoli gabelloti."
"Ah! ah! ho capito; qualche avventura... capricci..."
"Dio li perdoni" mormorò il frate.
"Dunque siamo intesi, me lo conduca... Sono curioso di cotesto giovane, che ha avuto il coraggio di attaccare briga con due "titoli" dei primi del regno, e di mettere in fuga cinque uomini del capitano di città..."
"Quando vostra Eccellenza vuole che glielo presenti?"
"Domani... sì, domani a questa ora."
Congedò con un gesto il frate e l'accompagnò fin sulla soglia. dove gli baciò la mano.
Il servo che stava in anticamera, dietro la porta, gli disse: "Eccellenza, c'è di là Matteo Lo Vecchio..."
"Ah!" esclamò don Raimondo richiamato alle sue preoccupazioni "fallo entrare."
Un minuto dopo il birro entrava nello studio inchinandosi umilmente. Era un uomo sulla trentina, magro, ossuto, nero, con un volto volpino e due occhi di gatto; una espressione di astuzia e di ferocia, di simulazione e di cinismo, di doppiezza e di avidità. I suoi movimenti avevano l'elasticità dei felini, ma le mani lunghe, scarne, sembravano artigli di rapace.
Entrando, gettò uno sguardo rapido, di sbieco, intorno a sè come per spiare.
"Avvicinatevi:" gli disse don Raimondo "so che siete abilissimo a scoprire i delitti più segreti..."
"Un po' d'esperienza..."
"E che vi basta la più lieve traccia per dipanare le matasse più arruffate. Lo so anche per prova. Orbene, voi avrete un grosso premio e la mia protezione, se giungerete a scoprire l'autore di certe lettere che da qualche tempo mi pervengono misteriosamente."
"Se vostra Eccellenza mi dà una di coteste lettere..."
Il duca stette un po' soprappensiero; poi aperse un tiretto del suo tavolino e ne cavò una lettera.
"Eccovene una."
L'algozino vi gettò gli occhi sopra, senza neppure aprirla, e disse con sicurezza: "So donde viene..."
"Sì?"
"Conosco la carta e i segni..."
"Quali segni?"
"Guardi."
Gli mostrò sulla cera del sigillo una piccola croce attraversata diagonalmente da due rozze spade.
"Ebbene?" domandò il duca.
"Questa lettera la mandano i Beati Paoli."
"I Beati Paoli?"
"Eccellenza, sì. Mutano sempre il sigillo: ma io li riconosco."
Don Raimondo si chiuse in un momento di silenzio; infine domandò: "Credete voi dunque che veramente esistano i Beati Paoli?"
"Come no!..."
"E dove sono?"
"Questo lo sa Dio: sono dappertutto, invisibili, introvabili, e sempre presenti. Quando meno si pensa, li abbiamo ai fianchi, alle spalle, in chiesa, per la strada, forse anche in casa; e non ce ne accorgiamo... Nessuno può guardarsene..."
"Diamine! voi ne fate una pittura terribile!" osservò don Raimondo con una punta di lieve ironia, che serviva a celare il senso di paura dal quale era invaso anche lui.
"Avete paura?"
Il birro levò il capo, sorridendo, con gli occhi feroci.
"Paura io? Dico per mostrarle le difficoltà dell'impresa."
"Avrete un premio di quaranta scudi, se scoprirete l'autore di queste lettere."
Gli occhi di Matteo Lo Vecchio brillarono di cupidigia; si inchinò e disse: "Farò il possibile, Eccellenza, per meritarmeli, e per meritarmi la sua protezione: ma intanto bisognerebbe stare in guardia..."
"Cioè?"
"Gli avvertimenti dei Beati Paoli sono seguiti sempre da qualche colpo. È prudente che vostra Eccellenza non esca mai senza essere accompagnato da persone di sua fiducia e di cuore. Si sa bene, che quando si è amministrata giustizia, si è seminato odio. A nessuno piace essere condannato, anche se colpevole."
"Quando mi darete qualche notizia?"
"Fra tre giorni. Vostra Eccellenza vorrebbe darmi una di coteste lettere?"
Don Raimondo esitò un secondo e gliela diede.
"Eccola: l'affido a voi."
L'algozino si pose una mano sul petto, in atto di giurare; poi prese la lettera, la piegò e se la pose in un taschino interno della sottoveste.
Il duca gli pose nelle mani alcune monete d'argento.
"Se vi occorre qualche spesuccia" disse.
Quando il birro fu uscito, don Raimondo restò soprappensiero. Non aveva mai pensato a quella misteriosa società, della quale si parlava con terrore e rispetto, e i cui decreti erano eseguiti con una sicurezza infallibile da mani che nessuno vedeva. I Beati Paoli? Come mai essi possedevano il suo segreto? Che cosa significava quella minacciosa sentenza Donzinus suscipiet pupillum, se non una allusione al piccolo Emanuele? Da quale ombra egli usciva improvvisamente? Era vivo? Gli pareva impossibile: per quattro o cinque anni egli aveva fatto ricercare donna Aloisia e il piccolo, tormentato da una paura segreta, tremando dentro di sè al pensiero di vedere improvvisamente balzare dall'ignoto la voce accusatrice della cognata. Ma ogni ricerca era riuscita vana. Il dubbio che Andrea avesse posto al sicuro la duchessa o il figlio era svanito: Andrea arrestato, processato, torturato, condannato come presunto rapitore, pareva veramente ignaro della sorte toccata ai suoi padroni; e se don Raimondo lo volle gettato sulle galere, fu per allontanare da Palermo una voce che poteva forse accusarlo, pensando che in galera una sapiente coltellata poteva sbarazzarlo da un nemico implacabile. Andrea non poteva dunque essere lo autore di quelle lettere; ne era l'ispiratore? Ecco una traccia. Si dolse che non gli fosse apparsa prima, per indicarla a Matteo Lo Vecchio, ma poi pensò che era meglio lasciare libertà d'iniziativa al birro, anche per vedere se egli sarebbe pervenuto con le sue indagini allo stesso punto.
Intanto l'avvertimento dell'algozino lo sgomentava. Chi lo avrebbe difeso?
Involontariamente pensò al giovane raccomandatogli da padre Bonaventura. Era, come sembrava, un uomo audace, del cui braccio poteva fidarsi; ma l'animo? Era necessario legarlo a sè con una forte riconoscenza.
"Vediamo disse; - se gli fa cessi rintracciare la parentela e gli facessi acquistare il diritto di portare il nome di suo padre?".
E la mente dell'uomo di legge fissò lo sguardo nella selva intricata del diritto.