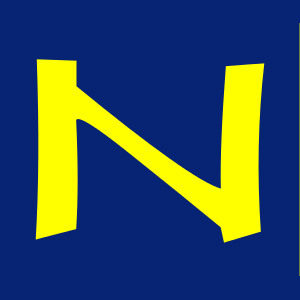Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 7
| Italiano | English |
Quella stessa mattina, all'ora stessa in cui padre Bonaventura andava dal duca della Motta, il pittore don Vincenzo Bongiovanni se ne stava nel suo studio, appollaiato al sommo di una scaletta di legno portatile, dinanzi a un'ampia tela segnata a carbone, sulla quale stendeva larghe pennellate azzurre, che, a giudicare da un bozzetto infisso sopra un'asse accanto alla tela, e che rappresentava il soggetto della grandissima tela, dovevano diventare un cielo qua e là sereno, offuscato altrove da folte nubi salienti dalla terra.
Sotto la scaletta, una graziosa fanciulla, col capo coperto di uno strano berrettino, attendeva a stemperare dei colori, dentro vasetti, con la sicurezza di chi vi ha lunga abitudine.
Lo studio era vasto, un po' disordinato, come tutti gli studi dei pittori, con le pareti piene di disegni, di schizzi, di bozzetti, quali dipinti, quali a sanguigna, quali segnati col carbone a grossi tratti, che talvolta si sovrapponevano, s'intersecavano, si confondevano. Attaccati a chiodi, ritti su mensole, biancheggiavano sul fondo grigio delle pareti gessi grandi e piccoli; calchi e riproduzioni di teste e di statue antiche e del Rinascimento; e qua e là armi e pezzi di stoffe e tavolozze imbrattate di colori, uno specchio dalla cornice dorata sopra una mensola dai piedi curvi a grandi volute.
Un tavolo pareva gemesse sotto il peso di cartelle, disegni e stampe; e altre cartelle sopra seggioloni e sgabelli e per terra. In un angolo, il più discreto di ombre e di raccoglimento, ardeva dinanzi a una immagine sacra una lampadina ad olio. Sotto la grande finestra, donde entrava la luce temperata, su uno di quei canapè impagliati, dalla spalliera dipinta, stava seduto un uomo maturo, asciutto di membra, con gli occhi vivacissimi, che tenendo sul ventre una chitarra vi lasciava sbadatamente, or sì or no, scorrere leggermente il pollice traendone delle vibrazioni dolci e quasi sospirose come gemiti: e un altro più vecchietto annusava tabacco, voluttuosamente, socchiudendo gli occhi.
Erano anch'essi due artisti noti, anzi celebri a Palermo, il primo dei quali, quello che pizzicava la chitarra, doveva salire, qualche secolo dopo, ai fastigi della gloria; si chiamava mastro Giacomo Serpotta, e aveva in quel tempo giocondato più chiese e cappelle dei suoi meravigliosi e insuperabili putti; l'altro era don Antonio Grano, pittore come il Bongiovanni.
"Oggi come oggi" diceva annusando "non ho proprio voglia di tirare una linea. Fa troppo caldo. Me ne andrei a Maredolce o allo scoglio di Mustazzola..."
"A pigliarvi un po' di frescura per l'estate che verrà..."
"Tutt'altro. San Martino quest'anno ha gettato addirittura il mantello..! nel mio studio fa troppo caldo."
Successe un momento di silenzio. Giacomo Serpotta accennò un arpeggio, poi disse al Grano: "E il vostro quadrone a che punto è?"
"Va innanzi. Fra quindici, mettiamo anche fra venti giorni, potrò consegnarlo... Non sono contento della testa del duca di Savoia..."
"Dite pure del re nostro signore" corresse non senza una lieve punta di ironia il Bongiovanni.
"Uhm!" fece Grano con incredulità.
"Intanto" disse don Giacomo Serpotta, continuando a toccare le corde "dopo trecent'anni abbiamo un re nostro."
"Lo credete?" ribattè il Grano. "Ho paura invece che il regno, e dico un regno come il nostro, diventerà una provincia del ducato di Savoia. Vedrete. Ma intanto la testa del duca non mi riesce; è poco somigliante..."
"Volete il ritratto che mi serve da modello?" gli domandò il Bongiovanni. "A me non fa più bisogno. Ne ho fatto uno studio per il mio quadro, e mi basta. Ve lo manderò. Mi assicurano che sia rassomigliante."
"Grazie... Se è così, vuol dire che manderò a prenderlo." "E sapete se il fiammingo è avanti con la sua tela?"
"No; è ancora dietro a studiare;" disse il Serpotta "questi fiamminghi sono pittori eccellenti, non c'è che dire, e il Borremans è di quelli, ma sono lenti e meticolosi..." "Qual è il soggetto della sua tela?" domandò il Bongiovanni. "Il duca Vittorio che fa voto di innalzare un tempio alla Vergine.."
Nuovamente si fece silenzio nel quale risonarono gli arpeggi dell'insigne scultore. Poi il Grano si alzò e prese commiato. Pareva infastidito. La giovanetta seguitava a sciogliere le tinte nei vasetti, provandone qualcuna sopra un pezzo di carta. Giacomo Serpotta la guardava socchiudendo gli occhi, seguendone le graziose movenze.
"Ma sapete" disse "che voglio modellare la mia statua della Scienza per l'Oratorio di Santa Cita, sulla vostra figliuola?"
La fanciulla si voltò arrossendo e sorridendo. Il grande artista in quei tempi aveva incominciato la decorazione dell'Oratorio di Santa Cita, quel meraviglioso saggio della fantasia e dell'arte sua unica e inimitabile. Giacomo Serpotta non aveva ancora sessant'anni, era nel pieno rigoglio dell'arte, e aveva popolato chiese e oratori di quei suoi putti giocondi e originalissimi, e di quelle sue figure simboliche eleganti e piene di grazia, delle quali egli stesso non conosceva forse l'altissimo valore. Figlio dell'arte - il padre era stato scultore o marmoraro, come si diceva - dopo aver prodotto qualche ardita opera di getto, e fornito disegni ad altri scultori, s'era dedicato alla decorazione con lo stucco, innalzando quest'arte fino allora umile, ad altezza non mai raggiunta, nè prima, nè dopo di lui. Le movenze della fanciulla, graziose e nel tempo stesso composte e non senza una certa nobiltà, gli suggerivano forse qualche motivo per la sua statua.
Pellegra Bongiovanni contava allora quasi quattordici anni e il suo corpo aveva già le dolci curve di una giovinezza promettente. Il capo, ricco di capelli castani, avvolto in una specie di cuffia o berretto, si inchinava un po' sull'omero destro, sopra il collo svelto e di classico disegno. Aveva gli occhi vivacissimi, nei quali le si leggeva la prontezza e la versatilità dell'ingegno, che molti anni dopo l'avrebbe resa celebre e corteggiata in Roma. A quattordici anni dipingeva: non era ancora in grado di far da sè, ma aiutava il padre, che era fra l'altro un mediocre pittore. Lei gli vestiva le figure.
"Dal momento che è donna" diceva, scherzosamente, don Vincenzo Bongiovanni "quello di fare vesti è affare suo."
Ma Pellegra aveva altre attitudini che il buon padre le aveva coltivato, e continuava a coltivarle. Aveva una grande inclinazione per la musica, e aveva composto già qualche madrigale a più voci: e gustava i poeti, specialmente il Petrarca; ragione per cui don Vincenzo le faceva impartire lezioni da un padre teatino, che l'aveva, secondo l'uso, addestrata nelle lettere latine; sicchè Pellegra poteva già tradurre all'impronta Virgilio. Pellegra era dunque una fanciulla abbastanza colta; oggi si direbbe intellettuale. Il suo spirito si esprimeva nelle tre arti che le diventavano familiari: la pittura, la poesia e la musica, e con una facilità e una sicurezza che la rendevano cara e apprezzata e che, in quell'ambiente di artisti, non troppo colti in verità, mettevano talvolta soggezione. Don Vincenzo, quando insorgeva qualche discussione di storia o di letteratura (gli artisti amano qualche volta discutere di ciò che non sanno), troncava la questione richiedendo la sentenza della "Sibilla".
"Sentiamo che cosa dice Pellegra."
Giacomo Serpotta, questo umile figlio dell'arte, e pur così alto intenditore dell'eleganza e della grazia femminile, aveva una speciale predilezione per la fanciulla, che aveva, si può dire, visto nascere. Adesso, nel vederla così seria e così intenta, e forse pensosa, aveva repentinamente veduto in lei la forma di un suo oscuro concetto, e se ne era dilettato.
"Come mai" disse il Bongiovanni, senza staccare gli occhi dalla tela "come mai non v'hanno affidato la direzione degli apparati? È una cosa che ancora non mi persuade, un arco di trionfo!..." Giacomo Serpotta alzò le spalle con noncuranza.
"Ci sono tanti scultori e architetti;" disse "volete che pensino a uno stuccatore?"
Allora Pellegra si voltò vivamente, e, venendo dinanzi al grande artista, esclamò: "E dove lo trovano in tutta la Sicilia uno scultore che vi stia alla pari?"
Giacomo sorrise.
"Oh! c'è il Vitagliano..."
"Ah! sì, il Vitagliano, che si fa dare da voi i disegni delle sue statue... e qualche volta anche i modelli!... ah! ah!..."
"Ma no, ma no!" esclamò Giacomo Serpotta.
Il discorso cadde sugli archi di trionfo che per commissione del Senato e delle varie corporazioni e "nazioni", si dovevano costruire e decorare per l'entrata ufficiale di Vittorio Amedeo II, che sarebbe avvenuta negli ultimi dell'anno.
Si sapeva che il duca di Savoia era partito dai suoi Stati e veleggiava per la Sicilia, dove sarebbe arrivato in quei giorni per prendere possesso del regno, dove si andavano facendo i preparativi per la decorazione. La deputazione del regno, il Senato, le corporazioni, le "nazione" - come si chiamavano allora le colonie di paesi d'oltreregno - si erano dunque poste all'opera, perché le feste per la coronazione del re fossero quanto mai magnifiche e solenni.
Dalla venuta di Carlo V, nel 1535, fino allora nessuno dei re che si erano succeduti aveva mai posto piede nell'isola; nessuno era stato coronato nell'antico e nobile duomo, con la corona di Ruggero e Federico II: il regno si era sentito quasi mortificato dalla trascuratezza dei suoi monarchi lontani, ai quali pur mandava larghi e generosi donativi.
Ecco invece che Vittorio Amedeo rinnovava gli antichi fasti. Egli veniva a farsi coronare dal metropolitano di Palermo, nell'antica sede della monarchia più gloriosa d'Italia; veniva a ridare lustro all'antica reggia dove Federico II aveva accolto il fiore di ogni gentilezza e donde aveva quasi imposto la sua volontà all'Europa. Ce n'era abbastanza per destare palpiti e speranze in tutti, ed eccitare l'orgoglio cittadino dell'antica capitale.
Tutta Palermo era in festa! Tutta Palermo si apparecchiava.
Un geniale e gentile pensiero aveva spiritualizzato un atto di cortigianeria; il Senato infatti aveva pensato di ornare il duomo per la cerimonia dell'incoronazione con una serie di grandi quadri d'occasione, a tempera, rappresentanti i fasti della vita e del regno di Vittorio Amedeo, affidandoli ai pittori più noti che allora fossero a Palermo. Il Bongiovanni, il fiammingo Borremans, don Antonio Grano erano fra questi.
Il discorso cadde sugli avvenimenti politici di quegli anni. Ricordavano la lunga serie di supplizi seguiti dopo il 1708: frate Ignazio Vulture che sognava la repubblica, don Prospero Fialdi, che voleva cacciati via Francesi e Irlandesi; don Antonino Guerrieri, giudice del Concistoro, perché aveva dato ricetto a un presunto ribelle, l'eremita di S. Matteo che parteggiava, nelle sue prediche, per gl'imperiali, e il pittore Ganguzzo coi figli e col suo'cero, gente valorosa, macchinatori di congiure, e mastro Agatino Quaranta, console dei "chiavettieri", ed altri ed altri: quali impiccati, quali decapitati e i cadaveri esposti a ludibrio, con cartelli infamanti. Erano le ultime vittime che il moribondo dominio spagnolo sacrificava a se stesso.
I due artisti parlavano a scatti augurandosi un periodo di pace, contro le scettiche previsioni di don Antonio Grano. Ma in questo punto fu bussato alla porta. Pellegra andò ad aprire.
"Si può vedere il maestro?"
"Entrate, entrate" rispose Pellegra che aveva riconosciuto il visitatore.
Un uomo maturo entrò, seguito da un giovanotto.
"Buon dì, maestro; vi ho condotto quel mio nipote di cui v'ho parlato..."
"Oh, bravo!" disse il Bongiovanni dall'alto del suo trono di legno dando un'occhiata di soddisfazione al giovanotto.