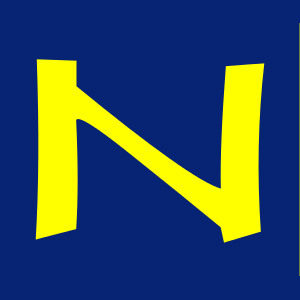Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 17
| Italiano | English |
Fin dall'alba del 21 dicembre, la città era in festa: il rullio dei tamburi e il miagolio dei pifferi delle guardie del corpo, del reggimento svizzero e dei dragoni piemontesi, che si recavano fuori Porta Felice, per schierarsi sulla spiaggia e fare guardia di onore alla porta e al padiglione reale eretto a Sant' Erasmo, avevano destato i cittadini, che del resto, e per l'avidità dello spettacolo nuovo e solenne, e per l'esultanza nazionale, e per i preparativi della festa, alla cui magnificenza ognuno concorreva come poteva, avevano quella notte dormito poco.
Fiumane di popolo scendevano dai vicoli e dalle strade che sboccavano sul Cassaro, si spandevano per l'antica e nobile strada, arteria dalla quale si diffondeva la vita pubblica in tutta la città. Chi aveva conoscenze, saliva in qualche casa; il popolo minuto, però, si impadroniva della via lunga e diritta: occupava le gradinate delle chiese, i banchi sporgenti delle botteghe, il vano dei portici dei quali ancora rimaneva qualche vestigio. I più previggenti s'erano provveduti di banchi e di sedie, e vi si tenevano su diritti, aspettando il corteo dietro le file dei soldati che si erano schierati di qua e di là della strada. Per tutta la lunghezza del Cassaro ondeggiava quel rumore indistinto e confuso di migliaia di passi e di migliaia di voci, simile allo sciabordio della marea, che ora saliva, ora s'ammorzava, per riprendersi poco dopo con un improvviso scoppio, come sospinta da un soffio di vento. A un tratto una notizia partiva da un punto del Cassaro, si propagava via via per la lunghezza della strada: tutte le teste mareggiavano, si voltavano, si agitavano.
Passava la cavalcata della nobiltà, con alla testa i due primi titoli del regno, il principe di Butera e il principe di Trabia; le magistrature, il Senato nella sua magnifica carrozza, grande, tutta oro e seta, circondata dalla solita pompa di araldi, mazzieri, musici, conestabili, nei colori della città, rosso e giallo, i prelati; e ogni gruppo, ogni corteo, sebbene consueto e visto, destava sempre la stessa curiosità, la stessa ammirazione.
Per quanto era lungo, il Cassaro aveva un aspetto magnifico, quale mai si era veduto. La lunga linea interrotta dagli archi trionfali, lo divideva in ampie gallerie, che sfolgoravano di colori e di luce. Dai balconi, dalle finestre pendevano tappeti e arazzi; festoni di fronde congiungevano e ornavano gli sbocchi dei vicoli; tutta una festa di colori rivestiva i prospetti delle case, ravvivati dal sole, che quel giorno, quasi per partecipare alla gioia comune, spandeva sul terso cielo la gloria dei suoi raggi.
Verso mezzogiorno corse per tutte le bocche una parola: "Vengono, vengono!"
Quasi nel tempo stesso dal Castellamare tuonarono le artiglierie, e subito dopo dai baluardi, dai vascelli, altre salve empirono l'aria di rombi. Squillarono le campane di S. Nicolò dei Greci.
Vittorio Amedeo fin dalle 17 ore di Italia, con la regina, col principe Tommaso, coi soli gentiluomini di camera e le dame di Corte, in forma privata, per le strade esterne si era recato nel padiglione a S. Erasmo, dove in tutta la pompa regale aveva preso posto sul soglio. Allora il gran ciambellano introdusse don Nicolò Placido Branciforti, principe di Butera, primo titolo e grande di Spagna, che in ginocchio manifestò il giubilo del regno per un principe così valoroso e saggio, che la Provvidenza divina aveva dato alla Sicilia.
Il re ascoltò con compiacimento, indi alzatosi e tolto dalle mani del grande scudiero lo stendardo reale, lo diede al principe dicendo: "Principe, a voi, come primo titolo del regno, affido lo stendardo delle mie armi, mostratelo ai miei vassalli, perché tutti sappiano che io sono il re, cui tutti devono servire, ubbidire e amare con tutto il cuore."
Allora tuonarono le artiglierie e cominciò la cavalcata.
Don Vincenzo Bongiovanni era corso anche lui, avido di spettacoli come un fanciullo, e dalla loggia del convento della Catena, a Porta Felice, aspettava con febbrile impazienza l'apparire del corteo. Aveva condotto con sè Pellegra ed Emanuele, che egli considerava come un figliuolo, non immaginando, nella sua fatuità, quale sentimento germogliasse già nel cuore dei due ragazzi. Don Girolamo non era con loro. Aveva raccomandato al nipote di non mescolarsi tra la folla, e di usare prudenza, e si era fatto promettere dal pittore che avrebbe tenuto d'occhio il ragazzo. Egli aveva dato convegno ad alcuni amici, e poi doveva coi governatori dell'Ospedale trovarsi nelle vicinanze del Duomo. I due giovanotti si erano posti all'angolo della loggia, appoggiandosi al parapetto di pietra, massiccio e deforme e stavano così, stretti, col cuore diviso tra la gioia di trovarsi insieme e il piacere di quello spettacolo magnifico e solenne. E bisbigliavano, come due passeri sopra un tetto. Ma la voce di don Vincenzo li fece tacere.
"Eccoli, eccoli! Guardate: sono i dragoni piemontesi."
Infatti i dragoni aprivano il corteo: marciavano in ordine col colonnello Serio alla testa, belli nella loro divisa turchina. Dietro a loro venivano a pie di i valletti del re e della regina, e poi i paggi a cavallo col loro governatore.
"Adesso vengono i nostri."
I nostri erano le magistrature del regno e della città, il marchese di Regalmici, capitano giustiziere della città, coi giudici della corte pretoriano, innanzi a tutti, e indi, la deputazione del regno, col suo mazziere, i suoi ufficiali; i governatori della Tavola, o pubblico banco, la nobiltà, stupenda per ricchezza di vestimenti, per bellezza di cavalli splendore di bardature, magnificenza di staffieri e lacchè; una vera fantasmagoria superba, che per se stessa valeva tutto lo spettacolo, e che faceva apparire povera ed umile la stessa Corte regia. Il confronto gonfiava di gioia e d'orgoglio i cittadini dimentichi che la ricchezza eccessiva di quelle vesti, di quelle bardature, di quelle livree, sulle quali loro e le gemme erano profusi, significava la miseria e la servitù di tutta l'isola.
Seguivano i razionali del patrimonio, i procuratori fiscali della Gran Corte, i quattro segretari del regno, il protonotaro della Camera reginale e poi il capitano della Gran Corte, e poi i prelati parlamentari, cioè che avevano seggio in parlamento come deputati del clero, e accanto a loro il regio Consiglio. La cavalcata non finiva mai. Venivano i mazzieri del Senato palermitano, intorno ai quali si levava un gran tumulto di popolo, come se un improvviso accesso di pazzia prendesse la folla. Gli era che il tesoriere generale del regno, da due sacchi pendenti di qua e di là della sella, gettava sul popolo manciate di tarì d'argento, con l'effigie di Vittorio Amedeo, per la prima volta coniati nella zecca di Palermo. Le mani avide si levavano per cogliere a volo i piccoli dischi rilucenti; i pugni rissosi se li contendevano; sopra la stessa moneta si agitavano in tre, in quattro, urtandosi, percotendosi, vociando; la cavalcata procedeva innanzi, suscitando quel soffio di tempesta e lasciandosene dietro il fremito convulso, domato appena dal clangore delle trombe degli araldi regi, che venivano dopo, precedendo i cavalieri della Corte del re, gentiluomini di bocca e di camera, elemosinieri, maggiordomi, scudieri, guardaroba, il primo ministro: e poi il principe di Butera con lo stendardo regio, il principe Tommaso, e immediatamente i reali.
Il re e la regina cavalcavano sotto un magnifico baldacchino color di fiamma, sorretto dai senatori della città; innanzi a loro tenuto a mano da scudieri e da palafrenieri di corte, procedeva il cavallo offerto dalla città: un superbo cavallo delle scuderie dei Branciforti, riccamente bardato di oro. Il re e la regina montavano cavalli bianchi; alla staffa del re andava don Ottavio Lanza principe di Trabia, al la staffa della regina il principe di Scordia, di casa Branciforti, pretore della città; e dietro a loro il grande scudiero con la spada nuda, i cavalieri d'onore, le cariche della Corte savoiarda, le dame e le damigelle di Corte. Una doppia fila di guardie del corpo e di svizzeri, di qua e di là fiancheggiava tutto questo gruppo che era il principale, e teneva indietro la folla, che batteva le mani, e rispondeva con un urlo formidabile al grido lanciato di quando in quando dal principe di Butera.
"Sicilia! Sicilia per Vittorio Amedeo!"
Una prima sosta avevano fatto i reali a Porta dei Greci, sotto il primo arco trionfale, dove in processione li aveva incontrati l'arcivescovo col capitolo e col clero della cattedrale. Essi erano scesi da cavallo per baciare la croce che il prelato offriva loro; una seconda sosta era avvenuta a Porta Felice. Ivi il pretore, staccatosi dalla staffa della regina, fatto un segno al sergente maggiore della città, al comandante delle milizie cittadine, che recava un bacino d'argento, prese da questo le chiavi della città e, in ginocchio, le offerse al re, dicendo:
"Signore, con la più grande allegrezza e volontà, Palermo, capo di questo regno, si sottomette a piè della M. V. Per le mie mani consegna alla destra gloriosa di V. M. le chiavi delle sue porte, e nello stesso tempo quelle del cuore fedelissimo di tutti i cittadini, pronti con la vita e col sangue al maggior servizio della vostra real Corona."
Il re prese le chiavi, dicendo che aveva fiducia nei suoi vassalli e nella fedeltà della città di Palermo, e le restituì dopo al pretore, aggiungendo che le serbasse al servizio della real Corona.
Allora tonarono le artiglierie, si alzarono le grida d'acclamazione, dalla strada fino alle finestre più alte; tutta la città parve presa da delirio, e mai, forse, vi fu maggiore fusione di spiriti... Nessuno pensava che non sarebbero passati neppure cinque anni, e i fatti avrebbero disperso auguri e voti e cancellato ogni memoria di quel solenne avvenimento.
La folla si riversò sulla strada, dietro le ultime carrozze del corteo, per seguirlo; si sapeva che ai Quattro Canti i musici del teatro di S. Cecilia avrebbero cantato un dialogo del segretario del Senato don Pietro Vitale, e un altro dialogo avrebbero cantato in piazza Bologna, dai balconi del palazzo del principe di Villafranca.
Don Vincenzo Bongiovanni disse alla figlia: "Andiamo a sentire la cantata."
Il corteo procedeva lentamente. Don Vincenzo uscì dalla Porta della Dogana, costeggiò la Cala per un tratto, e rientrò per Porta Carbone pensando che, per essere quelle strade, in quell'ora e in quell'occasione, quasi deserte, potesse avvantaggiarsi sul corteo. Era una sua tattica consueta, il cui successo però era affidato alle gambe. Egli correva, trascinandosi dietro i due giovani, per i quali per altro quella corsa era un nuovo divertimento. Tenendosi per mano e ridendo, seguivano il pittore, che ogni tanto si voltava per incitarli.
"Animo, via!..."
Percorrendo una linea di strade e vicoli, il cui asse si dilungava parallelamente al Cassaro, egli intendeva giungere al quartiere dei Conciatori, e di lì, per la strada Maqueda raggiungere i Quattro Canti. Ma nonostante la corsa, quando stanchi, trafelati, arrivarono alla meta, il dialogo era cominciato da un pezzo, e stava per terminare.
"Per colpa vostra!" borbottò don Vincenzo. "Andiamo al piano dei Bologna; almeno sentiremo quella. Ma affrettiamoci."
Correndo attraverso le strade parallele, riuscì finalmente sul Cassaro, dinanzi al piano dei Bologna, pieno anch'esso di gente, che si addensava dietro la fila dei soldati. I balconi del palazzo Villafranca erano riccamente addobbati di arazzi e velluti; in quello di mezzo, sotto un baldacchino, era il ritratto del re, ai fianchi del quale erano stati improvvisati due palchetti per i musici. Tutti gli altri balconi erano pieni di dame, invitate dal principe; le loro carrozze circondate di lacchè e volanti aspettavano nel piano dietro la statua dell'imperatore Carlo V, e mettevano tra il grigio dei muri la nota vivace delle dorature e dei pennacchi bianchi e rossi.
Don Vincenzo fendè la calca a furia di gomiti, per giungere sotto i balconi e udire meglio: lo scampanio della vicina chiesa di S. Giuseppe, e lo scoppio degli applausi lo avvisarono che i reali avevano ripreso il cammino; fra qualche minuto sarebbero arrivati nel piano. Con l'occhio sceglieva il posto migliore, trascorrendo fra le carrozze col rischio di cozzare contro i cavalli, rigettato indietro dai lacchè, con la loro consueta insolenza.
Pellegra guardava su nei balconi le dame in superbi abbigliamenti sfolgoranti di gemme: "Guardate, Emanuele," disse al giovanotto "all'angolo del secondo balcone, quella dama vestita di broccato amaranto... Non è la dama ch'era in carrozza, quando arrivò il re? La padrona di quel servo... ricordate?"
"Ah, la duchessa della Motta?"
"Appunto!"
"Non ricordo; non la guardai bene allora... Ci sarà quel cavaliere che voleva farmi paura?... Quello mi piacerebbe vederlo..."
"Non si vede; ci sono troppe dame... Sarà dietro, forse..."
Gli applausi li distrassero. Il re e la regina giungevano sul piano: dai balconi la piccola orchestra, composta di pochi strumenti a corda ed a fiato, come era uso in quei tempi, diede i primi accordi: su tutte le bocche un formidabile sssi, che parve un fiotto, impose il silenzio; il dialogo incominciò con un coro:
"Lire grate, Muse belle,
dei trionfi l'alto grido
dell'Oreto sulla sponda
oggi fate risuonar.
Aure dolci, pure stelle
a Vittorio che d'allori
il suo crine si circonda
non cessate di aspirar...".
Il poeta aveva adattato alla circostanza un dialogo a cinque voci cantato dieci anni innanzi per il natalizio di Filippo V; da un re all'altro, nuovi entrambi, entrambi estranei e non legati all'isola da nessuna memoria, da nessun avvenimento, la differenza era nulla; le lodi rese all'uno e le speranze concepite per questo, potevano benissimo valere per l'altro, poichè la cortigianeria ha un solo vocabolario che si adatta a qualunque diadema.
Ma quelle frasi vecchie, espresse con trilli e gorgheggi, oltre che al gusto estetico, rispondevano in quel momento al sentimento generale, e parevano cosa nuova e bella e sollevavano nuovi entusiasmi. Alla fine della cantata, la piazza ripeteva il coro finale, come espressione dell'animo suo:
"Con plausi e trombe
d'aure giulive
il suon rimbomba
il nostro ciel, la terra, il mar.
Vaghe fortune
di lieti giorni
nel nostro popolo
Vittorio solo ha da sperar."
Erano versi stupidi e senza logica in una musica sdolcinata; ma chi ci badava? Il re sorrideva soddisfatto, sotto il baldacchino vermiglio sorretto dai senatori, e quel sorriso pareva un ringraziamento, un assentimento, una promessa.
Il corteo passò oltre.
Don Vincenzo Bongiovanni era rimasto estatico, come un fanciullo, ripetendo: "Bello! bello! bello!..."
Lentamente seguiva la folla, che rotta ora la riga dei soldati si rovesciava nel Cassaro dietro le carrozze. Dal palazzo Villafranca scendeva qualche signora, montava nella sua carrozza per tornare a casa o per andare al Duomo, costringendo la folla a fendersi, pigiandosi e confondendosi tumultuosamente.
"Guardate, guardate, Emanuele," disse Pellegra, che si teneva stretta per mano al giovane; "ecco la carrozza di quella duchessa."
La carrozza infatti si era avvicinata al grande portone del palazzo, fiancheggiato di statue. Era a pochi passi da loro. Emanuele si avvicinò per vedere se ci fosse quel cavaliere. Nella memoria gli era rimasto fitto come un chiodo il gesto di Blasco e nulla gli pareva così mortificante come l'aria e le parole tolleranti di quel signore, che lo aveva trattato come un fanciullo. Vergogna e sdegno gli imporporavano il volto. Avrebbe voluto rivedere Blasco, per dimostrargli che non aveva paura, con l'ostinazione e la prepotenza di un ragazzo viziato.
Don Vincenzo, che andava innanzi, passo passo, canticchiando con aria beata l'ultimo coro, "Con plausi e trombe", non si era accorto di quello che faceva Emanuele; ma a un tratto un grido di Pellegra, lo fece sobbalzare.
"Signor padre!... Aiuto... Emanuele!..."
Si voltò e vide Emanuele circondato da tre o quattro lacchè, i quali strettolo per le braccia, lo tempestavano di pugni, mentre il giovanotto, furibondo, si difendeva disperatamente.
Restò quasi balordo per un istante, poi cominciò a gridare spaventato: "Lasciatelo! lasciatelo!..."
Altri lacchè accorsero, accorse gente; intorno a quel gruppo rabbioso si fece gran folla: alcuni popolani si gettarono in mezzo per sottrarre il giovanotto dalle mani di quei servi inferociti ancor più dalla resistenza di Emanuele. Erano i lacchè del duca della Motta; uno di essi, quello che due mesi innanzi era stato gettato da Emanuele sotto le zampe dei cavalli, aveva riconosciuto il giovane, lo aveva indicato ai compagni, e tutti insieme gli erano piombati addosso improvvisamente, per vendicarsi dell'affronto e dargli una lezione.
Per poco il piano dei Bologna non si tramutò in un campo di battaglia.
All'intervento dei popolani, altri lacchè, credendo che volessero prendere le parti di Emanuele, si avanzarono minacciosi in difesa dei loro compagni, per solidarietà di casta; grida, urla, ondeggiamenti, confusione: don Vincenzo, sempre più spaventato per Emanuele, gridava:
"Lasciatelo! ... lasciatelo! ... Andrò a chiamare le guardie..."
Ma quelli picchiavano ed Emanuele si difendeva eroicamente, come un piccolo cinghiale tra cani. A un tratto una voce imperiosa dominò il tumulto: "Ah, vigliacchi! .."
Si vide nell'aria roteare una mazza ornata di nastri e cadere come un fulmine sulle spalle dei lacchè; una vera tempesta di colpi, inaspettati, poderosi, che in un attimo sbandarono quelle canaglie e liberarono Emanuele. Era Blasco, che uscendo in quel punto dal palazzo, accompagnando la duchessa in carrozza, accorso al grido, aveva riconosciuto il ragazzo.
"Vigliacchi!" gridava; "in tanti contro uno! Contro un ragazzo!.. Tornate al vostro posto..."
Con le spalle e le braccia ancora frizzanti per i colpi, i lacchè mortificati, come un branco di cani mandati dalla frusta a cuccia, si avviarono verso la carrozza, dove la duchessa, stupìta del grido e della corsa di Blasco, ignorando che cosa era accaduto interrogava il cocchiere.
Un minuto dopo la piazza riprendeva la sua tranquillità festiva; le carrozze si allontanavano, seguivano il corteo, o scendevano per il Cassaro; dai vicoli uscivano portantine e sedie volanti, che avevano aspettato lo sgombero della strada; del piccolo incidente nessuno parlava; esso si era perduto nel rumore della festa: ne parlava soltanto Pellegra, che vedendo i lividi sul volto di Emanuele, ne accusava il padre:
"Che bisogno c'era di cacciarsi tra le carrozze? La musica poteva udirla anche da lontano... Intanto, che dirà il signor don Girolamo?..."
"Già! .." ripeteva il pittore non sapendo che dire; "che dirà don Girolamo?"
Anche la duchessa parlava di quell'incidente. Aveva voluto sapere che cosa era stato. Blasco gliel'aveva detto.
"Mi rincresce davvero d'avere bastonato i vostri lacchè, ma non ho potuto frenarmi... Non crederete che abbia voluto fare torto alla vostra casa..."
La duchessa alzò le spalle con un movimento di graziosa noncuranza, e mormorò: "Non è la livrea dei La Grua..."
Ella fino a qualche mese prima indifferente verso il marito, cominciava ora a sentire contro di lui quella avversione che è così vicina all'odio. Blasco, pur amandola profondamente e dimostrandole la sua devozione, non aveva abusato della sua posizione privilegiata, e si era imposto una condotta piena di riserbo: ma appunto ciò ferendo il suo cuore di donna nei più ardenti desideri dei sensi risvegliati, nel bisogno di tutta la pienezza della passione, aveva fatto germogliare nell'anima sua e vi nutriva quel sordo sentimento di astiosa ostilità, contro l'uomo che le appariva come un ostacolo, come un incubo. Anche verso Blasco ora ella teneva un contegno piuttosto freddo, ma triste, ed evitava qualunque intimità, qualunque allusione, qualunque ritorno a quell'istante di gioia che ella aveva appena assaporato. Qualche cosa era piombata sopra di loro, e pur impedendo che si separassero, impediva nel tempo stesso alle loro anime di avvicinarsi e di fondersi.
Blasco continuava ad accompagnarla ed a servirla da buon cavaliere, aspettando sempre che don Raimondo gli confidasse il segreto delle misteriose inimicizie che lo circondavano; e l'aveva accompagnata al palazzo Villafranca, quel giorno di festa, con la stessa premura devota e affettuosa, lo stesso riserbo, che gli costava uno sforzo doloroso. Ora le parole così significative di donna Gabriella lo meravigliavano. Era la prima volta che egli sorprendeva nella sua bocca un accento quasi di disgusto per il marito. Ne ebbe un brivido.
Per la strada non si dissero una parola.
Qualche ora dopo don Raimondo fece chiamare Blasco nel suo studio.
"Che cosa dunque è accaduto," gli domandò con un contegno freddo, che mal celava la collera, "perché vi siete spinto fino a bastonare persone che indossano la livrea della mia casa?"
Blasco alzò il capo con quel gesto di fierezza che era in lui indizio del suo risentimento.
"Nient'altro," rispose "che questo: i vostri servi commettevano una vigliaccheria, e per l'onore vostro ho creduto di richiamarli al rispetto."
"In verità," ribattè don Raimondo, "non stava a voi giudicare la condotta dei miei servi, e non vi avevo ancora dato la facoltà di punirli..."
"È vero signore, ma quando vedo compiere delle viltà non ho l'abitudine di chiedere il permesso a nessuno, io, per impedirle... Ragione per la quale, Eccellenza, non credo più compatibile la mia presenza in questa casa."
E fatto un bell'inchino, Blasco usci dallo studio; qualche ora dopo, raccolta la sua roba, abbandonò il palazzo. Mettendo il piede fuori, respirò a pieni polmoni, ma nel tempo stesso levò gli occhi alla finestra della duchessa, e sospirò con dolore.
La sera stessa una mano di birri andava ad arrestare don Girolamo Ammirata ed Emanuele.