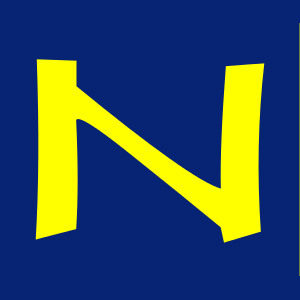Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 18
| Italiano | English |
Trovare un alloggio a Palermo, era più che difficile, impossibile. Le locande rigurgitavano. A Blasco non restavano che due strade, o domandare ospitalità a padre Bonaventura, nel convento di San Francesco, o domandarla al cavaliere della Floresta. Preferì quest'ultimo che era giovane come lui e cavaliere, e per il quale sentiva una viva simpatia.
"Vi recherò disturbo, se vi domanderò di ospitarmi in qualche parte del vostro palazzo?"
"Anzi mi farete un regalo, di cui vi sarò grato," rispose il cavaliere con accento di sincerità.
"Grazie! ero sicuro della vostra cortesia."
Il cavaliere della Floresta aveva un nome classico; si chiamava Coriolano.
Accompagnando Blasco nella stanza dei "forestieri" gli disse: "Chiamatemi col mio nome, e tralasciate con me i complimenti. Ho stima di voi e mi piace trattarvi come un fratello. Come vedrete, nell'ospitarvi soddisfo un sentimento egoistico, per cui non dovete ringraziarmi di nulla."
Era troppo gentiluomo per domandare a Blasco perché mai avesse abbandonato il palazzo Albamonte, sebbene non potesse affermare di non esserne curioso. Ma Blasco stimò doveroso dirglielo. Alla prima parola Coriolano della Floresta lo interruppe.
"Scusate; se è per spiegarmi le ragioni della vostra cara venuta, vi prego di non continuare; se è per farmi delle confidenze amichevoli, nel l'idea che io possa esservi utile, allora sono qui..."
"Voi siete non soltanto un gentiluomo, ma un uomo veramente gentile, Coriolano. Ebbene, sì, sono confidenze che io faccio a un amico. Ho bisogno di un cuore fraterno, e sento di averlo trovato in voi. Io sembro a tutti un giovane un po' strano, scapato, che ride, si batte, corre di qua e di là senza pensare al domani, di null'altro preoccupato, se non di bere alla coppa della gioia. Tale infatti la mia vita avventurosa mi ha formato; ma in fondo all'anima c'è annidata la tristezza, e di là getta un'ombra intorno a me, un'ombra che vedo io solo... Io sono stato per un pezzo il trastullo della fortuna; cosa che non mi garbava punto: mi sono sforzato d'invertire le parti e farmi alla mia volta dominatore di essa; vi sono riuscito, ma ciò non toglie che, di tanto in tanto essa non mi faccia qualche tiro. Non importa. Capisco che bisogna ridersene: ma qualche volta, no, non posso ridere, specialmente quando, come ora, mi trovo in una condizione... Mah!..."
Gli raccontò la scena avvenuta nel piano dei Bologna, risalendo ai precedenti, e il breve e significativo dialogo avvenuto tra lui e il duca della Motta.
"Che volete? Sono fatto così. Se vedessi un mio fratello commettere una viltà credo che l'accopperei; fortunatamente non ho fratelli. Del resto se vi devo confessare la verità non mi spiace avere lasciato il palazzo Albamonte. A che titolo io vi abitavo? La mia permanenza in quella casa mi esponeva a mille pericoli, che, non ridete, dovevo evitare. Questa è la parte più dolorosa, ma anche la più bella della mia risoluzione..."
Il cavaliere della Floresta lo ascoltava sorridendo lievemente; teneva il mento appoggiato alla mano e il gomito sull'alto bracciuolo del suo seggiolone; era una mano bianca, femminea, senza una menda. Al silenzio che era seguito alle ultime parole di Blasco, egli disse con quel garbo signorile che dava il tono al suo gesto come alla sua parola: "Povero amico! siete dunque veramente innamorato?"
Blasco arrossì e rispose vivamente: "Chi ve lo dice?"
"Vi rincresce che io l'abbia indovinato? Ve ne domando scusa..."
Blasco chinò il capo un istante, poi riprese con vivacità non disgiunta una certa amarezza: "Ebbene, sì. Sono innamorato, è la prima volta che mi capita di innamorarmi davvero. Non è bella forse? Non è incantevole? Non ha ella fascini misteriosi che legano le anime?... La prima volta che io la vidi, or sono circa tre mesi, ella mi passò dinanzi rapidamente; una visione fugace, che lasciò un'orma profonda nella memoria... Durante questo tempo l'ho potuta conoscere, apprezzare, ammirare. Così è nata questa passione. Voi comprendete che la mia condizione in quella casa mi vietava di approfittare; delle circostanze favorevoli... L'amo,e troppo per comprometterla. Ho frenato i miei desideri, ho soffocato la voce della passione, mi sono, per così dire, macerato come un anacoreta... Vi sembra strano, non è vero?... Avete ragione, neppure io mi riconosco! Bah! Credevo di avere posto fine alle bestialità; mi accorgo di averne commesso una più grossa delle altre..."
Rise, ma di un riso che non veniva dal cuore, e che evidentemente gli costava uno sforzo.
"Vi siete mai innamorato, Coriolano?"
"Mai," rispose il cavaliere col suo lieve e sottile sorriso. "Ho sempre pensato che nel mondo vi può essere qualche cosa di meglio da fare."
"E che cosa dunque avete fatto di meglio?"
Coriolano della Floresta lo guardò con uno sguardo limpido e di una meravigliosa ingenuità, e rispose: "Nulla. Blasco lo guardò stupito, poi, come riflettendo, disse: "Forse avete ragione; "nulla" è sempre meglio che innamorarsi come una bestia!... Felice voi che non avete addosso questa maledetta smania, che ho io, che vi moltiplica la vita, che vi spinge a fare qualche cosa, e vi fa sempre più sentire come un vuoto che bisogna riempire! Io ho questa smania; l'ho fin dalla nascita!.."
E improvvisamente troncando quella riflessione malinconica, disse: "Conoscete la mia vita, Coriolano? No; adesso voglio raccontarvela brevemente."
Si raccolse un po' come per rinfrescare la memoria, e riprese: "Fino a qualche mese fa, ignoravo in quale parte del mondo ero nato; della mia infanzia non avevo che qualche imperfetta, confusa, vaporosa reminiscenza. Le memorie non cominciano che dal mio quinto anno. Fui raccolto sulle rovine di Catania, da un buon frate che mi portò con sè in un convento.
Serbo un'immagine incerta di quel convento, che mi pareva ampio, immenso, freddo, e nei cui corridoi v'erano delle pitture che mi mettevano terrore. Quei frati mi viziavano: io ero padrone di fare quello che volevo: entravo nelle celle, mi arrampicavo sul le loro spalle, tiravo sassi al pollame e, in sagrestia, mangiavo le ostie che servivano per la messa.
Il frate che mi aveva preso con sè si chiamava padre Giovanni. La sua figura e la sua bontà sono scolpite qui, in fondo al mio cuore. Forse pensava di fare di me un altro frate. Di sei anni cominciò a farmi imparare il latino; a dìeci anni traducevo qualche classico con una facilità che faceva supporre in me un ingegno straordinario. Quei buoni frati prevedevano che io sarei stato un luminare dell'Ordine.
Povere illusioni!
Io però amavo meglio correre per la "selva", arrampicarmi sugli alberi, montare a cavallo delle mule del convento. L'aria e il sole mi piacevano più delle declinazioni e delle egloghe virgiliane. M'ero fabbricata da me una spada, con uno spiedo rubato in cucina, al quale avevo adattato, a guisa di elsa, la coppa di un vecchio ramaiuolo e mi pareva d'essere armato come un cavaliere.
Un giorno, avevo dieci anni compiuti, padre Giovanni fu mandato in altro convento. Egli non potè condurmi con sè, e prima di partire, mi baciò, e mi diede una lettera per un altro frate, padre Bonaventura da Licodia, che prima stava nello stesso convento.
La partenza di fra Giovanni mi riuscì più dolorosa di quello che io immaginavo; il convento, senza di lui, mi parve un luogo così orribile, che due giorni dopo, armato del mio spiedo, e con un pane in un sacchetto, me ne fuggii.
Dove andavo? Non conoscevo le strade: il mio mondo si era fino allora limitato all'orto, alla selvetta dove andavano a passeggiare i frati, a qualche campagna. Oltrepassati quei confini, mi si presentava un mondo più vasto, che sulle prime mi sgomentò; ma nel mio cervello non c'era che un'idea: andare a trovare fra Giovanni. Dove? A dieci anni si immagina che tutte le strade debbano condurre dove noi vogliamo andare. Mi avventurai per i sentieri che si dilungavano dinanzi a me, supponendo che, necessariamente, sarei giunto a Messina prima di sera. A sera mi trovai solo, perduto, sopra un colle solitario, fra montagne che mi empivano di terrore, circondato dai mille rumori misteriosi e indefiniti della imminente notte, e per giunta affamato, avendo consumato la mia provvista di pane.
Allora mi sedetti per terra, e mi misi a piangere. Dov'era il convento? Avrei voluto ritornarvi: ma qual era la strada? Sopra il mio capo il cielo immenso diventava più cupo, e io non osavo guardarlo: grandi ombre avvolgevano le valli, e io guardavo per terra, per non vederle.
Un latrare di cane mi fece trasalire. Cercai donde venisse: se c'erano dei cani, ci dovevano essere degli uomini.
Giù, a piè del colle, un polverio confuso: guardai bene: l'ultima luce crepuscolare mi fece riconoscere un gregge. Allora non ebbi più paura. Scesi dal colle, in fretta, chiamando. Due grossi cani da pastore, che parevano due lupi, mi vennero incontro sospettosi e biechi, ma quando videro che io ero un fanciullo, si fermarono, guardandomi coi loro occhi colore di miele, senza fare nulla.
"Che cosa fai solo, in questa montagna?" mi domandò uno dei tre pastori che guidavano il gregge: era un uomo piccolo, tozzo, barbuto, feroce. A me parve bellissimo.
"Mi sono smarrito;" balbettai "abbiate pietà di me... ho paura."
Si misero a ridere tutti e tre e quello che aveva parlato, disse: "Ebbene, vieni con noi."
Così diventai pastore, a dieci anni: quella vita errante, su per le montagne, tra cielo e terra, mi fortificò; forse debbo ad essa una certa semplicità e il disprezzo che ho per tutte le cose superflue e quella tempra che mi ha fatto resistere alle prove più dure. Tuttavia non sapevo rassegnarmi a quella vita. Avevo la lettera di fra Giovanni, che rappresentava tutta la mia ricchezza, e pensavo sempre a lui, nè abbandonavo l'idea di andare a raggiungerlo. Mi informavo delle strade, domandavo le distanze, e andavo maturando nella mia mente il disegno di una fuga...".
"Vi annoio, Coriolano?"
"Tutt'altro. Il vostro racconto è interessantissimo, ed io vi ascolto con piacere. Continuate, ve ne prego."
"Come volete" riprese Blasco.
"Io passai due anni fra i pastori, accarezzando il disegno della fuga. I pastori non mi lasciavano allontanare; avevano trovato un garzone, che rimuneravano con latte ed erbe, e con un giaciglio di paglia e di pelli, e non intendevano lasciarselo scappare. Io intanto prendevo conoscenza e pratica di quelle contrade, i sentieri mi diventavano familiari; sapevo i feudi per i quali potevamo condurre le greggi; sapevo a chi appartenevano; sapevo dove si trovassero i borghi e i castelli più vicini.
Una mattina, si era sul cominciare dell'autunno del 1700, noi eravamo nello Stato di Brolo; i pastori s'erano recati al castello per riverire il padrone, arrivato in quei giorni, e mi lasciarono solo. Vedevo dall'alto del colle il mare e in fondo le isole Lipari. Il mare!... Era la libertà. Non so quale smania mi prendesse. Abbandonai le greggi, e mi gettai fra le balze dei colli, verso quell'azzurro lontano. Per evitare ogni possibile incontro, mi allontanai dai sentieri. Uno dei mastini, che mi si era affezionato ed era il mio compagno di mensa e di letto, mi seguiva. Dapprima avevo cercato di cacciarlo via, ma esso si ostinava a seguirmi, e alle mie minacce rispondeva sdraiandosi per terra, scodinzolando e guardandomi con gli occhi color di miele, così teneramente, che non ebbi più il coraggio di respingerlo.
Esso mi precedeva ora, vigile, animoso, perlustrando le macchie, annusando ogni spaccatura di rupi, ogni mostruoso gruppo di massi. A un tratto si fermò con le orecchie diritte, rabbuffando il dorso. Guardai e impallidii; in una macchia vidi splendere due pupille e biancheggiare dei denti formidabili. Un grosso lupo ci stava dinanzi, ringhiando. Lampo, era il nome del cane, con un balzo assalì la belva; non vidi che un terribile viluppo di corpi rotolanti, balzanti, urtantisi; non udii che un sordo ringhio rabbioso. Allora cominciai a gridare per dare coraggio a Lampo e, impugnato il mio spiedo, mi avvicinai, cercando di colpire il lupo. Lampo si batteva valorosamente; aveva il collo e il dorso sanguinanti, ma era arrivato ad azzannare il lupo per la nuca, conficcandogli i denti, e costringendolo a piegarsi, impotente. Era il momento opportuno. Gli tirai una stoccata nel fianco. Il lupo mandò un urlo e cadde. Lampo lo tempestò di morsi alla gola, nè lo lasciò se non quando lo vide immobile nel proprio sangue; allora scosse il dorso, e nonostante ferito, fece due o tre salti di allegria. Io l'abbracciai e lo baciai: senza di lui, sarei stato sbranato dalla belva.
Verso sera giungemmo in un piccolo borgo, sul mare. Seppi che si chiamava Zappardino. Non osai entrare nell'abitato, ma aspettai che annottasse, per ricoverarmi dentro una delle barche tirate a secco, nella quale avrei potuto passare la notte.
Però avevo fame: anche Lampo doveva essere affamato: come provvedere? Il sole era tramontato, i casolari dei pescatori fumavano: certo quella povera gente si apparecchiava a cenare. Quell'idea aumentava e rendeva insopportabile la fame. Percorsi il piccolo borgo, con lo stesso risultato; poi trovai una chiesa, forse la parrocchia, e pensai che il curato mi avrebbe raccolto, per amor di Dio!... Mi accolse brandendo un nodoso bastone. Lampo era disposto a difendermi, ma lo trassi a me. Per quella notte andammo a dormire con lo stomaco vuoto. Lampo mi precedeva cacciandosi tra i cespugli: levò, senza volerlo, due quaglie. Io ero espertissimo nel tirare i sassi, come tutti i pastori: quelle quaglie mi parvero piovute dal cielo, come agli ebrei nel deserto. Era la passa di ritorno, ed evidentemente avrei trovato altre quaglie: scelsi dei ciottoli, e mi misi a cacciare. Dopo un'ora avevo ucciso sei quaglie. "Andiamo, Lampo! il buon Dio ha pensato a noi."
Diventavo un piccolo vagabondo, e, quel che è peggio, prendevo gusto alla vita errante e avventurosa; ma cominciavo a capire che non potevo e non dovevo vivere di carità, e che era necessario provvedere ai mezzi di guadagnarmi la vita. Mestieri non ne conoscevo, ma mi sentivo disposto; per soldato ero ancora troppo piccolo; frate non volevo essere.
Solo, sperduto, povero, senz'altri compagni che il mio spiedo e Lampo, Giungendo a Cefalù (mi avviavo a piccole tappe per venire a Palermo) e capitai in un giorno in cui un signore de Franchis, per conto del vescovo, armava un suo trabaccolo, Santa Maria, e ingaggiava la ciurma. Mi offersi per mozzo. Ero robusto, non sgradevole, fui accettato, e tre giorni dopo, con una grande commozione, mi avventurai nel primo viaggio per mare. E così incominciò una vita nuova: dopo aver provato la terra, provai il mare; sfuggito ai lupi, andavo incontro ai pescecani. Mi affezionai a quella vita; c'era qualche cosa che si confaceva al mio gusto. Quando il vento fischiava tra il sartiame e mi scompigliava i capelli e le ondate livide e spumeggianti minacciavano il trabaccolo, io mi sentivo felice.
Un giorno scopersero che io sapevo leggere e scrivere, e, cosa ancora più sbalorditiva, che sapevo il latino, come un frate. In mezzo a quella gente rozza e ignorante, parvi un fenomeno singolarissimo, anzi unico; mi considerarono con qualche rispetto, immaginando chissà che cosa. Ciò suscitò l'invidia di un altro mozzo, maggiore di me di quattro o cinque anni, il quale prese a stuzzicare me e Lampo. Io sdegnavo rispondergli per quanto riguardava me, ma non tolleravo che molestasse Lampo. Un giorno che, per farmi dispetto, egli diede un calcio a Lampo, io lo presi per la vita, lo sollevai in alto e lo gettai in mare. Questo fatto mi rivelò a me stesso: fino allora avevo ignorato di che cosa fossero capaci i miei muscoli. Il mozzo fu salvato: io fui bastonato e posto ai ceppi, ma la punizione mi apparve ingiusta e ingiuriosa. Il trabaccolo era in rotta per Napoli: quando approdammo, io che avevo scontato la punizione, sceso a terra, mi nascosi e non tornai più a bordo della Santa Maria. Ma non rinunciai alla vita del mare.
Per otto anni, passando da trabaccoli a brigantini, da brigantini a vascelli, da legni mercantili a legni di corsa, vissi sul mare, sballottato dalle tempeste, alle prese coi barbareschi, percorrendo il Mediterraneo, battendomi, rischiando la vita, scampando a mille morti, non certo perché la prudenza mi rendesse guardingo, ma perché pareva che qualche essere misterioso mi proteggesse...
Ma tutte le volte che vedevo un frate, mi ricordavo di fra Giovanni, e mi pungeva un rammarico, un rimpianto, che mi rendeva più cara e preziosa la sua lettera come una reliquia. Non potevo pensare a mia madre, perché la sua immagine si era affievolita, era scomparsa dal mio cuore, e mi pareva di non averne mai avuto!... Povera mamma!... La parola di padre Bonaventura ha ora destato nel fondo oscuro della mia coscienza un pallido e triste volto di donna, un po' confuso e incerto, ma con grandi occhi dolenti!".
Blasco tacque un po', quasi per godere la visione evocata dalle sue parole, indi riprese.