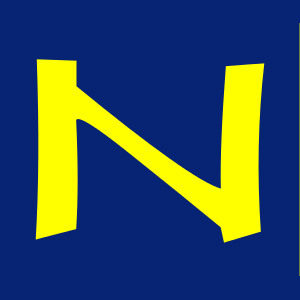Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 19
| Italiano | English |
"Nel 1708 mi trovavo a Napoli: avevo vent'anni, e mi pareva di essere il padrone del mondo. Ero povero, solo, senza casa, senza parenti, senza patria. I ricordi del convento si era no affievoliti anch'essi, come offuscati da altri ricordi più recenti. Mi sentivo una smania di fare, e la vita d'ozio che passavo in quella città, aspettando che il bastimento riprendesse il mare, mi riusciva non soltanto noiosa, ma, peggio ancora, mortificante e vergognosa.
Vivendo come un semplice marinaio, frequentavo le taverne del porto e attaccavo brighe facilmente; ma devo confessarvi che sentivo una specie di disgusto, una segreta avversione per quella società e per quello che facevo. Ricordo un episodio.
Stavo sul molo, presso il Castel nuovo, vedendo alcuni galeotti che tiravano una galea nell'arsenale, per riparazioni che occorrevano. C'era altra gente. I capiciurma, armati di grossi randelli sorvegliavano i galeotti, i cui piedi, per altro, erano legati fra loro da catene appena sufficienti per fare un passo.
Uno di quei galeotti tozzo, barbuto come un caprone, nudo e sporco come un selvaggio. Tirava la corda emetteva certi grugniti feroci, brevi, a riprese, che richiamavano l'attenzione. A un tratto lo vidi impallidire, fermarsi e gridare: "No, Giuseppico! no!"
Un uomo fendeva la folla dei boriosi: magro, ossuto, nero, di aspetto, ferino. I suoi occhi lampeggiavano di odio. Mi accorsi che era armato di coltello...
Il galeotto gridò ancora, con terrore: "No, Giuseppico! no!..."
L'uomo che rispondeva a questo nome mormorò fra i denti alcune parole in un dialetto che io riconobbi, sebbene non lo intendessi bene. Ere sardo".
Il cavaliere della Floresta trasalì.
"Sardo?" domandò con affettata indifferenza.
"Sì."
"E si chiamava Giuseppico?"
"Sì, perché mi fate questa domanda?"
"Nulla... perché molti anni fa... avevo anch'io un servo sardo, che si chiamava Giuseppico... Continuate."
"Per quanto potei comprendere, Giuseppico disse: "Son dieci anni che ti aspetto! ...".
Era quasi addosso al galeotto. Vidi balenare la lama: allora mi slanciai su Giuseppico, lo afferrai per le braccia, impedendogli di compiere la viltà di assassinare un uomo senza difesa. Quella belva ruggendo per l'inaspettato impedimento, si gettò allora sopra di me cercando di divincolarsi, per colpirmi, ma il mio braccio era diventato di ferro, la mia mano era una morsa: egli cercò di addentarla, e allora io gli torsi le braccia, che diedero uno scricchiolio.
Mandò un urlo e cedette. Non so se gli slogai le ossa; certo non fu in grado di reagire, ma tre o quattro uomini, che evidentemente erano lì per proteggerlo, mi si fecero incontro coi coltelli in pugno. Riconobbi dei camorristi: quel Giuseppico era uno dei loro. Con questa gente bisogna essere audaci: io non avevo armi, ma li affrontai, improvvisandone rapidamente una. C'era lì un arganello, ne strappai un aspe e mi misi in guardia: quel pezzo di legno dovette diventare un'arma formidabile, perché due di quei malandrini furono subito posti fuori combattimento: gli altri due fuggirono. Intorno a me s'era fatto un gran cerchio di spettatori, la cui curiosità era sufficientemente eccitata dalla mia giovinezza: i galeotti stessi, i capiciurma, gli algozini, si erano fermati a guardare quel singolare duello e forse rimpiangevano tutti che fosse terminato così presto.
Ma la vittoria non mi serbò corona d'alloro: tutt'altro! Io mi trovai a un tratto circondato e stretto da guardie e da soldati; e che soldati! Dei bestioni biondi, giganteschi, puzzolenti di vino, e che gridavano in una lingua sconosciuta... Indovinerete certo che io parlo dei soldati austriaci, perché, come sapete, fin dal luglio del 1707, il regno era stato occupato dalle truppe dell'imperatore Carlo VI.
La mia condizione era critica: correvo il rischio di andare in galera, perché la giustizia dell'imperatore non scherzava: d'altro canto devo confessarvi che quegli austriaci mi erano tremendamente antipatici.
Due ragioni per farmi risolvere. Il mare era a due passi: raccolsi in un supremo sforzo tutte le mie energie, e dato un urto potentissimo ai due soldati che mi trattenevano, li mandai a gambe levate fra i loro compagni, e mi slanciai nell'acqua, tra lo sbalordimento dei soldati, gli urli di ammirazione e le risa della folla, la delusione di quei malandrini. Ma dopo quel primo sbalordimento, quei barbari, mortificati per il fiasco, corsero a una barchetta per inseguirmi. Essi non sapevano d'avere a che fare con un uomo cresciuto nell'acqua, che poteva essere parente del famoso Colapesce.
Con poche bracciate raggiunsi un bastimento della repubblica di Venezia e mi ci ricoverai. Territorio straniero per togliermi dal quale occorreva o un tradimento o lunghe pratiche. Breve: dal bastimento veneziano passai in uno olandese che salpava la stessa sera alla volta di Genova, ma non fu quella l'ultima. mia navigazione.
Sarebbe lungo raccontarvi i miei pellegrinaggi attraverso l'Italia. Come vivevo? Non lo so neppure io, e pensandoci ora, mi stupisco d'essere rimasto vivo, fra mille privazioni, mille disagi, mille pericoli. Il mio digiuno non m'impediva di ridere e i miei poveri panni non m'impedivano d'innamorarmi di ogni bella ragazza e di battermi.
Ritornai a Napoli dopo due anni, con l'intenzione di venire in Sicilia e rintracciare padre Giovanni o padre Bonaventura. Ma pareva che un destino avverso mi allontanasse sempre da loro. La tartana sulla quale viaggiavo, oltrepassata Capri, fu assalita e presa da due grosse navi barbaresche e noi fummo incatenati e gettati nelle stive e trasportati a Tunisi...
Durante la mia vita di pastore, avevo imparato a suonare il piffero: me ne costruivo io stesso, e non suonavo malamente. Lungo la traversata, per ingannare l'ozio, suonavo qualcuna di quelle patetiche canzoni siciliane, che mi erano rimaste nel cuore come un'eco, un segno della patria: quelle canzoni avevano la potenza di ammansire i barbareschi: mi si mettevano intorno e mi sollecitavano a sonare e stavano lì ad ascoltarmi inteneriti e dimentichi di ogni altra cosa; cosicchè sbarcando a Tunisi, io fui presentato al Bey, come un pezzo raro e prezioso e non fui gettato negli ergastoli, ma trattenuto nel palazzo del Bey, come suonatore di Sua Altezza maomettana.
Se vi dicessi che quegli anni di cattività racchiudono per me ricordi incantevoli, forse non mi credereste... Ma è così.
Io godevo di una relativa libertà e spesso ero chiamato a suonare nell'harem. Una volta, suonando una delle mie più patetiche canzoni siciliane, vidi attraverso le inferriate, dietro le quali le donne del Bey ascoltavano, vidi gli occhi di una di loro empirsi di lacrime e me ne sentii rimescolare. Non ho mai veduto piangere una donna senza commuovermi. Perché piangeva? Era giovane? Era bella?
Io non vedevo altro di lei che gli occhi, ed erano grandi, neri, malinconici. La sera, prima di venir chiuso, una schiava mora, passandomi accanto, mi sussurrò una parola, che mi fece trasalire. Era un saluto, un semplice saluto inviatomi dall'ancora misteriosa ascoltatrice: ma bastò per non farmi chiudere occhio durante la notte. Mi prese un vivo desiderio di sapere chi fosse, di vederla, di conoscerla. Quanto al primo, non ci volle molto ad appagarlo: da quella schiava mora, che pareva cercasse le occasioni per vedermi, seppi che era una giovane donna, da due anni nell'harem, e che era una siciliana, rapita dai corsari, nelle spiagge di Marsala. Non potete immaginare quale stretta dolorosa e di pietà mi opprimesse il cuore a quella notizia. La mia canzone aveva destato in lei il ricordo della patria lontana, che forse non avrebbe riveduto mai, e il suo saluto mi parve allora come un rimpianto, un desiderio, un grido di dolore, di affetto, una implorazione!... Ahimè! io non ero che uno schiavo, e la mia virtuosità non mi avrebbe fatto riscattare.
Da quel giorno dei pensieri pazzi e audaci mi turbinavano e mi tormentavano il cervello. Prima di tutto desideravo vedere la mia compatriotta; ma l'impresa non era facile nè senza grandi pericoli. L'harem era custodito da eunuchi formidabili e feroci, e le leggi musulmane sono, su questo riguardo, rigorosissime. Ma che cosa può impedire a una donna di ottenere quello che vuole, nonostante i più rigidi divieti e la più oculata custodia? Voi non immaginerete mai quanti intrighi si annodino, si intreccino, si svolgano dentro il recinto impenetrabile dell'harem. Delle schiave serve affezionate a questa o a quella delle donne del Signore, sono le mezzane discrete e guardinghe di quegli intrighi. Non si tradiscono, perché ognuna sa dell'altra, e la menoma indiscrezione può costare loro la vita. La buona Oicuma metteva uno zelo e un'accortezza straordinaria: aveva tutte le furberie dei negri e tutte le sottigliezze dei servi. In grazia sua, una volta, io, nascosto in un giardino potei vedere Elisabetta, o come era diventata, Lizbeth, senza il velo, mentre stava con altre donne sopra un terrazzino. Mi parve bellissima. Ella sapeva dove ero io, sebbene non mi vedesse, e fece un gesto come di saluto; un gesto doloroso, quasi disperato...
Che cosa vi dirò? A ventidue anni i sentimenti di amicizia, di pietà, verso una donna giovane e bella si tramutano in amore. Noi ci amavamo; ci amammo disperatamente: ma con l'amore sorse potente, incessante, il pensiero della fuga...
Vi risparmio i piani più o meno pazzi e inverosimili che disegnavo nella mia mente, e che Elisabetta, col senso pratico delle donne disperdeva: deludere la vigilanza degli enuchi, far cadere i chiavistelli che serravano le porte, oltrepassare le mura dell'harem, trovare una nave, poter salpare senza timore d'essere inseguito, non erano problemi da poter risolvere facilmente. Elisabetta mi mandò a dire che aspettassi il mese del Ramadan, e lasciassi a lei l'iniziativa della fuga.
Io intanto, per ingraziarmi e addormentare i miei custodi, andavo dicendo che mi sarei fatto turco: ma rimandavo di giorno in giorno la solenne cerimonia, che è il loro battesimo. Ottenevo però una maggiore libertà, della tolleranza, della benevolenza. Un Imam prese a istruirmi sul Corano: io imparavo un po' l'arabo, e per mostrare che seguivo la legge di Maometto, mi vestii alla loro maniera, mi astenni dal vino e dalle carni suine e portavo appesi al cintolo dei lunghi rosari, come i loro santoni: ma quando essi credevano che io recitassi le loro preghiere, io mentalmente recitavo le nostre. Non avevo armi. Un giorno in un vecchio magazzino, riuscii a scovare fra tanti ferracci, una spada italiana; una di quelle spade lunghe, forti, dalla guardia ampia e ornata, che vediamo nei ritratti dei nostri antichi; spade che richiedevano braccio fermo e sicuro: è la spada che ho portato con me. Riuscii a rubarla e a nasconderla.
"Questa - pensai - mi sarà utile."
Ma più utile ancora sarebbe stato del denaro. Delle piastre d'oro hanno più possanza della punta di una spada, in certe occasioni. Io ero povero. Ma Elisabetta pensò anche a questo. Una mattina mi mandò una collana di perle perché la vendessi. Ne ebbi un fiero colpo, parendomi una cosa mortificante: ma non c'era da discutere. Mi proposi di adoperarla per liberare Elisabetta, e di non toccarne un grano per mio uso. La collana va leva cent'onze: la portai segretamente a un ebreo che fiutandovi sotto una provenienza dubbia, me la pagò a stento quarant'onze. Il miserabile cercò, con insinuazioni mielate, di strapparmi il segreto; ma quando s'accorse dell'inutilità dei suoi tentativi, pensò di riprendere il suo denaro, minacciando di denunziarmi come ladro. Mi vidi perduto. Lo ricacciai in fondo alla bottega, lo strinsi per la gola per impedirgli di gridare... forse strinsi un po' troppo. Lo lasciai per terra, seppellendolo sotto una balla di tappeti, e uscii dalla bottega serrandone l'uscio dietro di me.
Era già cominciato il mese del Ramadan, che è come una quaresima per i turchi: tempo di penitenze, digiuni, preghiere a modo loro. Una cosa buffa per noi, ma che essi compiono devotamente. Durante quel periodo, appena calato il sole nessuna nave può uscire dal porto: un colpo di cannone annuncia la chiusura del porto. Tutti i marinai conoscono questa usanza e se hanno bisogno di partire dentro sera, si affrettano a uscire dal porto prima del colpo di cannone. Avrete compreso già che noi avevamo stabilito di approfittare di queste circostanze per fuggire.
Da tre o quattro giorni era arrivata una galea di Trapani, con salvacondotto, a sbarcarvi sale e imbarcare tappeti. Mi concertai con loro: erano giovani animosi, rotti a ogni disagio e familiari coi combattimenti di mare ai quali l'idea di fare un torto a Maometto sorrise. Ignoro se conosciate la topografia di Tunisi: la città si trova in fondo a un ampio seno tutto chiuso, detto per la sua forma "lago di Tunisi": un breve canale mette in comunicazione il lago col Mediterraneo; su questo canale sorge la Goletta coi suoi bastioni, simile a una sentinella vigilante sull'entrata del lago. Il Bey abitava allora nel cuore della città, presso il bazar, in un gran palazzo, protetto da una fortezza detta la Kasbah, eretta da Carlo V. Uscendone bisognava attraversare il quartiere del bazar, e uscire alla marina per imbarcarsi: ma rimaneva poi da superare la Goletta.
Aspettammo un venerdì, giorno di grande preghiera. Elisabetta con lo aiuto della mora, uscì travestita da uomo dalla parte del giardino, eludendo la vigilanza degli eunuchi e delle guardie. Ella tremava dentro di sè, ma si comportava con una grande forza d'animo. Io l'aspettavo celato nel fondo di una barca, montata da sei robusti marinai della galea, che, per non destare sospetti avevano caricato alcune mercanzie. Elisabetta venne alla barca portando un grosso involto: pareva un tappeto; dentro vi teneva uno scrignetto con le sue gioie. Ella pareva un giovane facchino, di quelli che lavorano allo sbarcatoio. Quando io la vidi entrare nella barca, mi sentii empire gli occhi di lacrime; anche lei si mise a piangere. I sei remi diedero un tonfo nell'acqua e la barca si staccò dalla riva. Al tramonto mancava qualche ora, il tempo appena sufficiente per uscire dal canale della Goletta un minuto prima che il cannone annunziasse la chiusura del porto. Io non osavo ancora alzarmi dal fondo della barca per paura d'essere scoperto: anche Elisabetta si era nascosta; le balle e le gambe dei rematori ci celavano ma nondimeno noi tremavamo. Avevo preso nelle mie le mani di Elisabetta: era quello il nostro primo incontro e non osammo dire una parola; ma i nostri occhi parlavano per le anime nostre.
Qualche nave turca ci passò accanto. Se il desiderio avesse potuto affrettare la barca, le avrebbe dato le ali. Dal fondo vedevo il cielo ancora luminoso, e dicevo tra me: "Ancora c'è tempo!" E pensavo: "Se c'inseguiranno? Se avviseranno la guardia della Goletta?"
Avevo con me il mio spadone, i marinai avevano portato delle carabine e delle picche. Eravamo in sette e non difettava il coraggio. A un tratto uno dei rematori disse: "Se non sbaglio, ci inseguono."
Allora mi alzai tanto da sporgere il capo. Due barche piene di gente, che non si distingueva bene, venivano a gran furia di remi; da una di esse qualcuno agitava una specie di bandieruola: forse un segnale.
Impallidii; non per me, ma per Elisabetta. "Forza!" gridai.
C'erano dei remi di riserva: ne presi due, li adattai sulle forcole, mi piantai sopra un banco e diedi vigorosamente un colpo. La barca ebbe un guizzo.
"Bravo!" esclamarono i miei compagni, sorpresi e incuorati da quell'inaspettato soccorso.
Guadagnammo spazio; ma più noi ci allontanavamo e più aumentava lo sbandieramento: e poi, a un tratto, ecco una fucilata. Eravamo, credo, a meno di mezzo miglio dal canale e vedevamo il sole scendere lentamente dietro le colline; ancora un poco e il cannone avrebbe dato il segno. Moltiplicammo i nostri sforzi; la barca pareva davvero avesse le ali: inginocchiata nel fondo, Elisabetta pregava. Ma ecco, all'imboccatura del canale uno zambecco carico di soldati staccarsi dal molo della Goletta per sbarrarci la via. Il più lieve indugio ci avrebbe perduti, perché saremmo rimasti in gabbia: ormai si trattava di vita o di morte. Ancora un poco e saremmo stati fuori del canale.
Lo zambecco ci si era messo dinanzi; non c'era tempo da perdere: eravamo distanti da esso una cinquantina di passi.
Io dissi: "Attenti! vengono all'arrembaggio: prepariamoci!"
Il capo dei soldati ci gridò di fermarci. Ma sì! Noi demmo un colpo più vigoroso di remi, deviando dalla rotta per evitare un urto che poteva riuscire dannoso anche a noi.
"Giù!" gridai.
Ci gettammo sotto; una scarica passò sopra le nostre teste: ci rilevammo con le carabine spianate e facemmo fuoco alla nostra volta. Quei malandrini non si aspettavano il tiro, e stavano tutti scoperti; i nostri colpi colsero nel segno, arrestarono, sgomentarono, atterrirono gli assalitori; ci lasciarono libero il varco.
"Animo, ancora un colpo di remi!..."
Passato il primo sgomento, e adagiati i feriti, i soldati ricaricarono le armi mentre lo zambecco ci veniva addosso a tutta furia, all'arrembaggio. Eravamo già alla bocca del porto: avemmo appena il tempo di chinarci sotto, che i nostri nemici ci fecero un'ultima scarica quasi a bruciapelo; le palle si conficcarono nel bordo, qualcuna attraversò il fasciame e ferì. Lo indovinai all'urlo di dolore.
Brandii il mio spadone; i marinai si armarono in un attimo delle picche e delle scuri. I tunisini tentarono di agganciare con arpioni la nostra barca, ma l'urto col quale c'in vestirono, bastò a spingerci fuori dalla linea del porto. Temendo che noi fuggissimo, ci si gettarono addosso con maggior furia, intanto che altre barche armate sopravvenivano. Il momento era tragicamente terribile; ancora un minuto e poi saremmo stati liberi o presi. Cercando di respingere l'arrembaggio uscivamo sempre più dal porto. Il sole era calato dietro i monti; un'ultima luce guizzava: la nostra lotta per non farci prendere era disperata. A un tratto rimbombò un colpo di cannone; levammo un grido di gioia; il porto si chiudeva, le barche si arrestarono; noi e lo zambecco eravamo fuori, nel mare libero. Allora gettammo gatte e rizze e agganciammo lo zambecco per trarlo con noi. Venimmo alle mani ferocemente, disperatamente.
Quel che io feci col mio spadone, non lo so: i tunisini erano in maggior numero e cercavano di liberarsi.
I nostri colpi cadevano sulle loro braccia, sulle loro mani. Urli, gemiti e sangue.
Io gridai ai miei compagni: "Voga al largo... Qui basto io."
Quattro remi con un violento tonfo trascinarono via le due barche, strette l'una all'altra, mentre io battagliavo. Se giungevamo a superare le rocce che lì sono alte e a picco, saremmo stati al coperto anche dai bastioni.
Nella barca tunisina non v'erano più che sei soldati validi; gli altri, feriti, gemendo si erano abbandonati sulle panchette o nel fondo; quei sei si strinsero intorno a me; uno di essi avendo ricaricato il suo archibugio mi prese di mira. Io udii un grido vidi una figura gettarsi innanzi a me; un colpo: una nube di fumo ci avvolse...
Oh, povera Elisabetta! Ella prese in pieno petto la palla che doveva uccidermi: ella si immolò per me!...".
Blasco si fermò. La sua voce si era abbassata per la commozione e i suoi occhi si inumidirono di lacrime.
Poi riprese: "Io ebbi una percezione confusa di quanto era avvenuto: ma bastò perché perdessi il lume degli occhi: balzai come una furia nello zambecco roteando la spada che guizzava, scendeva, atterrava come un fulmine.
Chi scampò ad essa, si gettò nelle onde, rigandole di sangue: mezz'ora dopo non avevamo più avversari. I miei compagni, cinque erano validi, uno solo ferito alla gamba, si diedero a vogare di lena, la gioia della vittoria avendo infuso in loro nuova forza; io mi gettai piangendo sulla povera Elisabetta che giaceva immobile, sanguinante, senza vita, in fondo alla barca. Rimorchiando lo zambecco, raggiungemmo la galea, dove ci aspettavano trepidando. Il nostro arrivo fu accolto con grandi grida di gioia: noi portati in trionfo; ma io non avevo l'animo di goderne, per il gran dolore che mi struggeva. Elisabetta non era ancora morta; l'adagiammo sopra alcune pelli e cercammo di apprestarle qualche rimedio.
Ella aprì gli occhi, mi guardò lungamente, e li richiuse: mi sembrò di vedere sulle sue labbra errare l'ombra di un sorriso, che mi aprì il cuore a una speranza. Cadeva la notte: la luna sorgeva dal mare, grande e rossa; le onde scintillavano; la galea filava al tonfo misurato dei remi. Elisabetta aveva perduto i sensi un'altra volta, ed io me ne stavo lì accanto, senza parola, guardandola col cuore stretto in una morsa. Oltre un miglio dall'isola di Zembra, Elisabetta riprese i sensi, e mormorò: "Muoio... Addio!"
Mi parve che le sue labbra esprimessero un desiderio; mi chinai piangendo e la baciai. Nessun bacio fu più casto e più doloroso. Ella spirò in quel bacio... Così ebbe fine un amore germogliato nell'ombra dell'harem, nutrito di desideri ardenti e di speranze, troncato tragicamente, santificato dalla castità della morte...
All'alba sbarcammo a Marsala. Cercammo i parenti di Elisabetta e consegnammo loro quel povero fiore, che il pallore e l'ineffabile mestizia della morte rendevano più bello. Diedi loro la cassetta coi gioielli di Elisabetta e cedetti ai marinai ogni mio diritto sui tunisini feriti e prigionieri, che essi avrebbero potuto vendere come schiavi. Io non presi per me che una ciocca di capelli della povera fanciulla e partii a piedi con la mia spada, per cercare padre Giovanni o padre Bonaventura. Quel primo fiore d'amore, e il suo doloroso morire m'avevano posto nel cuore un desiderio di affetti, che fino allora la vita errabonda e avventurosa e, forse più, l'inconsapevolezza di adolescente, non m'avevano fatto provare.
Infine, per quanto le mie origini fossero avvolte nel mistero, io avevo dovuto avere dei parenti, e forse ancora vivi; io dovevo essere qualcuno, per quanto i miei genitori mi avessero abbandonato.
Che vi racconterò ancora? Nelle campagne di Pietraperzia incappai in alcuni banditi, compagni del famoso Saltaleviti. Me ne liberai un po' con l'astuzia, un po' mandandone due a raggiungere il loro antico capo, assai dissimile da loro. Misi sottosopra tutto il territorio di Catania, di Messina, senza poter raccogliere altra notizia che una sola, che il padre Bonaventura si trovava a Palermo. A Messina indovinate un po' chi trovai sopra una galera del regno con la casacca dei galeotti? Quel tal Giuseppico sardo".
"Oh!" esclamò Coriolano della Floresta, aprendo gli occhi; "ne siete sicuro?"
"Come no! il malandrino mi riconobbe. Cominciò a gridare che io ero un brigante scappato dalle prigioni, che avevo una taglia addosso... Egli era sulla nave, io sulla banchina; non potevo accopparlo. Si fece gente: dovetti allontanarmi; che dico? Dovetti fuggire per non cadere in mano dei birri e cacciarmi in qualche nuovo ginepraio. Uscendo da Porta Imperiale per il duomo, comprai da un contadino un cavallo, che forse aveva più anni di Matusalemme, e ripresi la strada dei monti. Per abbreviare, stetti alcuni mesi al servizio della città di Randazzo, a capo di una compagnia di arme, per liberarla dai banditi che infestavano quei boschi; ma non era mestiere per me e un bel giorno piantai tutti e me ne partii con la mia spada e due pani nelle bisacce. A Girgenti, in un giuoco del toro, scesi sull'arena, ammazzai la bestia inferocita, che aveva già sventrato uno sciocco, e fui portato in trionfo. Questa vittoria mi procurò una avventura con una dama; l'avventura mi tirò addosso inimicizie, fui aggredito di notte, ebbi un duello, e siccome si trattava di persone potenti, che avevano messo in moto l'avvocato fiscale, il vescovo, l'istruttore delle armi, i giurati, dovetti andarmene. Andavo alla ventura, un po' Orlando, un po' don Chisciotte; ritornai a Marsala, e volli pagare un tributo alla memoria di Elisabetta... Mi ammalai di febbre e fui curato in un convento ad Alcamo... Finalmente, col mio vecchio cavallo al quale m'ero affezionato con la mia spada così fedele, me ne venni a Palermo a cercare del padre Bonaventura.
Ho saputo da lui chi fu mia madre; dolce e santa creatura, morta come una martire; ignoro chi sia mio padre. Un patrizio di gran nome, a quanto pare... Non importa. Il gran nome e non lo redime dal doppio delitto di avere messo me al mondo e di avere... abbandonato mia madre.
E vivo? E morto? Non lo so. Ma padre Bonaventura lo sa, e non crede di rivelare questo segreto; nè io voglio fare forza sul suo animo. Se tace vuol dire che non può infrangere il segreto: io devo rispettarlo: del resto è meglio che lo ignori. Non potrei amare quell'uomo, perché si ribella quel vivo senso di giustizia che c'è in fondo al mio spirito. Cosicchè io rimango quel che sono: un senza nome. Qualche illusione mi era balenata nella fantasia, ma i fatti reali si sono affrettati a farla dileguare ben presto. Andiamo! La vita non bisogna prenderla sul serio!...".
Tacque e restò un po' assorto: la espressione di profonda amarezza che gli dipingeva il volto, contrastava con le ultime parole e col sorriso delle labbra.
Coriolano gli domandò: "Che cosa contate di fare, adesso?"
"Supplicare Sua Maestà che mi prenda nelle sue guardie. È un re che fa volentieri la guerra: ed ecco delle probabili occasioni per farmi spaccare la testa..."
Coriolano sorrise: "Più tardi che mai!" disse e, alzatosi, aggiunse: "Qui potete stare quanto volete, e disponete di tutto, senza complimenti. Fate conto di avere trovato la vostra casa. Buona notte."