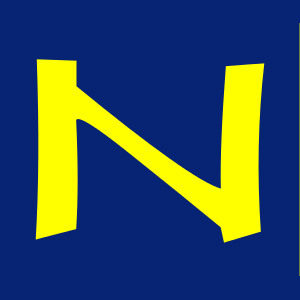Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte prima, capitolo 21
| Italiano | English |
Ella partiva perché soffriva, perché voleva trovarsi sola e sfogare il suo dispetto e partiva con quel vanesio, perché credeva, attraverso Coriolano, di esercitare una vendetta, una rappresaglia contro Blasco. Disse a don Raimondo che si sentiva un po' male, che tornava a casa perché la folla le dava il capogiro; lui rimanesse pure: gli avrebbe rimandato la carrozza.
"Non occorre, basta la portantina. Mandatemi la portantina."
Quando Coriolano la vide uscire col principe di Iraci, il suo volto espresse la più viva soddisfazione.
Si avvicinò al duca della Motta, con aria premurosa, dicendogli: "Ma che disdetta; mancherà alla festa il più bell'astro!..."
Don Raimondo si strinse nelle spalle, rassegnato.
"Piccoli disturbi. Sapete bene che le donne ne hanno sempre una provvista."
Egli non lasciava la festa; non già perché godesse della musica, del giuoco, della conversazione, ma perché tra gli invitati v'era il marchese di S. Tommaso, segretario del re, e v'erano anche il marchese Pallavicino, gran scudiero, il marchese di S. Giorgio gran maestro di casa, il marchese de la Pierre gran ciambellano e il marchese d'Augrogne gran maestro di cerimonie; tutti personaggi ben visti dal re, che avevano pratica col sovrano e che era utile avere per buoni amici in quei giorni. Don Raimondo parlava ora con l'uno ora con l'altro, serbando un contegno pieno dì dignità, ma nel tempo stesso premuroso e cortesemente servizievole. Faceva destramente cadere il discorso sulla legislazione siciliana, sulle prerogative del regno, illustrandole per mostrare la sua cultura giuridica e, indirettamente, la necessità di avvalersi dei suoi servizi.
A cena, sedette accanto al marchese di S. Tommaso, facendogli fra una portata e l'altra, amabilmente, la storia delle varie famiglie nobili, dei diritti che ciascuna vantava, delle consuetudini, delle condizioni delle campagne e della sicurezza pubblica. Calmo, freddo, ragionatore, logico, inflessibile nei giudizi, faceva di tutto per far discoprire in sè un uomo di governo. Senza parere, dava in forma indiretta dei consigli al re sul modo di governare la Sicilia, e suggeriva dei modi per risolvere con onore la grave questione sorta con la Curia pontificia per un lievissimo incidente col vescovo di Lipari. Il papa aveva lanciato l'interdetto, e v'era gran commozione nel clero e un gran turbamento nelle coscienze. E tutto ciò per un pugno di ceci! Ma già era un pretesto per la Curia di Roma, la quale non tollerava, e da lungo tempo, che la chiesa di Sicilia fosse quasi autonoma, per la bolla di Urbano II, che creava i re di Sicilia legati apostolici...
Il marchese di S. Tommaso lo ascoltava con interesse, persuadendosi che il duca della Motta era un uomo da proporre a sua Maestà. Vittorio Amedeo aveva appunto raccomandato ai dignitari della sua Corte di studiare bene l'alta società, per potervi scegliere gli uomini nei quali porre la sua fiducia. Certamente il duca della Motta oltre che per la sua competenza negli affari, che gli veniva dalla pratica degli uffici, era di quelli da scegliere anche per la dottrina e per la dirittura della mente e quella specie di rigidità che dimostrava.
"Il regno ha bisogno di uomini energici e diritti. Il governo spagnolo ha lasciato una grande eredità di mali, che bisogna curare energicamente e violentemente... Sua Maestà saprà scegliere fra i suoi fedeli vassalli..." "Per me, sebbene valga poco, depongo la mia persona ai piedi del trono, perché sua Maestà ne disponga a suo piacere. Farò di tutto per il servizio del nostro Signore e per la prosperità del regno."
Dopo la mezzanotte, su un altare improvvisato nella grotta artificiale, il cappellano di casa celebrò le tre messe di rito e tutti le ascoltarono devotamente, con lo stomaco pieno, in quel sopore che succede a una lauta cena, ma col cuore compreso della dolce soddisfazione di sentirsi in pace con Domineddio, e di non trovare nessuna contraddizione fra l'epicureismo raffinato della vita e lo spiritualismo della religione.
Dopo la messa don Raimondo lasciò la festa, soddisfatto di sè e pregustando la gioia ambiziosa di nuove dignità che lo avrebbero posto più in alto di quello stesso principe del quale era stato ospite. Nel grande atrio, a piè dello scalone, trovò la sua portantina di cuoio nero, a grandi borchie dorate: una portantina austera, da magistrato. Si avvolse nell'ampio mantello, poggiò i piedi sullo scaldino che era posto in fondo alla portantina e ordinò di partire. La via era facile e semplice: dovevano percorrere la strada del Celso, piegare per quella della Guilla, e risalire diritto fino al Capo. Dieci minuti. Due volanti precedevano con le torce; i portantini erano robusti e svelti, e andavano di buon passo. Le strade erano deserte; ma le case avevano qua e là finestre illuminate, e nel silenzio notturno si udiva l'acciottolio dei piatti mescolarsi a risa e a canti.
Di quando in quando squillavano le campane di una chiesa.
I portantini avevano oltrepassato la chiesa della commenda di S. Giovanni; al lume delle torce, i gatti randagi fuggivano rapidamente, lungo i muri; qualche cane ringhiava.
Presso il cancello della chiesa di S. Maria due ubriachi, barcollando, attraversarono il passo dei volanti, cadendo quasi loro addosso: i volanti li respinsero, ma quelli, come inviperiti dall'urto, si gettarono contro i volanti con male parole. I portantini dovettero rallentare il passo.
"Che cos'è?" domandò don Raimondo sporgendo il capo.
"Due ubriachi, Eccellenza," rispose uno dei portantini.
"Scacciateli e andiamo."
Ma la portantina non si mosse. I due volanti in un attimo erano stati gettati a terra e ridotti all'impotenza e i due portantini avevano creduto di correre in loro soccorso. Don Raimondo stupito e crucciato sporse un'altra volta il capo, ma ebbe appena il tempo di percepire una scena confusa di corpi rovesciati fra altri corpi e un balenio d'armi, che sentì una lama fredda e acuta, pungergli il collo, e una voce minacciosa dirgli: "Non una parola, o sei morto! ..."
Lo spavento, più che l'ingiunzione gli tolse la parola. La portantina era circondata da uomini mascherati e intabarrati, armati di pugnali e di pistole: i servi, colti alla sprovvista, atterrati, legati, imbavagliati erano trasportati via da altri uomini; egli era solo, i difeso, in balia di quegli esseri misteriosi.
Un nome che sonava terrore, gli salì sulle labbra, ma non osò pronunciarlo, o non potè: "I Beati Paoli!...".
"Non vi sarà torto un capello" gli disse colui che aveva parlato, "se non direte una sillaba, e se non farete la menoma resistenza."
"Ma che cosa volete da me?" balbettò don Raimondo con un filo di voce.
"Lo saprete. Intanto ubbidite."
Non c'era da fare resistenza. Quell'uomo, tratto dal seno un gran fazzoletto di seta, gli bendò gli occhi strettamente: con una funicella gli legò le braccia dietro le reni: lo ricacciò sul sedile, e ripetè:
"Siete avvertito. Guai a voi se gridate; non compireste il grido."
Don Raimondo sentì sollevare la portantina che riprese la via con maggiore celerità. Dove lo portavano? Avvertì che svoltava ora a destra, ora a sinistra, ma non arrivava a comprendere quali vicoli percorresse, in quel quartiere che egli pur conosceva perfettamente.
Quindici minuti dopo la portantina si fermò.
Quella stessa voce gli disse: "Alzatevi."
Nel tempo stesso quattro mani lo strinsero per le braccia, guidandolo. Discese una scala, girò; poi si sentì sollevato di peso, portato un po' su e giù infine deposto sopra una sedia. Allora gli tolsero la benda.
Egli si trovava in una stanza, appena rischiarata da due lampade a olio, poste sopra un tavolino, sul quale stava un libro, un Cristo, un calamaio e della carta.
Dietro, intorno al tavolino, accanto e dietro a sè una dozzina di uomini, avvolti in mantelli neri, col capo coperto da un cappuccio, il volto mascherato, la mano armata di pugnale. Un gran silenzio regnava nella stanza. Don Raimondo sudava; dietro le maschere vedeva brillare pupille minacciose; le lame avevano delle vibrazioni nervose che le facevano balenare sinistramente.
"Duca della Motta," disse l'uomo che aveva parlato fino allora: "noi conosciamo i tuoi delitti."
Don Raimondo divenne più pallido.
"Noi conosciamo in che modo tu da semplice cavaliere, sei diventato duca e signore di un patrimonio che non ti apparteneva; noi, ascolta bene, sappiamo dove e perché è morta donna Aloisia, vedova di don Emanuele della Motta..."
Il duca ebbe un brivido di terrore.
"Sappiamo come e perché è morta Maddalena, assassinata da te e da un tuo servo..."
Don Raimondo si sentì venir meno.
Tentò una difesa; balbettò con voce soffocata: "Non è vero..."
"Taci" impose l'uomo misterioso "e pensa che qualche volta le tombe si aprono e gli accusatori vengono fuori. Noi abbiamo prove e testimoni. Bada, duca della Motta!"
"Non è vero!... non è vero!..." balbettò ancora una volta don Raimondo.
"Bisognerà dunque ricordarti i beveraggi di Peppa la Sarda?..."
Queste ultime parole fecero uscire di sè il duca della Motta; pallido come un morto, tremante, smarrito, potè a stento, fra il battere dei denti, spiccicare qualche parola.
"Chi siete?... Che volete?"
"Vedi dunque che abbiamo tanto in mano, da consegnare la tua testa al boia e inaugurare il nuovo regno con un grande atto di giustizia; ma non è il tempo!..."
Il boia!... La mannaia!... Don Raimondo si vide perduto; con un gemito, con la bocca stretta da uno spasimo delle mascelle ripetè: "Chi siete?... Che volete?..."
Chi erano dunque quegli uomini misteriosi che frugavano nel suo passato, e tenevano sospesa con un filo la scure del carnefice sopra il suo capo? Come sapevano tutto? Perché gli rievocavano quelle torbide notti di delitti?
"Chi siamo?" rispose l'uomo mascherato; "la giustizia; la vera giustizia, quella del popolo che non fallisce, perché non è pagata. Che cosa vogliamo? Impedirti di nuocere a della brava gente, e di compiere altre infamie..."
E rivoltosi a due uomini che stavano dietro a don Raimondo, ordinò: "Scioglietelo."
Quelli ubbidirono.
"Duca della Motta," riprese il capo "tu hai fatto arrestare e te nere in carcere, senza processo, senza giudizio, due brave persone, gettando nel dolore e nella disperazione una famiglia. Noi non siamo sordi alle grida di dolore dei poveretti. Non chiediamo altro da te, che una lettera al capitano di giustizia, per l'immediata scarcerazione di don Girolamo Ammirata e del suo nipotino."
Don Raimondo sospirò e si rinfrancò alquanto. Temeva di peggio; tuttavia obiettò: "Ma non dipende da me..."
"Il capitano di giustizia trattiene in carcere quei due poveretti unicamente per farti piacere. Scrivi."
Il tono non ammetteva replica; don Raimondo era in balia di uomini che possedevano tutte le armi per ucciderlo, e non chiedevano, infine, che una cosa ben lieve, offrire la quale non era poi, per lui, un grande sacrificio. Prese la penna, l'intinse e tirò a sè un foglio. Con sua meraviglia si accorse che era la carta che egli soleva adoperare; una carta un po' azzurrognola.
Scrisse, sebbene con la mano un po' tremante, e consegnò la lettera all'uomo mascherato. La lettera diceva così:
Ill'mo e Spett'mo sig. Capitano e amico veneratissimo,
"Oltremodo grato a V. S. per avere a mia preghiera fatto sostenere in carcere il signor don Girolamo Ammirata e il suo nipote, per la mancanza nota a V. S., vengo ora a pregarla, perché si degni rimetterli in libertà non sussistendo più le ragioni della loro prigionia, e ritenendo che la pena sofferta abbia soddisfatto il legittimo risentimento della mia casa.
Certo che V. S. accoglierà la mia preghiera, me le dichiaro riconoscentissimo e La prego di considerarmi sempre fra i suoi fedeli servitori".
Il Duca della Motta
"Sta bene:" disse l'uomo, "chiudila e suggellala."
Con uno stupore ancora più grande e quasi terrificante, don Raimondo si accorse che la cera e il sigillo erano i suoi.
Come si trovavano lì?
Con mano più tremante per la com mozione di quella scoperta, scrisse l'indirizzo.
All'Illustrissimo Signor
Il Sig. D. Raffaello Bellacera,
marchese di Regalmici
Capitan Giustiziere del Regno di Sicilia
Palermo.
Consegnò la lettera e aspettò, guardando con occhio sospettoso.
L'uomo mascherato riprese: "Vi ho detto che non vi sarebbe stato torto un capello, e mantengo la promessa; ma badate, signor duca, il menomo passo che voi farete, o per molestare don Girolamo Ammirata, o per mettervi sulle nostre tracce, vi costerà la vita e l'onore. Ora sapete quello che possiamo."
Gli dava del "voi" adesso, ma senza smettere il tono aspro e autoritario. Fece un segno a uno degli uomini mascherati.
"Bendatelo e riconducetelo."
Nuovamente don Raimondo fu bendato e legato e ricondotto per mille andirivieni, salendo e scendendo scale; si sentì riporre nella portantina, sollevare, trasportare. Dopo un po' di cammino, la portantina si fermò. Un uomo mascherato, senza fare motto sciolse la cordicella, tolse la benda e sparve. Don Raimondo vide una luce rossastra, si affacciò timidamente, vide i due volanti con le torce, e i due portantini riprendere le cinghie delle aste, come se nulla fosse accaduto.
Si ricacciò dentro mormorando coi denti serrati, in un impeto di collera contro i servi: "Vigliacchi, briganti!... vi licenzierò tutti!... Andiamo!"
Appena giunse a casa, corse nel suo studio; la sua cera, il suo sigillo erano lì, sopra un vassoio, accanto alla candela. Guardò intorno; le finestre erano serrate, non v'era la più lieve orma umana. Un tremore superstizioso lo colse; cadde sopra un seggiolone con la testa fra le mani, immerso in profondi e terribili pensieri.