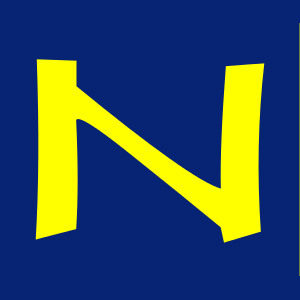Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte seconda, capitolo 1
| Italiano | English |
Le feste della coronazione erano passate: re Vittorio, per mostrare la sua benevolenza ai nuovi sudditi, mangiò due volte all'aperto, perché tutti potessero assistere al pranzo di Sua Maestà; ma, nè fece benedire la mensa a monsignor Barbara, che quale cappellano maggiore ne aveva il diritto, nè fece trinciare le carni all'illustrissimo don Antonio Maria Stella, marchese di Spaccaforno, siniscalco ereditario in virtù del privilegio concesso da re Giovanni nel 1462 alla sua famiglia. Omissioni, queste, che furono rilevate e cagionarono un certo malcontento nella nobiltà.
Due altre solennità erano avvenute nei primi mesi del 1714: il solenne ricevimento dell'ambasciatore di Malta, feudo del regno di Sicilia, e l'apertura del Parlamento. L'ambasciatore di Malta, che era il balio Spinola, venne a prestare l'omaggio dell'Ordine dei cavalieri di Malta, feudatari, con la rituale offerta di un falcone e fu ricevuto con gran pompa di cavalcate, carrozze, seguito; il Parlamento fu inaugurato dal re con un discorso della corona, letto, come di prammatica, dal protonotaro del regno. La vita cittadina rientrava nelle sue consuetudini. Eppure qualche novità non mancava. Un ordine del re prescriveva alle magistrature e al Senato di smettere il vestire alla spagnola e di adottare la moda piemontese; una prammatica proibiva severamente il lusso smodato della nobilità e i giuochi di azzardo; obbligava i signori a non tenere più di due cavalli o mule attaccati alla carrozza; di non avere più di due lacchè; di non sciupare l'oro nelle carrozze; di non portare troppi gioielli, nè trine e stoffe forestiere, salvo che in ricevimenti di corte. Erano tutte cose che destavano il malumore di una nobiltà abituata a una gara inimmaginabile di sfarzo e di magnificenza. Le dame, specialmente, ne erano furibonde.
Ma ben altro e di più grave momento turbò il regno. Il 12 febbraio apparve dietro la porta del Duomo e nei luoghi appositi una bolla pontificia, con la quale si dichiarava scomunicato il giudice della Monarchia ed Apostolica Legazia.
Era il primo atto di ostilità aperta, col quale la Curia romana moveva contro l'autonomia ecclesiastica della Sicilia, per togliere ai re il privilegio secolare. Giova raccontare brevemente le origini del fiero conflitto, che per parecchi anni gettò le coscienze nel turbamento e nel quale, sebbene in piccole proporzioni, parve rivivessero le antiche lotte fra la Chiesa e l'Impero.
Il conflitto ebbe la sua origine a Lipari, per due libbre e mezzo di ceci, del valore di otto grani, ossia di diciassette centesimi di moneta nostra.
Il vescovo di Lipari, don Nicolò Tedeschi, catanese, aveva mandato a vendere in piazza alcuni sacchi di ceci sui quali i catepani o maestri di piazza, ufficiali annonari, avevano chiesto ai commessi del vescovo il loro diritto di "mostra" - cioè una tassa di esercizio - che, nientemeno, ascendeva a due libbre e mezzo di ceci. I commessi si erano rifiutati, allegando che i ceci provenivano dalle decime che si pagavano al vescovo, e che le decime erano libere di aggravi. Ma i catapani non si arresero.
"Voi pagherete" dissero "come pagano tutti, e se non pagherete, vi piglieremo in pena e pagherete dieci volte tanto. Se monsignore non vuol pagare i diritti di piazza, venda i ceci nel vescovado; ma se manda a venderli in piazza, egli è un cittadino come tutti gli altri, e deve pagare. Su, sbrighiamoci!"
I commessi capirono che i catapani li avrebbero davvero presi in pena, cioè multati, e che la ribellione avrebbe loro tirato addosso qualche guaio; borbottarono qualche altra parola, e pagarono il diritto di "mostra".
Ma si recarono a raccontare il fatto a monsignor vescovo, che montò in furia, vedendo in esso un'offesa alla Chiesa. Chiamò il segretario e gli dettò una lettera fulminante contro i giurati della città di Lipari. Essi avevano offeso l'immunità della Chiesa, avevano commesso un sacrilegio, erano incorsi nelle pene canoniche, avevano violato la fede, avevano provocato l'ira del cielo, preparato alla città, al bando, terribili disastri...
I giurati per evitare noie, mandarono a chiamare i catapani e li persuasero a restituire i ceci; e i catapani per amor di pace, ritornarono in piazza dai commessi, e restituirono i ceci dicendo: "Ripesateli". Poteva bastare, non è vero? Ma nossignori; ringalluzzito, il vescovo stese un'altra epistola per i giurati della città, per rimproverarli e minacciarli non avendo essi riconosciuto i diritti della mensa vescovile con una dichiarazione formale, e poichè i giurati non intesero con pubblico atto riconoscere un diritto che non esisteva, monsignor vescovo, dopo quattro giorni, fece apparire alla porta della chiesa di Lipari un monitorio, col quale dichiarava che i catapani erano incorsi nella scomunica maggiore e dichiarava vitandi, - nientemeno! che significava che quanti li avvicinavano incorrevano anch'essi nella scomunica. I poveri catapani, non si aspettavano di essere scomunicati in quella guisa, per otto grani di ceci che avevano per giunta restituiti. Una legnata, via! ne ricevevano tante, qualche volta! l'avrebbero ricevuta anche allora, ma essere respinti dalla chiesa, dai sacramenti, essere fuggiti come e peggio di appestati, era cosa intollerabile. Ricorsero al giudice della Monarchia che li assolse.
E fu peggio. Il vescovo cominciò a strepitare contro il giudice della Monarchia, che aveva osato assolvere gli scomunicati sostenendo che Lipari non dipendeva dal regno di Sicilia, poichè Alfonso il Magnanimo l'aveva aggregata al regno di Napoli, e quindi era fuori della giurisdizione del giudice; e dimenticava che Filippo II l'aveva poi restituita alla Sicilia. Spedì il suo canonico segretario a Messina dove si trovava il Vicerè spagnolo, marchese di Balbases, per perorare la causa... dei ceci. Ma quando il Vicerè seppe di che cosa si trattava, perse la tramontana.
Senza tanti discorsi, fece pigliare il canonico e lo fece carcerare. Figurarsi monsignor vescovo! Se non scoppiò fu un miracolo. Noleggiò un bastimento e corse a Messina... Per far tremare il Vicerè? Forse lo pensava; ma il marchese di Balbases gli fece una lavata di capo, esortandolo a essere in avvenire più saggio, se non sentiva di dover essere più evangelico. Ah, povero fegato vescovile! La scarcerazione del canonico non valse a rimetterlo a posto. Giallo di dispetto, verde di bile, pallido di collera, rosso di vergogna, con tutti i colori sul volto, monsignor vescovo, giurando vendetta, celatamente s'imbarcò in una galea di Toscana che salpava, e se ne andò a Roma.
Allora (1712) continuava la guerra per la successione al trono di Spagna e il papa si barcamenava tra la Francia e l'Austria per stringersi al vincitore: quando fu sicuro che la casa di Borbone ne usciva malconcia, uscì di riserbo, e pensò di dare un colpo al tribunale della Monarchia. E mandò ai vescovi di Sicilia una lettera della Santa Congregazione della immunità, con la quale si annullava l'assoluzione data dal giudice della Monarchia, si riconfermava la scomunica dei catapani, e si faceva obbligo ai vescovi di affissare quella lettera nei luoghi soliti delle loro sedi.
A noi, oggi, questa pare cosa da riderci sopra; ma allora, no: era in verità una cosa gravissima, che feriva il regno in una delle sue prerogative. Con quella notificazione, infatti, si aboliva di fatto l'antico secolare privilegio dell'Apostolica Legazia, per la quale le chiese di Sicilia erano sottratte alla giurisdizione diretta della Curia Romana, e poste sotto quella del re, come legato apostolico di diritto, e per esso del giudice della Monarchia.
La lettera, datata il 16 gennaio 1712, giunse ai vescovi nel febbraio: alcuni di essi, prudenti come quelli di Palermo e di Monreale, la mandarono all'avvocato fiscale perché desse l'esecutoria, che fu negata; altri fecero presenti a Roma le conseguenze di quella inconsulta notificazione; altri invece la pubblicarono senz'altro, come quello di Catania. Ma i giurati della città la strapparono dalla porta della chiesa e la spedirono al Vicerè.
E allora anche il vescovo di Catania entrò in conflitto; e dopo di lui quello di Girgenti; e dietro a loro tutta una gran parte del clero, dimenticò di sè, invece di difendere l'indipendenza della chiesa di Sicilia, parteggiò per il papa: la questione, sorta per diciassette centesimi di ceci, diventò una lotta fra la potestà laica e l'ecclesiastica; fra lo Stato e la Chiesa. Il papa scomunicò il giudice della Monarchia, monsignor Miranda; interdisse le chiese di Catania e di Girgenti, inasprì il conflitto.
Re Vittorio Amedeo, succedendo alla monarchia spagnola, trovava il regno in queste condizioni. Cercò di venire ad accordi con la Curia pontificia, ma a Roma non si aveva che un obbiettivo: togliere alla corona di Sicilia il secolare privilegio. Ma il re non volle, nè doveva rinunciare al suo diritto. E la lotta entrò in una nuova fase, più acuta.
Vittorio chiamò intorno a sè i giuristi più dotti: naturalmente don Raimondo non fu risparmiato e non gli dispiacque.
Da quella notte terribile egli era vissuto quasi appartato, non rischiandosi di uscire di casa, sospettoso di tutti, ma covando feroci propositi di vendetta, e rodendosi per venire a capo di scoprire quella setta misteriosa che, lasciando da parte le lettere misteriose e simboliche, gli si era posta di fronte come una realtà vivente e terrificante.
Anche donna Gabriella era diventata silenziosa, torbida, irritabile. Nelle ore in cui si vedevano, a tavola, parevano due che si odiassero; tanta era la freddezza taciturna con la quale si trattavano e la cura di non guardarsi. Così erano trascorsi i primi mesi del 1714. Poi, siccome i Beati Paoli non avevano dato segno di vita, egli si era, se non rassicurato, sollevato alquanto: cosicchè l'invito reale lo trovava in migliori condizioni di spirito e valeva a infondergli delle, benchè lievi, speranze di poter esercitare sopra un capo più sicuro le sue vendette.
Matteo Lo Vecchio era ritornato da Girgenti, dove aveva dato mano forte all'avvocato fiscale, per cacciare via preti e frati che si mostravano più inclini a ubbidire a Roma che a Palermo. Tornato, era corso a riverire don Raimondo e a informarsi se nulla di nuovo fosse accaduto.
Per quanto don Raimondo si sforzasse per conservare la sua maschera fredda e impenetrabile, l'occhio fine e penetrante del birro lesse sul volto e nelle maniere del duca che gli nascondeva qualche cosa.
"Vostra Eccellenza ha bisogno di adoperarmi? Vuole che io riprenda la mia traccia?"
"È inutile. Ho la prova materiale che quell'Ammirata appartiene alla setta."
"Vostra Eccellenza ha la prova? Ma allora..."
Il birro lo guardò con stupore.
"Allora bisogna tacere e aspettare il momento opportuno."
Il birro fece una smorfia, ma chinò il capo. Pensò: "Qui sotto c'è un mistero; è evidente. Ma ne verrò a capo".
"Intanto non bisogna perderlo d'occhio."
"Non lo perderò..."
"E appurare dove la setta si raduna..."
"Per coglierli nel covo. Ho capito."
"Voi sapete di quel colpo di pistola tirato contro di me presso S. Matteo, nello scorso ottobre..."
"Lo so."
"Il colpevole non è stato ancora 'rintracciato e non si è potuto scoprire donde sia fuggito. Qualcuno deve avere la chiave di quel mistero..."
"Certamente."
"Eccovi dunque un altro campo da percorrere... Il reo è un antico servo infedele che io cacciai di casa. Egli non potè sottrarsi alla giustizia senza un protettore..."
"È evidente."
"Cercate dunque."
"Non sarà difficile. Troveremo il bandolo..."
Matteo Lo Vecchio per la strada faceva un ragionamento che non mancava di logica.
"Il duca ha la prova materiale che don Girolamo è un Beato Paolo; come l'abbia avuta non lo so ancora, ma non importa. Don Girolamo pare, anzi ne sono certo, l'ha contro il duca. Perché? Questo è da indagare. Per ora fissiamo questo punto: che don Girolamo, Beato Paolo, è un nemico del duca. Quel servitore tira una pistolettata al duca; scappa dentro la chiesa, e sparisce. Non è provato che sia divenuto uccello e sia uscito dalla cupola: qualcuno l'ha sottratto in modo misterioso. Chi armò il braccio di quel servitore deve essere quel medesimo che lo sottrasse; il quale, certo, stava dentro la chiesa per vedere l'esito del colpo. E costui non può essere che un nemico del duca; e, per il modo col quale fece sparire il servitore, sarà certamente uno della setta, e potrebbe anche essere don Girolamo Ammirata. Tutto ciò mi sembra così evidente, che non occorre ripensarci sopra. Occorre invece vedere donde e come quel servitore e il suo complice siano usciti dalla chiesa di S. Matteo. Dice che il capitano di città fece rovistare perfino sotto gli altari, perfino nella sepoltura dei confrati, e invano. Eppure è lì che si troverà la chiave del mistero. Se mi lasciano fare!... Ci vuole prudenza e pazienza. Disse il sorcio alla noce: dammi tempo e ti fo il buco!".
Il giorno dopo, aveva già elaborato il suo piano. Si rase accuratamente, si tinse destramente delle rughe sottili, si pose una parrucca femminina, indossò una veste nera un po' logora e si coperse il capo con un manto di lana nera, stinto e rattoppato. Si guardò allo specchio e sorrise di soddisfazione; non si riconobbe. Con un lungo rosario in mano, appoggiandosi a un bastoncello, curvo innanzi come una vecchierella acciaccosa, uscì di casa e si avviò di buon'ora alla chiesa di S. Matteo. Pareva una di quelle tante beghine che passano la vita nelle chiese e non diede nell'occhio a nessuno. Attraversando il vicolo nessuno lo riconobbe.
"Buon segno. Sono dunque sicuro" pensò.
Entrò in chiesa, e mentre si segnava con l'acqua benedetta guardò intorno, per scegliere un posto di osservazione che lo tenesse meno visibile. Si fermò nella seconda cappella di sinistra, e si mise a sedere, col rosario fra le dita, biascicando preghiere, tutto raccolto, ma non perdendo d'occhio coloro che entravano.
Uscì la messa all'altare del Crocifisso.
Matteo vi trascinò la sedia, camminando a piccoli passi stentatamente. Vi erano altri devoti, delle brave persone inginocchiate, che pregavano fervorosamente con un aspetto edificante. La gente andava e veniva; alcuni di quei devoti rimanevano in chiesa, passando da una cappella all'altra, come la gente che non trova altra occupazione nella vita, che quella di pregare. Vi rimasero fino a quasi mezzodì, ora in cui la chiesa, vuotatasi, venne chiusa.
Matteo Lo Vecchio uscì ultimo, dopo aver gettato una monetina di bronzo nella cassetta delle elemosine. Quel giorno nessuna cosa fissò la sua attenzione.
Tornò in chiesa il giorno dopo, e poi l'altro, passandovi mezza giornata a pregare e spiare, e rivedendo sempre gli stessi devoti andare da una cappella all'altra. Il terzo giorno, mezz'ora prima che si chiudesse la chiesa, vide entrare don Girolamo Ammirata.
Ebbe un sussulto di gioia e, chinato il volto in modo da nasconderlo, lo seguì con la coda dell'occhio.
Don Girolamo si avvicinò a due di quei devoti che pregavano inginocchiati alla cappella dell'Angelo Custode. La chiesa era quasi vuota.
Matteo si avvicinò trascinandosi, e s'inginocchiò nella vicina cappella della Madonna delle Grazie; udì don Girolamo recitare a mezza voce dei versetti di salmi e uno di quei devoti, con lo stesso tono, mettersi anche lui a recitare versetti come se avesse risposto.
Trasalì. Erano forse delle parole convenzionali?
Si strinse il manto nero intorno al volto, acuendo lo sguardo e l'udito, ma non potè cogliere neppure una parola.
Gli ultimi fedeli erano a poco a poco usciti dalla chiesa; non rimanevano ora che don Girolamo, i due devoti, Matteo Lo Vecchio.
Il birro vide che il sagrestano dopo avere scambiata una occhiata con don Girolamo, si avvicinava a lui. Finse di essere immerso nelle preghiere.
"Zia," gli disse il sagrestano "è ora di chiudere."
Matteo Lo Vecchio fece un gesto col capo; si alzò segnandosi e baciando da lontano con un gesto le immagini dei santi, e uscì. Capì che non poteva indugiarsi senza destare sospetti ma per quanto gli rincrescesse lasciare la chiesa, era soddisfatto.
"Ci siamo; - pensava. - Siamo sulla pista".
Continuò assiduo e devoto, nel suo travestimento, a frequentare la chiesa, dalle prime ore del mattino fino al momento della chiusura: ubbidendo dolcemente alle ingiunzioni del sagrestano, gettando la sua monetina di bronzo nella cassetta, baciando tutte le immagini da lontano, col solito gesto. Una mattina portò una candela al sagrestano perché l'accendesse all'altare della Madonna delle Grazie.
"È per una grazia che domando;" disse con una vocina in falsetto che fece ridere il sagrestano. "Una grazia che la Madonna Santissima deve farmi, per togliermi da una grande tribolazione."
Il sagrestano aveva cominciato a guardarlo con simpatia; non dubitando che fosse una buona vecchietta inoffensiva ed afflitta da un grande dolore, l'aveva presa quasi sotto la sua protezione, e non le diceva di uscire di chiesa se non quando doveva serrare la porta.
Per altre due volte Matteo Lo Vecchio vide venire don Girolamo Ammirata, lo vide confabulare in latino coi due devoti, e rimanere in chiesa, non ostante che il sagrestano invitasse lui ad uscire. Bisognava trovare il modo di cogliere i loro discorsi senza essere veduto, e di sapere quello che facessero in chiesa, dopo la sua uscita. Ma dove nascondersi?
Egli guardava i due piccoli organi, posti di qua e di là della tribuna, sopra le porte della sagrestia. Quei due organi, con la cantoria pensile di legno dorato potevano offrire un comodo nascondiglio; ma come salirvi? Le porticine mascherate nella parete erano chiuse, almeno supponeva, e d'altra parte se fossero state aperte bisognava cogliere il momento opportuno per potervi entrare senza essere veduto.
Cominciò a confondersi tra i fedeli, e a uscire di chiesa prima degli altri, per far perdere di vista la sua persona; sulle prime il sagrestano notò che la "vecchia" non si tratteneva più in chiesa, come una volta, e glielo domandò:
"Zia, se ne va così presto?"
"Ho trovato una buona signora, che mi dà a cucire un po' di biancheria."
"Era la grazia che chiedeva, zia?"
"Ah, no, figlio mio... quella è un'altra cosa; è una grande tribolazione..."
Finì che il sagrestano non gli badò più. Matteo Lo Vecchio intanto studiava, spiava, raccoglieva. Non aveva più dubbio che il sagrestano era della lega e che quei colli torti che parevano dei santoni, erano dei pezzi grossi della misteriosa società; e supponeva che quando la chiesa si chiudeva, essi confabulassero e concertassero i loro colpi. Quello era il covo. Bisognava spiare, avere nelle mani qualcuno dei loro segreti, e trovare il modo di acchiapparli, in un colpo, ed estirpare così le radici di quella pianta velenosa.
Per ogni buon fine non andò in chiesa, senza nascondere sotto le vesti un paio di pistole corte e un pugnale. Era risoluto ad andare fino in fondo, ed era bene premunirsi contro ogni sorpresa.
Una mattina che, per una festa, la chiesa era più affollata, Matteo si confuse tra i fedeli, mettendosi a sedere dalla parte della cappella del Crocifisso, a pochi passi dalla porticina dell'organo: c'era messa cantata e la porticina era socchiusa, perché su nella cantoria c'erano i musici. Matteo Lo Vecchio stette fino alla fine della funzione; seguì i celebranti nella sagrestia, offerse una candela per la Madonna delle Grazie; andò su e giù affaccendandosi, rassettando le sedie, come una serva, e aspettando che la chiesa si vuotasse. Ma intanto non perdeva d'occhio don Girolamo Ammirata e altri due devoti, che s'erano raccolti nella cappella di S. Anna, dove il sagrestano s'era indugiato un po', apparentemente per accendere una lampada.
La chiesa s'andava vuotando, ma nella saletta che precede la sagrestia, c'era ancora gente. Quella saletta era un ritrovo di inverno, alla messa del l'alba; serviva talvolta da rifugio a coloro che avevano bisogno di dirsi qualcuna di quelle cose che si dicono nell'intimità.
Matteo Lo Vecchio aspettò l'attimo in cui l'attenzione dei pochi fedeli era rivolta altrove e rapidamente spinse la porticina dell'organo, vi si cacciò dentro e la richiuse. Stette lì ad ascoltare un poco, se mai si fossero accorti di quelle manovre, col cuore palpitante. I minuti gli sembravano ore. Nessuno venne.
La chiesa si sprofondava in un silenzio sempre più alto, segno che si faceva sempre più deserta. Matteo sentì la voce del sagrestano, ammonire qualcuno che ancora s'indugiava.
"Adesso si chiude - pensò. - Se potessi vedere!"
Si tolse le scarpe, e piano, come un gatto, montò la scaletta, salì fino all'organo e si nascose dietro le canne. C'era qualche spazio fra una canna e l'altra; vi appoggiò l'occhio e impallidì. Vide il sagrestano fare un cenno verso l'organo e avvicinarsi.
Una bestemmia gli assommò sulla bocca. Sentì il sagrestano spingere la porticina, ma nessun passo sulla scaletta: anzi udì quasi subito serrare la porticina con una doppia mandata di chiave, e vide il sagrestano allontanarsi. Era salvo.
Don Girolamo, gli altri due santoni erano lì, dinanzi la cappella di S. Anna; ed erano le sole persone che ormai si trovavano in chiesa. Il sagrestano era andato a chiudere le tre porte: il rumore dei pesanti battenti rimbombò nella chiesa vuota.
"Hai chiuso?" domandò don Girolamo al sagrestano.
"Chiuso."
"Bene. Andiamo."
Andiamo? E dove andavano? Matteo Lo Vecchio vide i tre e il sagrestano attraversare la chiesa ed entrare nella sagrestia, per la porta che era sotto l'organo dove egli si era nascosto. Aspettò: certamente sarebbero usciti. Passarono delle ore, nessuno uscì dalla sagrestia, nessun rumore si udiva. Egli si affacciò timidamente dal la loggetta dell'organo; la chiesa era deserta e silenziosa. Allora scese e tentò la serratura della porta; con la lama del pugnale riuscì ad aprire. Tese l'orecchio verso la sagrestia; silenzio profondo. Si spinse cautamente, attraversò la saletta che precedeva la sagrestia, fermandosi a ogni passo, con l'orecchio intento, e man mano che procedeva, insieme con la sicurezza, si dipingeva sopra il suo volto un profondo stupore. Dov'erano dunque? Sulla soglia della sagrestia si fermò, addossandosi allo stipite esterno e sporse lentamente il capo: nessuno! Entrò allora risolutamente, con le mani sotto le vesti, sulle impugnature delle pistole. La sagrestia era vuota; le finestre chiuse internamente, e d'altronde erano difese da grosse inferriate.
"Diamine! diamine!... Spiriti non sono certo; nè si saranno trasformati in uccelli. Da una parte saranno certamente usciti: ma donde?".
Cominciò a percorrere per lungo e per largo la sagrestia, picchiando coi piedi sul pavimento, per sentire se mai in qualche punto risuonasse per vuoto: ma dava un suono opaco e uguale da per tutto. Dunque non c'era sotterraneo. Allora cominciò a passare in esame le pareti: anch'esse non davano suono; ma in gran parte erano coperte da grandi armadi di legno scolpito. Quegli armadi!... Erano tutti serrati; contenevano certamente i paramenti sacri, il vasellame e gli altri arredi sacri; tuttavia... Si diede a tastare e a tentare gli sportelli degli armadi, e a uno a uno, dopo avervi appoggiato l'orecchio; e giunse così a uno sportello al cui buco era attaccata una piccola chiave. L'aprì. L'armadio non aveva palchetti, e non conservava nulla. Matteo Lo Vecchio si fermò a guardare in silenzio, con le sopracciglia aggrottate, il cuore frettoloso. Poi con le mani si mise a percorrere il fondo dell'armadio, premendovi sopra.
A un tratto mandò un grido soffocato: un vano scuro si era aperto repentinamente e un corridoio nero si prolungava e si perdeva nell'oscurità.
Dove metteva? Quanto era lungo?
Matteo Lo Vecchio ebbe un istante di paura: o per lo meno dubitò. Si sarebbe avventurato in quel corridoio? E se non avesse poi ritrovato la via di tornare indietro? Porse l'orecchio; nessun rumore giungeva; aguzzò gli occhi, non si vedeva nulla. Fu l'incertezza di un istante. Prese una candela dal tavolo e l'accese a una lampada, trascinò una sedia, e la pose di traverso nel vano per impedire che si richiudesse, e deposta la veste femminile, per essere agile, col pugnale fra i denti e una pistola in pugno, entrò in quello stretto andito. La candela gli rischiarava il cammino: ma anche senza la candela egli avrebbe potuto percorrerlo, giacchè andava sempre in linea retta.
Camminò un pezzo senza fare rumore, soffermandosi per ascoltare, fino a che si trovò dinanzi a una porta. Si fermò, di là gli parve giungesse a lui un lieve ronzio. Spense la candela e si avvicinò, un piccolo foro gli rivelò la toppa; vi pose l'occhio; non vide nessuno, ma il ronzio era più distinto; veniva probabilmente da un'altra stanza, che non era quella che comunicava con la porta. Sforzò il suo udito a raccogliere qualche parola. E udì.
Una voce diceva: "Giuseppico è per noi..."
"Bisogna che si affrettino a venire," osservava un'altra voce.
"Andrea ha mandato a dire che verranno per la via di terra..."
"Purchè giungano prima che il duca parta col re..."
"Il viaggio è lungo: da Messina a qui ci vorranno tre o quattro giorni..."
"Così sia. Voi intanto, Zi' Rosario, tenete pronta la stanza; metteremo Giuseppico insieme con Peppa la Sarda... Tanto, erano buoni amici..."
Matteo Lo Vecchio registrò nel suo cervello tre nomi: Andrea, Giuseppico, Peppa e il duca. Sapeva chi era Andrea; non sapeva chi erano gli altri due; evidentemente però tutti e tre tramavano qualche cosa contro il duca, per cui Andrea era andato a Messina. La chiave doveva possederla il duca.
Non udendo più nulla, Matteo Lo Vecchio ritornò indietro, camminando nelle tenebre con abbastanza sicurezza; ritornò in sagrestia, tolse la seggiola e il vano si richiuse da sè. Era contento. Oltre agli indizi di quella trama, aveva scoperto la via segreta donde Andrea si era sottratto alla giustizia, e aveva la sicurezza che il sagrestano e quello Zi' Rosario, del quale aveva udito il nome, appartenevano alla setta.
Le sue conoscenze si allargavano; a poco a poco egli andava scoprendo quei famigerati e misteriosi Beati Paoli che empivano di terrore tutto il territorio di Palermo e ciò gli procurava dei fremiti di piacere, che lo confortavano dei morsi della fame che già si faceva sentire. Egli non aveva preveduto la possibilità di passare la notte in chiesa e non si era provveduto di una pagnotta; nè in chiesa avrebbe potuto trovare di che sfamarsi. Do vette fare di necessità virtù; e, risalito sull'organo, si acconciò sopra una sedia e, filosoficamente rassegnato, vi aspettò la notte e il sonno. Non poteva uscire che all'alba.
Le campane della prima messa lo svegliarono. S'aggiustò le vesti, si ricompose e si preparò a uscire dal suo nascondiglio. La prima messa viene recitata a San Matteo quando è ancora buio; la chiesa è quindi immersa nell'oscurità, rotta appena dinanzi all'altare al quale si celebra dai due ceri accesi. Non bisognava dunque che cogliere il momento in cui il sagrestano sarebbe stato occupato nel suo ufficio, per uscire e mescolarsi tra i fedeli; la cosa gli riuscì perfettamente e facilmente.
Finita la messa, il sagrestano vide la solita vecchia, inginocchiata dinanzi all'altare della Madonna delle Grazie.
"Ebbene, zia," domandò non senza meraviglia, "così presto oggi?"
"Non v'ho detto che ho avuto del lavoro? Oggi bisogna che sbrighi certa biancheria, e son venuta più presto..."
"Brava. E v'ha fatto la grazia la Madonna?"
"Aspetto. Ho fede."
Poco dopo Matteo Lo Vecchio uscì dalla chiesa, trascinandosi, inginocchiandosi davanti ad ogni immagine, indugiandosi al solito, ma in realtà con una grande impazienza nei piedi, che avrebbero voluto correre. Non gli parve l'ora di giungere a casa, deporre quel travestimento, riprendere il suo aspetto consueto, e recarsi al palazzo Albamonte.
Don Raimondo aveva fatto colazione allora allora ed era entrato nel suo studio a prendere delle carte da presentare al re. Sul volto di Matteo Lo Vecchio lesse che c'era qualche grande novità nell'aria.
"Ebbene?" gli domandò.
Matteo Lo Vecchio andò a chiudere la porta, e avvicinatosi al duca gli disse a voce bassa: "So donde è uscito quel tale Andrea, e dove s'è ricoverato."
"Eh?!" esclamò il duca sorpreso; "E allora..."
"Allora," riprese Matteo cogliendo a volo il pensiero di don Raimondo, "bisogna aspettare che ritorni, per acciuffarlo..."
"Dove è andato?"
"A Messina."
"A Messina? Perché? ..."
"A prendervi un certo Giuseppico."
Il duca diventò orribilmente pallido. Matteo lo osservò, fingendo di non accorgersi di quel pallore e continuò:
"Il quale Giuseppico andrà ad abitare con una donna che si chiama Peppa la Sarda!..."
Don Raimondo era spaventevole; domandò con voce alterata:
"A che scopo?"
"Perché l'uno e l'altra devono servire contro vostra Eccellenza..."
Il duca sudava freddo; balbettò:
"Chi ve l'ha detto?"
"L'ho udito io, con questi orecchi."
Voi? L'avete udito? Dove? Come?"
Don Raimondo tremava; temeva che Matteo Lo Vecchio fosse venuto a conoscenza del suo segreto, del quale non gli restava dubbio che altri fossero padroni. Il birro gli narrò brevemente come avesse intuito che fra il delitto tentato da Andrea e le persecuzioni di cui il duca era fatto segno, ci fosse una connessione, e che bisognava andare a cercare la chiave della fuga di Andrea dentro la chiesa di S. Matteo; e giù giù, dal suo travestimento fino alla scoperta del passaggio segreto. Don Raimondo tremando, agitato da mille dubbi, da mille sospetti, da mille terrori, si domandava per quali occulte ragioni don Girolamo Ammirata fosse venuto in possesso del suo segreto, e fosse andato rintracciando i suoi antichi complici; e chi fossero quegli altri, quello zi' Rosario. Sete di denaro? Ne avrebbe dato; li avrebbe arricchiti, se fossero andati a chiedergliene; ma non gliene avevano mai domandato. Vendetta? E di che? Non li aveva mai offesi!... Intanto ecco sorgere dall'ombra dove erano stati dimenticati quei due nomi terribili e accusatori: Giuseppico e Peppa la Sarda.
"Bisogna" disse "avere nelle mani costoro... subito..."
"Vostra Eccellenza dimentica d'aver fatto rilasciare don Girolamo... Occorre trovare una ragione per arrestarlo."
"Non c'è, forse? Non è complice di Andrea?..."
"E dunque bisogna cominciare dal mettere le mani addosso a quell'Andrea. E soprattutto..."
"Vostra Eccellenza dica..."
Don Raimondo parve raccogliersi un minuto; sul suo volto si vedeva chiaramente che egli faceva un grande sforzo. Disse: "Matteo Lo Vecchio, io posso fare la vostra fortuna..."
"Che dice vostra Eccellenza!..."
"Chiedete pure quello che volete: io vi prometto di contentarvi..."
"Vostra Eccellenza mi ordini quello che ho da fare, dal momento che le ho consacrato la mia virtù..."
"Ebbene, bisogna avere nelle mani quel Giuseppico, prima di tutto, innanzi tutto; averlo nelle mani: o vivo o morto."
"Non occorre altro. Oggi stesso parto per Termini.."
"Prendete: eccovi del denaro."
Prese da uno stipetto un rotolo di scudi e glielo diede, aggiungendo:
"Tornate verso mezzodì; vi farò avere dal gran Giustiziere del regno un ordine per tutti i capitani e gli ufficiali dei cavalleggeri e delle compagnie di armi, per darvi mano forte..."
"Benissimo. A mezzodì meno un quarto sarò qui, e partirò subito."