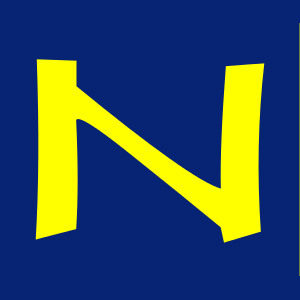Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte seconda, capitolo 9
| Italiano | English |
Blasco quella notte non dormì. Due pensieri gli martellavano il capo, diversi e quasi opposti: l'educanda e i discorsi nell'osteria. Chi era quell'educanda, che lo aveva guardato con tanta curiosità e simpatia ad un tempo? Lei lo aveva guardato e gli aveva sorriso come a persona nota, ma egli non l'aveva mai veduta; non aveva mai veduto educande, se non di lontano, nei giorni di festa quando esse popolavano i loro loggiati pensili sul Cassaro, o sulla Strada Nuova, ma attraverso le grate fitte come reti non le aveva vedute che come ombre bianche e nere; nè ricordava che qualcuna di quelle ombre avesse mai richiamato la sua attenzione.
Intanto, ora, l'immagine di lei gli era rimasta fitta nel cervello: egli la rivedeva, e confessava a se stesso che era una fanciulla assai bella e graziosa; ma chi era e in quale monastero si trovava?
Da questi pensieri passava agli altri che si destavano e si associavano a quel poco da lui udito nella bettola. Non metteva in dubbio che si trattasse di un complotto a danno di don Raimondo e che quegli uomini fossero dei Beati Paoli; e si tormentava con questa domanda: se, di fronte al pericolo che veramente minacciava la casa del duca della Motta, egli aveva fatto bene ad andarsene ed abbandonarlo. Di don Raimondo non si dava gran pensiero: era un uomo potente, e doveva sapersi difendere: e poi gli era stato sempre antipatico. Ma la duchessa, poteva egli lasciare la duchessa in balia di quei nemici misteriosi? L'immagine di donna Gabriella destava sempre un mesto rimpianto, ricordandogli ore deliziose che gli avevano dato l'illusione dell'amore. Una sensazione gli era rimasta nella carne, incancellabile, e talvolta acuta: e per essa si credeva e si sentiva come legato da certi obblighi verso donna Gabriella, obblighi di difesa e di protezione occulta e non compromettente.
Così passò la notte. Quando la mattina il servitore venne a dirgli che il cavallo era pronto, egli rispose:
"Levategli la sella e riportatelo alla mangiatoia."
"Vostra Eccellenza non parte più?" domandò stupito il servo.
"No... forse partirò domani..."
Coriolano non fu meno stupito del suo servitore. A colazione domandò al suo ospite: "Vi sentite male, forse?"
"No; ma vi dirò... Si tratta di un impegno... Mi darete ragione..."
Gli raccontò il suo incontro nella bettola, le parole udite, gli confidò i suoi sospetti e i suoi propositi.
"Devono essere quei maledetti Beati Paoli, è evidente! Ma sapete che è una cosa terribile? E non capisco come non riesca al governo di farne una retata e impiccarli... Se avessi venti uomini al mio comando, avrei certo il coraggio di purgare la città da questa lebbra!"
"Lo credete?" disse Coriolano col suo freddo e cortese sorriso.
"Eh, perdinci!" esclamò Blasco.
"Bisognerebbe prima di tutto sapere chi sono, quanti sono e dove sono..."
"Con delle buone spie..."
"Ve le espongono sulle forche, sotto il naso del pretore, come hanno fatto stanotte con Matteo Lo Vecchio, vuol dire col più acuto, più esperto, più capace e più temibile dei birri della città, e forse del regno! Ma non v'impacciate di queste cose, mio giovane amico, e mettetevi in testa che, se i Beati Paoli hanno stabilito di fare un tiro alla duchessa, il vostro valore, il vostro coraggio, il vostro sacrificio non giungeranno a impedire che essi compiano quello che hanno stabilito. Sono uomini che non indietreggiano, non si arrestano... Non vi mettete sulla loro strada."
"E perché no? Quello che mi dite è per me una allettativa maggiore per affrontarli..."
"Non li affronterete..."
"Perché?"
"Ve lo impediranno."
"Mi assassineranno?"
"Vi puniranno..."
"È la stessa cosa."
"No; il boia punisce e non assassina... Essi sono esecutori di giustizia."
"Giustizia tenebrosa!... Non mi va, Chi ha torti da vendicare, colpe da punire, se è persuaso di agire secondo giustizia, perché si nasconde nell'ombra?"
Coriolano alzò le spalle, come per dire che quella non era una domanda da fare, e rispose invece:
"Ma del resto, di che vi preoccupate voi? Nè il duca nè la duchessa della Motta corrono per ora alcun pericolo: essi partono dopodomani al seguito del re."
"Ah, come lo sapete?"
Appena disse queste parole, arrossì e aggiunse:
"Perdonate la mia indiscrezione..."
"Oh! non siete indiscreto... E una cosa che si diceva ieri notte a Palazzo."
"Meglio così, allora! E vi ringrazio di questa notizia che mi toglie un gran pensiero dalla mente. Partirò domani."
Coriolano gli domandò:
"Dove contate di passare la serata?"
"Non so... forse andrò a letto presto..."
"Oibò! Vi condurrò con me; andremo in casa Lungarini: c'è spettacolo e l'Unione dei Musici vi canta un'opera nuova. Ci state?"
"Ci sto."
"Allora stasera... se non volete trattenervi in casa fino a un'ora di notte, potremo vederci al palazzo Lungarini... Sapete dov'è?"
"Sì; vicino San Francesco."
"Appunto. Alla campana d'un'ora di notte, io vi aspetterò all'angolo del vicolo della Madonna la Bella."
"Non vi farò aspettare."
Blasco occupò la giornata un po' passeggiando, un po' sbadigliando, un po' pensando al suo viaggio, all'educanda, forse più a questa che a quello, e all'invito fattogli da Coriolano, al quale si meravigliava di essersi arreso senza alcuna obiezione. Egli non aveva voluto più andare ad alcuna conversazione aristocratica; eppure quella sera si sarebbe trovato in mezzo a tutta la nobiltà!
Il marchese di Lungarini di casa Abate, appassionato per gli spettacoli. musicali, aveva nel suo palazzo costruito un bel teatro, nel quale dava le opere più note, con un lusso di apparati e di vestiario veramente signorile: e con non minore signorilità invitava tutto il patriziato, al quale non dispiaceva di trovare uno svago nuovo e intellettuale. V'erano due o tre signori a Palermo che avevano in quel tempo dei teatri in casa; e, dopo il carnevale, quando taceva il teatro dell'Unione dei Musici, detto di S. Cecilia, aprivano le loro sale alla nobiltà, e vi facevano gustare le composizioni dei begli ingegni della città o dei maestri di Napoli.
Blasco era quasi sicuro di incontrarvi la duchessa della Motta e il principe di Iraci; forse anche si sarebbe trovato a fianco di don Raimondo: delle quali cose non si sentiva in verità, contento; anzi gli mettevano un certo malessere. Non era, certamente, imbarazzo, ma timore di dare luogo a qualche spiacevole incidente.
"Sarà meglio non andare - pensò; - aspetterò Coriolano sull'angolo del vicolo, ma per ringraziarlo e disimpegnarmi".
Qualche minuto prima che le campane richiamassero alla preghiera dei defunti, Blasco si avviò verso la strada che ancora porta il nome di Lungarini e S. Marco, dal palazzo che vi aveva questa nobile famiglia. Camminava lentamente, con la mano appoggiata alla elsa dello spadino, piuttosto come un ozioso, che non abbia nulla da fare, che come uno che si rechi a un appuntamento.
Dinanzi a lui, accanto, dietro era una processione di portantine, di carrozze, di servi con le torce, che illuminavano tutta la strada di San Francesco, o dei Cintorinai; grida di avviso, schioccate di fruste, si fondevano col frastuono delle ruote e lo scalpitio dei cavalli. Addossandosi lungo i muri, per non essere schiacciata, la plebe ammirava lo spettacolo...
Blasco riconobbe in una carrozza che gli passava accanto le livree del principe di Iraci.
E si avvide che quel riconoscimento, invece di ridestargli le prudenti riflessioni già fatte, gli metteva un certo pizzicorino di maligna curiosità, anzi qualche cosa che somigliava a quella provocazione che avrebbe voluto evitare.
Sull'angolo del vicoletto che, perduto l'antico battesimo di Salto d'Opezzinga, prendeva nome ora dall'immagine della Madonna la Bella, trovò Coriolano che l'aspettava.
"Benissimo!" gli disse il cavaliere della Floresta stendendogli la mano. "Son contento che siate venuto. Andiamo. Voi non potete supporre il piacere che io mi riprometto questa sera, al vedere questi musi!"
Il marchese di Lungarini era assai buon signore per fare un'accoglienza meno che cortese a Blasco che gli veniva presentato dal cavaliere della Floresta, ma non potè del tutto celare un certo imbarazzo e una certa preoccupazione. Blasco si accorse che egli gettò un rapido sguardo nella vasta sala e, seguendolo, scorse fra un gruppo di giovani gentiluomini il principe di Iraci, pallido, con gli occhi sfolgoranti, le narici frementi, tutto ira mal repressa nel volo e nel gesto. Allora sorrise, alzò la testa con aria di sfida, e, come se i mormorii e l'affettato disprezzo non lo riguardassero, percorse la sala ed entrò nel palazzo.
Era un salone secentesco, ornato di stucchi e affrescate, in fondo al quale si apriva l'arco della scena, i cui pilastri dipinti simulavano colonne di verde antico, statue marmoree e trofei. Da una parte si aprivano tre ampi balconi, dall'altra, di contro ai balconi, tre grandi porte; i due vani compresi fra esse erano coperti da alti specchi dalle cornici di stucco dorato. Da una grande lumiera pendente dal soffitto, e da una straordinaria quantità di candelabri infissi alle pareti, si diffondeva un mare di luce che faceva sfolgorare le sete, gli ori, le carni di una folla di dame, elegantissime nei busti serrati e lunghi come corazze, nelle gonne a rigonfio e a volanti, dai colori delicati. Tutte quelle dame cinguettavano, ed empivano la sala delle loro voci molli e tenere, come voleva la moda, e di piccole risa argentine come squilli di campanelli. Blasco gettò uno sguardo anche sulle signore: e non tardò a scorgere donna Gabriella. Il cuore gli diede un balzo, non potendo dominare la sua commozione: ma si calmò subito. Egli si domandò se gli conveniva andare a baciare la mano della nobile dama, o se doveva fingere di non accorgersene. Lo domandò anche a Coriolano della Floresta, che rispose tranquillamente.
"Non v'affrettate. Se il caso vi conduce vicino a lei, comportatevi da buon gentiluomo: intanto avrete il tempo di studiare il terreno."
L'orchestra cominciò ad accordare gli strumenti; un incrociarsi di strida di violini, di lamenti d'oboe, di ronzii di contrabbasso; un confondersi di gemiti d'arpa e pizzichi di chitarra. Le orchestre di quei tempi non erano così ricche di strumenti e così numerose di professori, come sono oggi. Pochi violini, un contrabbasso, un arpone, talvolta anche la chitarra, il mandolino fra gli strumenti a corda, l'oboe, il piffero, il flauto, fra gli strumenti a fiato: dieci o dodici professori componevano già un'orchestra ragguardevole, dalla quale i musicisti del tempo - e v'erano i classici della musica - sapevano cavare mirabili armonie.
Quando il "maestro di cappella" prese posto e con un foglio di carta ripiegato più volte sopra se stesso picchiò sullo spartito aperto sul leggio, si fece subito silenzio; tutti gli occhi si voltarono verso il palcoscenico; l'orchestra intonò le prime battute di una sinfonia e la tenda si aperse.
La scena rappresentava una spiaggia; da un canto si elevava il peristilio di una specie di tempio o basilica, che il pittore si era sbizzarrito a improntare al più schietto barocco. Di fronte a essa un altro edificio di indefinibile significazione. Questa scena rappresentava Cartagine ai tempi della sua fondatrice e il melodramma aveva per soggetto "Didone abbandonata", tema favorito da molti e che doveva più tardi allettare il Metastasio. I casi della bella regina innamorata e morta per amore attraevano una società piena di sentimentalità, di sospiri e di lacrime, nella quale le Didoni erano sì abbandonate, senza per questo uccidersi, ma più frequentemente abbandonavano. Il poeta aveva fatto di Didone una dama querula che si sfogava in "ohimè" e in "Numi"; e di Enea, il perfido mito Troiano, un cavaliere che si esprimeva per madrigali. C'era un terzo personaggio, Arbace, innamorato deluso che non osava nè dichiarare il suo amore a Didone, nè ammazzare Enea, pur giurando ai quattro venti fra lacrime e invocazioni solitarie il suo amore, e minacciando ferocemente e inutilmente il fortunato rivale; e un quarto personaggio, Anna, che aveva qualche cosa tra la nutrice, la sacerdotessa e la mezzana.
Le due donne, come voleva il buon costume che proibiva alle donne il palcoscenico, erano due uomini: due di quei disgraziati che con crudele offesa alla natura e all'umanità, si destinavano a cantare con voci femminili; voci così meravigliose, e nel tempo stesso così penetranti e suggestive, che rimescolavano il sangue, mettevano dei brividi; facevano fremere, piangere, sognare...
Il coro, con un costume fantastico, turchesco, cantava una specie di barcarola, che disponeva gli animi all'entrata in scena di Didone e di Anna. Didone cominciò a gorgheggiare un'aria sentimentale. Che le giovava essere regina? Che le giovava avere fondato una città? Ella era sola! forse in odio a Venere. Eppure, non aveva offerto sempre i suoi sacrifici alla dea? Anna le ricordò la fede giurata al morto marito, e allora si svolse un duetto fra le due donne e i due cantori gareggiarono meravigliosamente in trilli, gorgheggi, svolazzi, fioriture, che la sala ne fu commossa, rapita. Finito l'atto, scoppiarono gli applausi e incominciarono i commenti. Tutti lodavano la musica e la virtuosità dei cantanti; qualche meticoloso, che voleva cercare il pelo nell'uovo, fu sopraffatto.
"Eh già! se si trattasse di un maestro forestiero, si troverebbe tutto bello; perché è palermitano, eccoci subito alla ricerca dei difetti!..."
"Non per nulla siamo a Palermo!"
Blasco non prendeva alcun interesse alla musica; non pareva che la gustasse, o forse il suo cervello vagava altrove. Aveva veduto il principe di Iraci, addossato alla parete, quasi accanto alla sedia sulla quale era seduta donna Gabriella, chinarsi più volte e parlare con la duchessa, sorridendo: s'era accorto più d'una volta che i loro sguardi avevano accennato a lui e non dovette fare uno sforzo per capire che doveva essere lui l'oggetto dei loro discorsi.
Nel secondo atto si videro giungere le galere troiane e sbarcare Enea col seguito. Il popolo di Cartagine accorre, si formano dei gruppi di cori; Enea rende grazie agli dei e intanto ritorna Didone seguita dall'immancabile Anna. Didone concede ospitalità al troiano e alla sua gente e allora troiani e cartaginesi, per la gioia, intrecciano un balletto. Ma sul più bello ecco Arbace; il quale, dopo aver invano cercato di impietosire Didone, se la prende con Enea. Mettono mano alle spade. Enea atterra Arbace, gli toglie la spada e canta un'arietta per dire che appenderà quella spoglia al tempio di Venere sua genitrice. Didone vuole essere ministra di quell'offerta ed Enea galantemente le dà la spada. Il duetto nel quale Didone si sente avvampare di amore manda il pubblico in visibilio. Quando ella dice:
Ahimè! qual foco sento!
Ahimè! che il cor mi langue!
le dame si commuovono e qualcuna crede di doversi asciugare gli occhi. Arbace capisce di che si tratta; si batte l'anca e se ne va confuso, minacciando, mentre i coro lo schernisce.
Blasco guardava Gabriella e il principe di Iraci con un sorriso beffardo. Il principe era livido: il poeta pareva avesse composto quell'episodio per burlarsi di lui: la duchessa pareva un po' imbarazzata sotto lo sguardo di Blasco. Gli applausi sollevati dalla fine dell'atto la sottrassero al fastidio di quella situazione.
Nel terzo atto la catastrofe. Enea, rimproverato dai Numi, si affretta alla partenza. Didone, avutane notizia, investe l'eroe, il quale le dimostra la necessità di partire. Tale è il volere del fato e ciò gli impone il suo onore.
Dolce mio ben rassegnati
al gran voler del fato
io parto disperato
ma il cor mio lascio a te.
Ma Didone non sa che farsene di quel lascito ideale e prorompe in invettive, ricordando le avvenute nozze, le dolcezze dell'imeneo, e chiamandolo crudele, allattato da tigre ircana, non nato da Venere, ma dalle feroci Erinni. Tutte cose che non commuovono Enea. Il coro dei Cartaginesi piange di dolore: quello dei Troiani canta di gioia. Arbace torna e vorrebbe approfittare della circostanza, ma Didone si sfoga contro di lui chiamandolo buono a nulla, sopportatore di offese, senza onore ecc. ecc. Arbace giura vendetta e parte...
Blasco guardò un'altra volta nella sala: la duchessa era lì nervosa, ma il principe di Iraci non c'era più. Sorrise, e cercò Coriolano per comunicargli quella scoperta, ma il cavaliere della Floresta non c'era neppure lui. Pensò: "Sarà in fondo alla sala"; e seguì lo spettacolo che precipitava verso la fine. Arbace naturalmente non giunge in tempo, giacchè le galere troiane si sono già allontanate; torna deluso, mortificato a portare la notizia e infatti, in fondo alla scena si vedono passare delle barche, sulle quali Enea e i suoi compagni cantano un addio. Allora Didone, dopo avere scacciato Arbace e respinto Anna, sale sopra una pira apparecchiata per un sacrificio, e si trafigge; muore cantando deliziosamente come un usignuolo, tra gli applausi dell'uditorio, le lacrime delle dame, i commenti dei cavalieri.
Dei domestici in gran livrea servirono in ampi vassoi d'argento confetture e rinfreschi e la sala si empì di un gran chiacchierio. Soltanto donna Gabriella pareva nervosa e impaziente.
Blasco si avviò per uscire col proposito di cercare Coriolano, ma il cavaliere non c'era. Uscì nell'altra sala, non c'era neppure: tornò indietro verso il teatro, e quasi sulla porta s'incontrò con donna Gabriella. Le fece un profondo inchino, ma la duchessa gli passò dinanzi altera e sdegnosa, fingendo di non vederlo.
In quello sdegno c'era troppa ostentazione.