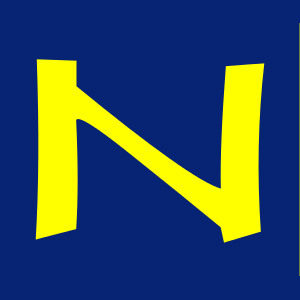Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte seconda, capitolo 13
| Italiano | English |
Donna Gabriella, cedendo alla volubilità della sua indole aveva ottenuto di restare ancora a Palermo, ma dopo la partenza del re se ne pentì. La vanità e l'ambizione presero il sopravvento sulla gelosia. In fondo che cosa gliene importava di Blasco? Ella non l'amava più, anzi l'odiava; e se aveva preso quella risoluzione improvvisa era stato per nuocere o meglio per fare un dispetto a Blasco, immaginando, troppo fervidamente, che la figliastra fosse innamorata del bel giovane. Ma a mente più serena, ora che il pentimento la rendeva crucciata contro se stessa, riconosceva che aveva lasciato correre troppo la fantasia e che aveva veduto dei giganti in ciò che era appena una ombra della sua immaginazione; e che le sue preoccupazioni erano sciocche. La figliastra era chiusa in un monastero; e se mai, ella aveva una maniera più sicura per impedire qualunque comunicazione fra lei e Blasco. Poteva condurla con sè a Torino, dove avrebbe potuto sposarla a qualche signore della Corte. Perché no? Come mai quest'idea non le era balenata prima nel cervello? Se ne adontava, ricercando il modo di riparare al malfatto, sebbene riconoscesse che non era facile riprendere un servizio, il sottrarsi al quale significava una rinuncia, da una parte, e una caduta in disgrazia dall'altra. Disgrazia?
Lo specchio che le stava dinanzi e dentro il quale ella si vedeva a metà pareva le dicesse di no. Ella sorrise. Non possedeva forse le armi più potenti per infrangere i divieti dell'etichetta come i rigori della austerità? per arrestare il braccio punitore come per schiudere la mano alle generosità? per dare e togliere? Non sapeva ella, forse, che anche i re più possenti si spogliavano di ogni regalità, del loro splendore divino dinanzi alle labbra frementi di una bocca amata?
Non occorreva che il pretesto, la ragione plausibile che la riavvicinasse a Corte o che, per lo meno, giustificasse la sua presenza a Messina.
Dopo l'alterco con don Raimondo, ella non aveva riveduto il marito neppure a tavola: don Raimondo desinava nel suo studio. Questa separazione i primi due giorni non le dispiacque, anzi le fece piacere, perché la lasciava più libera e le risparmiava il fastidio di possibili spiegazioni, ma al terzo giorno cominciò a indispettirla. Le sembrava come una specie di disprezzo che feriva il suo amor proprio.
Ma il quarto giorno don Raimondo, senza neppure annunciarlo, andò a sedere a tavola, al suo antico posto, come se nulla avesse interrotto le sue abitudini. Era pallidissimo e non mangiava, sebbene il suo volto rimanesse immobile sotto il freddo sorriso che gli agghiacciava la linea sottile delle labbra.
Donna Gabriella ne fu sorpresa, e in certo modo preoccupata: doveva essere accaduta qualche cosa che, probabilmente, il marito voleva confidarle e che non palesava per la presenza della servitù. Con un gesto licenziò il cameriere che li serviva, e domandò:
"Che cosa avete dunque? Siete pallido come un morto..."
Don Raimondo la guardò con asprezza, quasi con rancore e le rispose:
"Raccolgo i frutti del vostro tradimento."
"Il mio tradimento?"
Questa parola, che poteva prestarsi a varie interpretazioni, la fece arrossire, e pensò a molte cose.
"Che intendete dire?" domandò.
"Intendo dire che la vostra rinuncia ad accompagnare i sovrani, la vostra diserzione dal posto che con tanto studio e fra tante invidie, avevamo conquistato, ha lasciato il campo libero ai nostri nemici."
"Dite i vostri..."
"V'ingannate: non sarò soltanto io il colpito..."
"Sia pure; ma non giungo a concepire in che vi abbia potuto nuocere una risoluzione della quale, per il vostro buon nome (e sottolineò la parola) dovreste anzi essere lieto."
Il duca fece un impercettibile moto ironico con le spalle.
"Nel mondo vi sono cose che premono anche di più... Lo Stato e la vita."
Si interpose un istante di silenzio; don Raimondo riprese:
"Ero arrivato a mettere le mani sopra i miei nemici, li avevo scoperti ed ero quasi certo di arrivare sino in fondo ai loro disegni, ebbene, stamane un ordine del re sospende ogni interrogatorio, fino all'arrivo di altre disposizioni..."
"E che vuol dire ciò?"
"Vuol dire che mi si toglie dalle mani il processo per darlo ad altri..."
"E se coloro sono veramente colpevoli, di che temete?"
"E se..."
Tacque: la sua fronte si inumidì di sudore. Senza rispondere all'osservazione di donna Gabriella, quasi parlando a se stesso mormorò:
"Bisogna assolutamente che quell'ordine sia revocato; bisogna che nessuno si occupi di questo processo fuori di me; bisogna che quella donna non parli o che dica soltanto ciò che voglio io... Bisogna prima di tutto sapere il perché di quest'ordine e se io sono caduto in disgrazia... Giacchè se questo è avvenuto, e per cagione vostra, donna Gabriella, io vi giuro che saprò travolgere anche voi nella mia rovina. Non vi ho mai chiesto conto della vostra condotta; ho chiuso anche un occhio sulle vostre leggerezze... Oh! è inutile fingere con me. Non credete che io sia uno sciocco e che sia facile ingannarmi... Se io non ho suscitato uno scandalo, quando ne era il momento, gli è perché ho ritenuto più conveniente fingere... Ma ora avevo chiesto il vostro ausilio; avevo bisogno di una persona sicura che potesse avere il mio stesso interesse a serbare o aumentare il prestigio e la potenza della casa; e nessuno meglio di voi l'avrebbe potuto.
Il mio grado vi aveva posto a contatto dei sovrani; la vostra grazia ne guadagnava la simpatia: voi, la prima dama della Corte, io, il primo magistrato del regno. Nessuno avrebbe osato attaccarci. Io avrei potuto, coi mezzi di cui avrei disposto, distruggere quella setta scellerata che scava dei tranelli a ogni mio passo, e che... fabbrica le accuse più inverosimili contro di me... L'opera mia era incominciata: due del la setta erano stati impiccati; ora avevo fatto arrestare la moglie dell'Ammirata, uno dei capi, per averlo così nelle mani. Ma ecco repentinamente arrestarmisi il braccio. Perché? Chi si è frapposto? Chi ha provocato l'ordine del re? Se voi aveste accompagnato la regina, questo non sarebbe avvenuto; voi avreste potuto sventare la trama... Invece, per una bizza, per un capriccio inqualificabile e inesplicabile, voi avete perduto il vostro posto, io disarmato e dato in mano dei miei nemici..."
Si era alzato da tavola e passeggiava lentamente per la stanza. Donna Gabriella era rimasta pensierosa; l'ombra avvolgeva i suoi occhi neri perduti nel vuoto. Le parole di don Raimondo e più il terrore che non confessava ma che traspariva dal suo pallore, dallo sforzo per serbare una certa calma, dal sudore che gli bagnava la fronte, le destavano dei dubbi, le aprivano l'anima a paure ignote, a interrogazioni che ella per la prima volta si rivolgeva. Mai si era affacciata a investigare il passato e la condotta del marito; lo aveva conosciuto austero, quasi rigido e irreprensibile, ricco, rispettato; non aveva mai pensato che egli avesse potuto avere qualche cosa da celare o da temere. L'agitazione presente, la viva preoccupazione, l'angoscioso terrore di possibili eventi la spingevano ora in quel passato. Ella si domandava:
"Di chi ha paura? Perché ha paura? Quale segreto nasconde la sua vita?".
E guardandolo si sentì ora penetrare nelle vene un brivido gelato, apparendole sotto una bieca luce in un aspetto meduseo. Che cosa aveva quell'uomo? Che cosa c'era su quelle mani? Che stimmate sulla sua fronte? Provava anche lei quel senso di terrore indefinito. Con voce alterata e bassa, gli domandò:
"Che cosa c'è dunque di così terribile da farvi tremare tanto?"
Le parole furono queste, così vaghe, così indeterminate, ma il loro senso era più preciso e più penetrante ed egli lo intese. Fece uno sforzo sopra di sè e dominandosi rispose:
"Non vi ho mai detto nulla, perché in verità non valeva la pena turbare l'anima vostra, ma è tempo che voi sappiate ogni cosa..."
La sua voce aveva un tono quasi lugubre e soffocato.
"Orbene... Voi saprete che dopo la morte di mio fratello, mia cognata sparve col figliuolo, e che si trovò assassinata la cameriera Maddalena..."
"Sì, sì... ero ancora ragazzina, e mi pare di avere sentito che se ne fece un gran rumore."
"Coloro che la rapirono dovettero avere un complice nella servitù... Si trovò al balcone della camera una fune formata di fasce da neonato legate insieme. I rapinatori, e io non esito a dirli assassini, fuggirono di là.. Non potei scoprire mai, nè avere traccia di loro. Nè di mia cognata... E tuttavia ho speso due anni frugando dappertutto, nè solo a Palermo... Con tutto ciò mi si accusa... intendete bene, mi si accusa di essere stato io a sopprimere mia cognata e mio nipote per impadronirmi del patrimonio..."
Donna Gabriella guardò il marito, e tremò. Gli parve che in quel momento egli avesse veramente qualche cosa di belluino e di spaventevole.
Egli continuò:
"Vi giuro sul capo di mia figlia che io non so come sia sparita la duchessa della Motta e che cosa ne sia avvenuto." Non mentiva questa volta; perché in verità non aveva mai potuto entrare nel mistero di quella sparizione.
"E allora?" domandò donna Gabriella ancora sopraffatta dalle sue impressioni.
"Ebbene, c'è qualcuno che io non conosco, un nemico occulto e implacabile che, ignoro per quali fini, ha cercato di accumulare testimonianze contro di me, per dimostrare che io sono... un assassino e un usurpatore; delle lettere misteriose sono penetrate qui, in questa casa, non so come, malgrado le porte e le finestre chiuse; lettere piene di minacce, di allusioni, di insidie... Io sono circondato da ogni parte da nemici invisibili che si proclamano rivendicatori di ciò che io avrei usurpato, e che invece mi viene di diritto... Trovare testimoni, tra quella gente, non è difficile; forse i testimoni saranno gli assassini stessi... evidente che qualcuno ha interesse; qualcuno ambisce alla corona ducale dei della Motta. Chi? La chiave del mistero è quell'Ammirata... Ed egli ora mi sfugge. "Essi" sono arrivati fino al re... Quando un esercito di testimoni, che io non conosco, accumulerà le accuse più inverosimili, e coi raggiri ch'io so per esperienza si imbastisce un grave processo, come farò a discolparmi? Dove troverò le testimonianze in mio favore? È più facile fare apparire colpevole un uomo, che persuadere della sua innocenza... Ora sono in balia dei miei nemici!.."
Donna Gabriella si domandava mentalmente:
"È egli veramente uno scellerato? È una vittima? Se è uno scellerato, dovrò essere la sua complice? E se è vittima di raggiri, potrò abbandonarlo?".
"Quand'anche potessi mostrare la inverosimiglianza delle accuse, lo scandalo che si desterebbe non giustifica forse la mia preoccupazione? E non darebbe modo e agio agli invidiosi della nostra fortuna di moltiplicare a nostro danno tutto ciò che la malevolenza può suggerire?... E se (perché bisogna ammettere tutte le possibilità) la voce dell'innocenza non giungesse a distruggere le accuse invereconde, pensate voi quale rovina!"
Tremava, pallido, esterrefatto, quasi convulso, come se avesse veduto lampeggiare dinanzi agli occhi la mannaia. Faceva terrore e compassione a un tempo. Ma in quel momento nessuno di questi sentimenti vibrava nell'anima di donna Gabriella; ella pensava che in verità il suo stato, la sua ricchezza, quel dominio che esercitava nella società aristocratica, erano compromessi e che bisognava salvare il marito per conservare a sè tutte quelle condizioni che formavano la ragione della sua vita.
"Ditemi che cosa bisogna fare" disse.
"Riconquistare il favore regale. C'è un brigantino nel porto che salperà domani per Messina: il re percorre la strada di Catania, donde poi si recherà a Messina. A volere limitarsi a calcolare il tempo strettamente necessario, non potrà giungervi prima della fine del mese; voi invece arriverete fra due giorni e vi troverete all'ingresso..."
"Sta bene, partirò..."
"Grazie, donna Gabriella; pensate che sventando la trama non è me solo che sottraete alle insidie dei nemici, ma anche voi." Rimasta sola donna Gabriella si abbandonò al tumulto dei pensieri: riflettendo su quello che aveva udito e più su quello che aveva intuito e supposto, provava per don Raimondo una specie di ribrezzo e di terrore, e nel tempo stesso di disprezzo; egli le appariva crudele, e vile; innocente, non mostrava la forte fiducia nella sua innocenza.
Colpevole, non aveva il coraggio e l'audacia che talvolta danno un sapore estetico alla colpa medesima. Tremava e si raccomandava come una femminetta. Vile! vile! Oh sì, lei l'avrebbe salvato per sè, per il suo decoro; ma poi... non voleva più nulla in comune con un uomo, del quale ora conosceva tutta la miseria: ella sarebbe partita, avrebbe tentato di riconquistare il posto perduto, ma per suo tornaconto.
Don Raimondo intanto, col cuore sollevato per quello che aveva ottenuto, entrò nel suo studio, rivolgendo nel suo pensiero altri propositi. In fondo se gli era vietato per allora di procedere nel giudizio di una persona, non gli si toglievano quelle ampie facoltà di arrestare e l'ufficio di vicario; e d'altronde la signora Francesca ed Emanuele rimanevano serrati in Castello, il che in qualche modo rispondeva ai suoi disegni.
Mandò subito a chiamare Matteo Lo Vecchio, il solo che possedeva almeno una traccia sicura per scovare la setta tenebrosa, e mettere le mani addosso a quei capi sconosciuti che lo empivano di terrore.
"Ricapitoliamo: - pensava - donna Gabriella a Messina scoprirà donde e da chi è venuto questo colpo ultimo, e ne paralizzerà gli effetti. Se, come credo, spiegherà tutte le sue forze, sono sicurissimo. La moglie e il nipote di don Girolamo, in carcere, sono ostaggi preziosi per tirare in un tranello don Girolamo Ammirata; Matteo Lo Vecchio, poi, ha già sufficienti indizi per cogliere nella rete tutti gli altri. Ora è il momento di stringere e di agire con rapidità fulminea. Sicuro dalla parte del re, mi sento forte e audace... Ma il re bisogna isolarlo, bisogna isolarlo!".
E si domandò se non era il caso di accompagnare la moglie a Messina, e, con un atto di audacia, domandare al re le ragioni di quell'ordine che lo aveva riempito di tanto terrore. A mano a mano che rifletteva e studiava, riprendeva animo; il primo sgomento s'andava dileguando e il suo spirito, rinfrancandosi, penetrava nel campo dei disegni più arditi.
Fra questi pensieri lo trovò Matteo Lo Vecchio.
C'era voluto un bel po' perché Matteo Lo Vecchio, riavutosi dalla impiccagione che per poco non gli era costata la vita, si fosse trovato in grado di uscire di casa. L'odio, il dispetto, l'acre desiderio di vendetta insoddisfatto avevano aggiunto una nota di più alle sofferenze che gli segnavano il volto. Don Raimondo si stupì al vederlo, quasi irriconoscibile.
"Ebbene," gli disse "vi sentite in gamba?"
"Eccellenza, sì; sono patito, non è vero?
Ma non importa, questo forse mi giova..."
"Potete riprendere la campagna?..."
"L'ho già ripresa..."
"Ah! da quando?"
"Da due giorni..."
"Bravo".."
"Capirà, Eccellenza, che oltre al servizio del re e di vostra Eccellenza ora ho una partita da aggiustare, anche per conto mio..."
"Non vi do torto. E avete trovato qualche altra pista?"
"Forse. Ma occorre prudenza. Quei maledetti diavoli hanno occhi aperti e orecchie tese dappertutto e bisogna diffidare di noi stessi; per questo, vostra Eccellenza mi perdoni, non le dirò quello che ho scoperto; glielo dirò quando non avremo più paura che il nostro segreto sia scoperto e i nostri passi prevenuti."
"Sospettate?"
"Non certo di vostra Eccellenza; ma le pareti... So bene che senza avere occhi e orecchi vedono e odono."
Don Raimondo pensò al modo misterioso col quale penetravano in casa sua quelle lettere dense di simboli e minacce e si guardò intorno, colto da un senso di superstiziosa paura.
"Avete ragione," mormorò, "e non vi domando nulla..."
"Vostra Eccellenza ha ordini da impartirmi?"
"Sapete che il re mi ha nominato vicario generale per purgare il regno dai malfattori?"
"Lo so."
"Ho dunque pieni poteri..."
"Lo so; ma intanto le hanno impedito di interrogare la signora Francesca Ammirata..."
"Lo sapete?"
"Eccellenza, sì; e so anche donde viene il colpo."
"Ah!... è un segreto anche questo?"
"No, dal momento che è avvenuto. L'ordine del re è la conseguenza di una denunzia a carico di vostra Eccellenza, presentata al re, a Bagheria, dalla figlia del pittore Bongiovanni; quella sgualdrinella che pare cucita ai panni del nipote dell'Ammirata..."
Don Raimondo restò di stucco. Che c'entrava quella ragazza e che cosa conteneva quella denunzia? Balbettò:
"Che interesse poteva avere quella fanciulla?"
"Lei, personalmente, nulla; non era che la mano per presentare la denunzia; il braccio che la spingeva innanzi era quello dei Beati Paoli..."
"Come lo sapete?" domandò don Raimondo con voce alterata.
"Questo entra nel mio segreto, e glielo dirò dopo. Vostra Eccellenza, del resto, non si dia pensiero di nulla: so quello che debbo fare... soprattutto non bisogna lasciarsi sgomentare."
Il duca alzò il capo, arrossendo per la vergogna di essersi mostrato debole agli occhi del birro.
"Oh, no!" disse, sforzandosi di prendere un'aria spavalda.
"Così sta bene" approvò Matteo.
Prese commiato e se ne andò. Da due giorni, aveva detto, egli aveva ripreso la sua caccia e, non veduto, aveva visto arrestare la signora Francesca; ma quell'arresto aveva agli occhi suoi acuti rilevato nuove cose e indicato nuove piste. Nessuno aveva posto mente a un accattone lacero e sporco, che s'era seduto per terra dinanzi a una taverna, domandando l'elemosina agli avventori. Ma quel poveraccio, che pareva ridotto agli estremi della fame, teneva d'occhio la casa dell'Ammirata, quasi di faccia alla taverna. Così aveva veduto venire i birri e la lettiga e aveva veduto eseguire l'arresto. Poichè molta gente si era adunata, bisbigliando, anche lui, curioso come gli altri, si era avvicinato per vedere e intanto raccoglieva i giudizi popolari sull'arresto, che commoveva la contrada.
Due parole di gergo furbesco attrassero la sua attenzione. Fingendo di ritornare al suo posto, dinanzi alla taverna, si voltò a guardare, e vide due giovani che parevano garzoni di bottega; uno dei quali, dopo avere scambiato qualche altra parola, si era allontanato in fretta per la strada della Guilla; l'altro era entrato nella taverna.
"Bene, questo è il punto di ritrovo, - disse. Stiamo attenti...".
Entrò anche lui nella taverna e, sedutosi in un angolo, tratto dalla tasca un pezzo di pane, si fece portare un bicchiere di vino. Il garzone era andato a sedere fra un gruppo di giocatori, a guardare il giuoco, scambiando qualche parola ora con l'uno ora con l'altro. Passò così circa mezz'ora e vide entrare nella taverna l'altro garzone, che scambiò uno sguardo di intelligenza col primo.
Allora uscirono tutti e due sulla porta. Matteo pagò e uscì anche lui, passando dinanzi a loro con indifferenza, e udì un nome "don Antonino". Chi era costui? Per non dare sospetto si allontanò dalla taverna, per alcun poco, fermandosi di tanto in tanto col pretesto di chiedere la carità, per non perdere di vista i due giovani sospetti. Essi si separarono di nuovo e quello che si era allontanato la prima volta riprese la strada verso la Guilla.
"Bisogna seguirlo," disse. Gli tenne dietro sino all'Albergheria, dove il giovane si fermò dinanzi a un portoncino, e picchiò.
"Guarda, guarda - mormorò il birro non senza meraviglia; - ecco chi è don Antonino!... Ma benone!... Matteo mio, te l'ho detto, tu sei un uomo di genio. Ora aspettiamo un po' che cosa farà il sor don Antonino Bucolaro!...".
E infatti, poco dopo, il giovane uscì con un uomo tarchiato che all'aspetto pareva uno di quelli che a Palermo si chiamano di mezzo ceto, classe intermedia fra gli artigiani e la borghesia più elevata, e che comprendeva i piccoli commercianti, i sensali, i piccoli impiegati, i trafficanti. Essi entrarono in una rimessa lì accanto e ne uscirono poco dopo con uno di quei carrettelli a un sedile, che furono i progenitori dei carrozzini, dei chars-à-tane, o curriculi, al quale era attaccato un bel ciuco di Pantelleria alto come un mulo.
"Diamine! - pensò Matteo; vanno lontano. Dove? Come farò a seguirli".
Il carrettello gli passò dinanzi velocemente, e imboccò la strada di Porta Sant'Agata. Matteo lo seguì con gli occhi.
"Vanno fuori le porte. Ho capito. Vanno a portare la notizia a don Girolamo. è naturale. Dunque don Antonino sa dove sì trova, ed è anche lui della combriccola...".
Ma a un tratto il volto del birro s'illuminò di un lampo di gioia. Battendosi la fronte, egli esclamò:
"Benone! don Antonino ha un piccolo podere a Falsomiele. Ecco dunque dove propriamente è nascosto don Girolamo e probabilmente anche il suo compare Andrea!... Adesso aspettiamo che ritornino. Qui non bisogna abbandonare la posta".
Calcolò che per lo meno sarebbe passata un'ora e mezza buona, e che aveva il tempo di andare a casa a deporre il suo travestimento. D'altronde abitava a pochi passi. Avvenne come aveva preveduto; in meno di due ore don Antonino Bucolaro tornò con quel giovane, riportò il carretto nella rimessa e uscì di nuovo. E Matteo dietro, da lontano. Essi rifacevano la strada che conduceva nella piazzetta di San Cosmo, alla casa di don Girolamo Ammirata.
"O vanno a prendere qualche cosa che occorre al "razionale" - pensò il birro, - o vi aspettano qualcuno; ovvero...".
Ma i due montarono fino al piano di sopra e andarono in casa del Bongiovanni. Matteo Lo Vecchio si spinse fin verso il portoncino, tendendo l'orecchio. Dopo venti minuti sentì che si apriva una porta. Delle voci dissero:
"Domani mattina a dodici ore."
"Domani mattina."
Riconobbe fra quelle una fresca voce femminile.
"Ho capito" pensò, allontanandosi rapidamente per non farsi trovare. E aspettò che Antonino Bucolaro e il giovane uscissero e se ne andassero: poi lasciò passare qualche minuto, e andò anche lui a bussare al portoncino.
Era già sera e il cielo imbruniva. Matteo entrò nella casa del pittore, parlando con la cadenza dei provinciali.
"È qui che abita il pittore don Vincenzo Bongiovanni, non è vero?"
"Qui, proprio," gli rispose Pellegra che era andata ad aprirgli.
"Ne sono contento; e gli si può parlare?"
Il pittore, che era venuto fuori in quel punto, disse:
"Parlare a me? Eccomi... Si accomodi; senza complimenti. Quali comandi?"
"Vengo da... Baucina... sicuro, da Baucina e c'è da fare il ritratto del padre parroco, che è vecchio, e può da un momento all'altro morire, salvando noi e i nipoti, si capisce bene..."
"Sì, sì, capisco..."
"Avrebbero fretta. Quando si potrebbe cominciare? ..."
"Uhm!... domani no di certo... domani sono impegnato, vado a Bagheria."
Matteo sorrise acuì la sua attenzione.
"Ho capito; vuole godersi l'arrivo del re..."
"Precisamente: l'arrivo del re. Andrò con mia figlia e con qualche amico."
Mentalmente Matteo completò: "Con Antonino Bucolaro", e disse forte:
"Mi rincresce rimandare: sarà dunque per dopodomani; dopodomani condurrò con me il nipote del parroco e vi metterete d'accordo su tutto. Sta bene?"
"Benissimo, benissimo! ... Grazie, tanti riguardi."
Matteo sapeva già abbastanza: gli occorreva sapere soltanto che cosa andassero a fare a Bagheria. Certo non per vedere il re, che potevano vederlo passare da Porta di Vicari quella gita si collegava con l'altra a Falsomiele; c'era un concerto: quale?
La mattina dopo, Matteo, travestito da abate, a cavallo di un somarello, si fece trovare nei pressi del ponte dell'Ammiraglio e aspettò la carrettella di Antonino Bucolaro. Vide così consegnare la supplica e più tardi vide partire il corriere con l'ordine reale.
Egli dunque possedeva ora qualche altro filo e aveva la certezza del rifugio di don Girolamo. Per non destare sospetti e cogliere il razionale e Andrea nella rete, occorreva muovere quelle nuove fila: Pellegra e don Antonino Bucolaro. Per guadagnar la prima egli possedeva l'esca più pesante: l'amore personificato nelle sembianze di Emanuele; per guadagnare il secondo bisognava essere più addentro nei segreti della setta, della quale non conosceva che qualche segno e qualche parola, e di questa conoscenza non poteva fidarsi, temendo che, come era probabile, gli adepti gli si rivoltassero contro.
Da due giorni dunque spiava e studiava la vita e le abitudini di don An tonino, indagandone le relazioni, e cercando fra le tante quella che più gli conveniva. Ora, uscendo dal palazzo della Motta, ricapitolava tutte le sue indagini parendogli il tempo di dare il colpo decisivo.
Con quel travestimento da abate che lo rendeva irriconoscibile, e munito dell'ordine che gli dava ampie facoltà, egli si recò al Castello e, fattosi riconoscere dal comandante, ottenne di vedere la signora Ammirata. La trovò in una cella quasi buia, seduta sopra un piccolo sedile di pietra, murato alla parete umida e grommante. Il custode, fattolo entrare, richiuse la porta e allora Matteo Lo Vecchio, chinatosi, disse rapidamente a bassa voce:
"Vengo dal fondo di don Antonino..."
La signora Francesca trasalì, ma finse di non comprendere.
"Che don Antonino?"
"Toh! che vuol dire questa domanda? Don Antonino Bucolaro. necessario dirvi chi mi manda? Gli ho parlato... Sono un amico del cappellano del Castello, ma sono buon amico e fratello di don Antonino... Voi capite che qui non è facile entrare, ma a me non è difficile come agli altri... Ho detto che sono il vostro confessore; così abbiamo concertato con don Antonino... E così, son qua. Vostro marito mi manda a dirvi di stare di buon animo e non temere di nulla. Ha fatto consegnare al re, a Bagheria, una supplica da quella cara fanciulla, la figlia del pittore Bongiovanni... c'ero, io! Che colpo! ... La supplica ha fatto effetto... Come vedete nessun giudice è venuto a interrogarvi; tutto sospeso... Eh! ci è voluto un po' di lavoro; fra don Girolamo, Andrea, don Antonino Bucolaro e me, siamo riusciti!..."
La signora Francesca dapprima lo aveva ascoltato con diffidenza, ma a poco a poco s'era lasciata convincere: tutte quelle particolarità e la notizia di una supplica data al re, da Pellegra, e la sospensione del giudizio, tutte queste cose andavano via via conquistando la sua fiducia, e finì per credere pienamente che l'abate venisse da parte del marito. Allora gli domandò come l'aveva lasciato, e se gli aveva detto altro.
"Oh, sta benissimo!" rispose; "per quanto si possa star bene lontano dalla propria casa. Vi raccomanda il ragazzo e vuole sapere se avete qualche notizia da mandargli..."
La signora Francesca stette un minuto in dubbio, poi disse:
"Ecco, gli dica che, siccome fui arrestata inaspettatamente, non feci in tempo a mandare quelle carte a don Antonino... e sono ancora in casa. Bisognerebbe ritirarle."
"Sta bene: le carte sono ancora in casa, e bisognerebbe ritirarle. Prima di stasera egli lo saprà. E adesso state allegra, io verrò a vedervi."
Se ne andò gongolando. C'erano dunque delle carte importanti in casa, che quella brava signora non aveva fatto in tempo a trafugare. Bisognava vederle e, se mai, farle sparire.
Entrare nella casa non era una cosa difficile; bastava prendere l'impronta della serratura. Uscendo dal Castello dunque, per prima cosa, si munì di un po' di cera e, fingendo di andare dal pittore Bongiovanni, infilò risolutamente le scale. Poco dopo si recò da un ferrivecchi.
"Scusate. Ho perduto la chiave di casa, e non posso rientrare: ho preso l'impronta: vediamo un po' se ne avete una che si adatti."
Il ferrivecchi prese un grosso mazzo di chiavi arrugginite e ne trovò una quasi uguale: "Con due colpi di lima, questa qui andrà bene."
E detto fatto, la strinse in una morsa e vi lavorò intorno. Dopo mezz'ora l'abate ritornava con passo spedito nella piazzetta S. Cosmo ed entrava nella casa del razionale. Ma quando richiuse e sprangò l'uscio, una viva commozione gli fece battere il cuore con violenza.
Si fermò in mezzo alla stanza, guardando intorno.
"Vediamo un po': la signora Francesca non avrà avuto il tempo di portare via le chiavi dei cassetti... Lì c'è uno scrignetto. Non vorrei scassinarlo."
Cominciò a frugare in ogni parte; ceste, cassette... nulla. Cacciò le mani sotto i guanciali, nulla; poi sotto i materassi, nulla. Brancicò la lana e la stoppia dei materassi e , a un tratto mandò un grido: aveva toccato un corpo estraneo e sentito un fruscio di carta. Trasse un temperino, scucì l'involucro del materasso, vi cacciò la mano dentro, frugò, ne la cavò fuori con un fascicoletto di carte, ravvolto in un foglio e legato con una fettuccia.
"Deve essere questo" disse.
Sciolse la fettuccia, svolse il fascicolo, e tolto il primo foglio lesse: "Seduta del 21 novembre 1713, relazione di Andrea Lo Bianco, già servitore del fu illustrissimo signore il duca Emanuele Albamonte della Motta".
"Benissimo. Sentiamo."
A mano a mano che egli leggeva, lo stupore, la meraviglia la gioia si alternavano sul suo volto. Tolse il secondo foglio; il titolo diceva:
"Seduta del 1 marzo 1714: deposti del nominato Giuseppico già servo del signor don Raimondo attuale duca della Motta e di Peppa La Sarda, fattucchiera, con la testimonianza degli infrascritti".
Lesse anche queste carte, del cui contenuto sapeva già una parte per la confessione ricevuta dal sagrestano nelle carceri, ma trovandovi altri particolari che lo empivano di nuovo e più alto stupore. Poi prese un altro involto, ma, appena apertolo, gettò un grido di meraviglia e di spavento. La prima carta che gli venne sotto lo sguardo era un fogliettino quadrato, con lo stemma della parrocchia di S. Ippolito e sul quale fra le formule latine stampate si leggeva scritta a mano una data "Die XVI januari, 1698" e più giù un nome: "Emanuel de Albimontis generis clius olim Emanuelis ducis Mottae et illustris dominae Aloysiae Vigintirrilliae".
"Emanuele?" gridò il birro; "Emanuele? Lui il figlio del duca? Il ragazzo scomparso?... Sogno? Questo è il bollo della parrocchia, non c'è dubbio!... Ma come? Come?"
Tremava per la commozione di quella scoperta che gli poneva nelle mani la chiave della misteriosa persecuzione dei Beati Paoli e lo rendeva arbitro e padrone di tutto. Prese con la stessa febbrilità un'altra carta. Era l'atto di seppellimento di una tale Rosa Matranga, sepolta sotto l'altare maggiore della chiesa di S. Cristoforo al Capo.
"Chi è costei?" domandò a se stesso il birro, ripiegando la carta; ma nel ripiegarla vide sul rovescio un rigo di scrittura, lesse e gridò:
"Eh!... Lei!..."
Nota !he sotto questo nome è seppellita La signora duchessa della Motta".
Matteo Lo Vecchio stette un po' in silenzio, contemplando quelle carte, irresoluto e pensoso: indi le ravvolse nuovamente nel foglio, le rilegò con la fettuccia e se le pose in tasca.
"Il duca darebbe la vita per possedere queste carte, ma è meglio che le conservi io... staranno più sicure. Intanto sostituiamole".
Cercò dell'altra carta e ne fece un involto della stessa dimensione di quello sottratto e lo cacciò dentro il materasso. Trovò un ago e del filo in un cestino, ricucì l'involucro, rassettò accuratamente ogni cosa, e se ne andò tranquillamente; ma invece di avviarsi per la sua casa, si fermò al portone di casa Bucolaro e bussò.