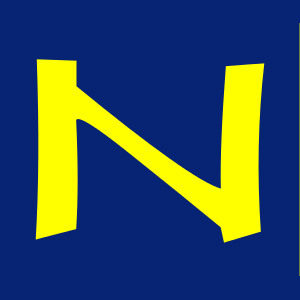Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte seconda, capitolo 24
| Italiano | English |
Don Raimondo aveva ripreso il processo contro la signora Francesca. Un nuovo ordine del re, "considerato che per la sicurezza del regno era necessario procedere alacremente, e che le in formazioni assunte e le spiegazioni date sull'opportunità di procedere contro detta signora Francesca erano sufficienti per rimetterla alla giustizia, riconfermando le potestà date al signor duca della Motta, quale vicario generale", gli commetteva la continuazione del processo. Era una prima vittoria, alla quale si riprometteva di farne seguire delle altre. Aveva cominciato con interrogatori tortuosi, avviluppando fra contraddizioni, sorprese, suggerimenti la povera donna, per tentare di strapparle quello che egli credeva il fondamento della persecuzione di cui era oggetto: e insisteva sul nome di Blasco da Castiglione, che era invece del tutto ignoto alla signora Francesca.
Ma le sue risposte negative non parevano sincere a don Raimondo, che ricorse alle minacce della tortura, e, per maggiore crudeltà le mostrò perfino i vari strumenti di tortura in uso in quei tempi: la corda, il cavalletto, le zeppe per l'unghia, il conio, la morsa, il braciere, l'imbuto; strumenti spaventevoli, ognuno dei quali gridava una storia di lacrime e di spasimi. La povera donna impallidì, tremò, si torse le mani per la disperazione, gridò:
"Ma perché? Perché? Ma io non so nulla!... Perché volete uccidere una povera donna che non ha commesso nulla? Ma non c'è dunque un Dio per commuovervi?..."
Queste parole disperate furono colte a volo dal torbido duca, che parve scandalizzarsene.
"Voi bestemmiate!... Voi dite proposizioni ereticali!... vi consegnerò al Sant'Offizio, perché ciò esula dalle mie competenze."
Era un pretesto. In verità egli non aveva trovato nulla per incriminare la signora Francesca e pronunciare una sentenza contro di lei e temeva che, appellandosi ella alla gran Corte criminale, questa la rimandasse assolta. Ma il Sant'Offizio? Chi aveva giurisdizione superiore a esso? E quale autorità poteva strappare una vittima alle segrete di quel terribile tribunale? E chi avrebbe messo in dubbio la denuncia di un uomo di qualità e così autorevole come il duca della Motta?
Formulò la sua accusa: e il giorno dopo la signora Francesca fu dai famuli e dalle guardie del Sant'Offizio trasportata dalle segrete di Castellamare a quelle dell'Inquisizione, dove altre sepolte vive giacevano vittime di superstiziose esagerazioni o di private vendette. Nulla fu più doloroso e straziante dell'uscita della signora Francesca dal Castello, dove pure rimaneva abbandonato e in balia di quei perfidi magistrati il povero Emanuele.
Ella si gettò in ginocchio, pregò, supplicò, gridò che era una buona cattolica, che adempiva a tutte le pratiche religiose, che non aveva mai bestemmiato: ma non le porsero orecchio. Fu tolta di peso, gettata in una portantina, imbavagliata perché non gridasse per la strada, e trasportata via.
Ella fu chiusa in una cella angusta senza finestre, salvo uno sportello che dava sopra un corridoio semibuio; un sedile di pietra fissato alla parete doveva servire anche da letto; in un canto una brocca di terracotta con dell'acqua puzzolente. Un buco in un angolo serviva di luogo immondo, e appestava la cella. Quando la povera donna giunse a riconoscere l'orrore della segreta, scoppiò in pianto e, buttatasi a sedere, esclamò:
"Oh Dio! Dio!... prendetemi con voi... Non ne posso più!..."
Emanuele era rimasto solo; fino a quel giorno egli non sapeva perché lo avessero chiuso nel Castello con la sua mamma adottiva, nè alcuno l'aveva interrogato. Don Raimondo, o per partito preso, o perché si riservava di sondare l'animo del giovanotto, dopo avere strappata qualche confessione alla signora Francesca, lo aveva quasi dimenticato. D'altronde egli aveva fatto arrestare il ragazzo per averlo come ostaggio, e obbligare così don Girolamo a presentarsi o lasciarsi prendere; e pensava che il ragazzo poteva fornirgli qualche indizio sul rifugio dello zio, sulle sue relazioni, ma non poteva certamente dire nulla di quel segreto che egli voleva scoprire.
Nondimeno, quando fu sicuro d'avere sepolto la signora Francesca nelle segrete del Sant'Offizio, egli volle interrogare il giovanotto.
Emanuele sapeva che il duca della Motta era il padrone di quei servi coi quali egli aveva avuto da dire e, senza conoscerlo, aveva concepito per lui una avversione che giungeva quasi all'odio. Il saperlo autore degli arresti e incaricato di procedere, aveva accresciuto quest'avversione. Quando si vide in presenza del duca, i suoi occhi sfolgorarono d'odio.
Il duca lo guardò col cipiglio del lupo che si trova dinanzi all'agnello.
"Come ti chiami?" gli domandò acerbamente.
"Perché devo dirvelo?" rispose il giovane guardandolo con fierezza.
"Perché te lo impongo."
"Voi mi avete fatto arrestare, dunque sapete come mi chiamo. inutile ripetervelo."
"Sai che sei un insolente?... E che potrei fartene pentire?"
Emanuele alzò le spalle con una espressione di disprezzo, che fece stringere le mascelle a don Raimondo.
"Ti farò frustare" digrignò.
"Credete di farmi paura?"
Don Raimondo fece un segno allo scrivano che lo assisteva, il quale uscì dalla sala, e rientrò poco dopo seguito da tre persone dall'aspetto ripugnante e feroce.
"Rispondi," disse don Raimondo, "o ti farò frustare."
Per tutta risposta Emanuele gli sputò in faccia: "Eccovi la mia risposta."
Il duca balzò in piedi coi pugni stretti, gli occhi iniettati di sangue:
"Frustatelo a sangue, perdinci!" gridò.
Quei tre manigoldi si lanciarono su Emanuele, che come un torello inferocito, prima che quelli gli avessero posto le mani addosso, con una capata nel petto mandò rotoloni il primo che gli si parò dìnanzi, e a pugni, a calci, a morsi, si difese dagli altri due. Per un minuto si vide quel gruppo indemoniato dibattersi per la stanza e occorse far entrare alcuni soldati, per poter legare le braccia e le gambe di Emanuele e rovesciarlo bocconi sopra un cavalletto.
"Fategli saltare la carne!" urlò don Raimondo.
Quelli denudarono il dorso del giovanotto e con una frusta cominciarono a percuoterlo a vicenda. Le fruste sibilavano come serpi, e lasciavano sulle carni dei segni rossi, rigonfi, che laceravano, strappavano. Emanuele si contorceva, muggiva di dolore, di rabbia, mordendo il legno al quale era legato e i suoi spasimi pareva gonfiassero di soddisfazione il cuore di don Raimondo. Giammai egli si era rivelato così feroce come in quel momento; la sua natura aveva abolito la maschera fredda e riservata di cui si copriva il volto e ad ogni colpo di frusta accompagnava il gesto del boia, con un incitamento:
"Forte! forte! forte!..."
Emanuele svenne. Lo scrivano osservò timidamente:
"Illustrissimo! il ragazzo muore."
Don Raimondo, richiamato da quelle parole, riprese il dominio di sè e fece un segno al boia di fermarsi.
"Basta. Riconducetelo nella sua cella."
I due aiutanti del boia, benchè abituati a dare la tortura, quella volta erano disgustati, perché mai forse avevano veduto nel magistrato un così acre desiderio di tormentare, e perché si trattava di un giovanotto; la freschezza degli anni induce sempre a maggiore pietà. Riportarono Emanuele con una certa cura e lo adagiarono bocconi sul pagliericcio della cella; e mentre era ancora svenuto, gli applicarono sulle piaghe un unguento e delle pezze di tela.
"Povero ragazzo!" mormorarono. Gli fecero annusare dell'aceto, gli umettarono con acqua le tempie, gliene spruzzarono sul volto. Emanuele gemette e aprì gli occhi, ma al vedere le figure dei due tormentatori, ignorando il pietoso ufficio che avevano allora compiuto, prese un aspetto truce che contrastava col pallore e con le contrazioni spasmodiche del volto.
Una febbre violenta lo assalì.
Intanto il racconto di quella tortura non necessaria, non imposta dal rito giuridico e che aveva tutti i caratteri di una vendetta, aveva commosso gli altri carcerati la maggior parte dei quali erano signori, ivi chiusi o per favoreggiamento di banditi, o per avere bastonato qualche caporonda, o per avere contratto matrimonio con donne di diversa condizione sociale, contro la volontà dei parenti.
Cominciarono a mormorare e a protestare col castellano, e a minacciare che avrebbero fatto ricorso al re contro l'inumanità di quel procedimento, perché non si doveva abbandonare un giovanotto in quelle condizioni. Era necessario un medico, anche per impedire che quella belva di vicario ripetesse la tortura.
Mercè queste proteste, Emanuele ebbe un medico, il quale indignato anche lui di quella barbarie, ordinò che il ragazzo fosse posto almeno in una cella migliore. Allora nelle prigioni non vi erano infermerie e i carcerati che si ammalavano erano trasportati in una sala apposita dell'Ospedale grande. Ma don Raimondo si oppose risolutamente a che Emanuele vi fosse portato, adducendo gravi ragioni di polizia e di sicurezza, note a lui, che non poteva nè doveva comunicare. In realtà egli temeva che all'Ospedale, dove non poteva disporre d una segregazione così rigorosa come nel Castello, i Beati Paoli con qualche colpo di mano liberassero il ragazzo e gli togliessero un ostaggio prezioso. Consentì solamente al suo trasporto in altra cella, che offrisse garanzie di sicurezza.
Emanuele fu curato con amore e con interesse dai custodi e dallo stesso castellano. Di tanto in tanto qualche signore otteneva di passare una oretta col ragazzo, al quale non mancavano doni di dolciumi e di frutta da parte dei cavalieri carcerati. Egli si rimise, ma il suo umore diventò cupo, il suo cuore chiuso: pareva che un pensiero assillante e tormentoso si fosse annidato nel suo cervello.
Un bel giorno uno dei cavalieri gli disse sottovoce:
"Sta' di buon animo; ho notizie di tuo zio... Egli manda a baciarti e a dirti di non perderti di coraggio, perché pensa a te."
"Grazie, signore, grazie della buona notizia..." mormorò Emanuele.
Don Girolamo era stato avvertito sia del passaggio della moglie nelle carceri del Sant'Offizio, cosa che lo aveva colpito di terrore, che della tortura inflitta ad Emanuele, per la quale aveva pianto di dolore e di collera.
In quelle sere le solite ombre misteriose a una, a due, apparivano e sparivano nel vicolo degli Orfani.