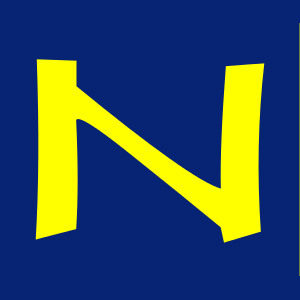Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte seconda, capitolo 25
| Italiano | English |
Matteo Lo Vecchio, ritornato da Messina, portò a don Raimondo della Motta la nuova della morte di Blasco, che parve al duca il coronamento della vittoria.
Volle sapere come era andata, e il birro cominciò dal suo viaggio pericoloso, narrando del tentativo dei compagni d'arme che l'avevano derubato "di tutto il suo", dell'arrivo a Messina, dei duelli di Blasco, della prigionia, e della cena misteriosa che gli aveva provocato una colica mortale.
"Non potei neppure rivederlo, prima di partire! Povero diavolo! Appena giunto sulla porta della Rocca, il custode mi diede l'annunzio che il signor Blasco era morto.
Ostentava un volto così compunto che il duca sorrise. Sorrise perché gli pareva ormai di non avere più nulla da temere; con la morte di Blasco mancava, secondo lui, il principale autore e motore della guerra mossagli dai Beati Paoli, che non vi avrebbero avuto più interesse e gli sarebbe stato più facile impadronirsi di don Girolamo e di Andrea, per vendicarsi di loro. Bisognava tendere loro qualche tranello; bisognava cattivarsi l'animo di qualcuno dei settari.
Un nome si presentò alla mente di Matteo Lo Vecchio: quello di Antonino Bucolaro. Non conoscendo altri affiliati e avendo sperimentato che egli non era stato gran che guardingo e prudente quando gli si era presentato travestito da abate, gli parve di poter fare affidamento sopra di lui.
Egli si mise dunque sulle piste del Bucolaro, per rendersi edotto delle sue abitudini, delle sue conoscenze e relazioni e don Raimondo fu tal mente sicuro di poter trionfare di quell'ultimo avanzo dei suoi nemici, che non stimò più necessario proseguire il processo contro Emanuele. A che pro? Era meglio dimenticare il giovanotto nelle segrete del Castello, come dimenticata era ormai la signora Francesca in quelle del Sant'Offizio.
Così trascorreva il tempo. Matteo Lo Vecchio ogni tanto veniva a fargli il resoconto di quello che aveva fatto, di quello che aveva veduto. Piccoli indizi. Pareva che i Beati Paoli si fossero dispersi o che le sconfitte patite e la paura di altre maggiori li avessero sgominati e obbligati ad abbandonare l'impresa.'
Nino Bucolaro era partito e non si sapeva per dove; don Girolamo Ammirata e Andrea erano spariti e forse avevano dovuto lasciare il regno. Infatti le squadriglie delle compagnie rurali, i birri del capitano di giustizia, i drappelli di soldati di fanteria e di cavalleria avevano percorso, frugato le campagne, i poderi, i colli, le grotte del territorio palermitano; non avevano potuto scoprire neppure un vestigio dei due latitanti o, come si diceva, "prosecuti".
Neppure uno dei soliti biglietti minacciosi era venuto a dare indizio a don Raimondo della esistenza della setta! Egli potè scrivere alla moglie che ormai tutto era tranquillo e che, se credeva e se non aveva nessun impegno con la Corte, poteva ritornare a Palermo, dove l'aspettava il Vicerè, che alla partenza non lontana di Vittorio Amedeo, avrebbe assunto il governo dell'isola.
Una sola persona aveva cercato di rompere la tranquillità del duca: Pellegra. La giovanetta, accompagnata dal padre che diventava sempre più scemo, osò presentarsi al duca ad intercedere per Emanuele. Da quando lo avevano arrestato, ella non aveva avuto più pace; si era prestata volentieri al tentativo della Bagheria, ma non ne aveva veduto alcun risultato. Era assai lontana dal supporre le ragioni vere per le quali la signora Francesca ed Emanuele fossero stati arrestati e immaginava che si trattasse ancora di quello incidente coi servi: credeva dunque che la lunga prigionia bastasse a soddisfare il duca della Motta, e che le sue preghiere potessero commuoverlo.
Il duca era nel suo solito studio, intento a leggere le relazioni dei capitani delle compagnie rurali e baronali, quando gli fu annunciata la visita del pittore Bongiovanni e immaginò subito quale sarebbe stato lo scopo della sua venuta. Pensò di spaventarlo, non appena il pittore sarebbe entrato.
Profondendosi in inchini e balbettando a ogni passo:
"Servo umilissimo di vostra Eccellenza!" egli entrò trascinandosi dietro Pellegra un po' timida e come paurosa.
Ma il duca lo investì con un cipiglio severo:
"Voi siete il pittore Bongiovanni? E voi, prescelto a dipingere i fatti della vita di sua Maestà, che Dio guardi, osate avere relazione e traffico coi malfattori?"
Il Bongiovanni guardò intontito non sapendo che dire. Balbettava:
"I malfattori? Dove sono i malfattori?..." Ma Pellegra, seguendo le sue supposizioni, osò una difesa:
"Eccellenza, è un giovanotto ancora... E poi fu provocato!..."
Don Raimondo le impose di tacere.
"Non parlo con te!... Vi dico solo: badate! Badate a voi! Vi manderò alla Vicaria; e te, ti chiuderò in un ritiro! Andate! Andate! Non ho niente da dirvi!..."
Il pittore guardava sgomento, non aspettandosi quella invettiva, e tremando all'idea di essere chiuso in carcere. Tirò la figlia per un braccio, dicendo:
"Andiamo... Sua Eccellenza è in collera... L'abbiamo offeso; certo l'abbiamo offeso!... Vostra Eccellenza perdoni... Io non volevo venire, è stata lei, mia figlia. Dice: Andiamo da sua Eccellenza... Ma no, dico: perché disturbare quel buon signore?... Vostra Eccellenza perdoni... perdoni!... Andiamo, Pellegra; domanda perdono anche tu... Il carcere, capisci? Il carcere! e per te il ritiro; il ritiro è meno peggio del carcere... Ma la Vicaria!... Oh è una cosa orribile!..."
Inchinandosi, tirandosi dietro la figliuola, uscì dallo studio. Pellegra lo seguì confusa, tentando qualche parola di scusa che si perdeva nel diluvio delle parole paterne; e così uscirono tutti e due, senza neppure avere avuto il tempo di dire una parola: nè osarono tentare più; che anzi, appena Pellegra accennava alla signora Francesca, don Vincenzo che aveva la mente piena di carceri e di paure cominciava a gridare, e le impediva di continuare.
"No! no! perdinci! Non voglio sentirne parlare!... Malfattori, capisci? Vicaria, capisci?... Eh, no, no! è meglio partire; meglio andarsene. Andremo a Roma, dove ci sono i tuoi parenti. Sì, sì, a Roma!..."
Pellegra lo seguiva piangendo, col volto basso. Ahimè, era l'ultima speranza che le rimaneva e quell'uomo gliela distruggeva; il povero Emanuele rimaneva in carcere e lei non lo avrebbe forse veduto mai più! Questo pensiero tormentoso la sforzava al pianto.
La gente che li incontrava, lui agitato dalla paura, dimenando le braccia con gesti da matto e gridando frasi sconclusionate, lei silenziosa e piangente, si fermava a guardarli; qualche donna del popolo commossa domandava:
"Che cosa le è accaduto, signorinella?..."
Ma il Bongiovanni rispondeva:
"La Vicaria, capite? La Vicaria e il ritiro... Oh! no; partirò per Roma... Sì, per Roma, per Roma, per Roma!"
Poco dopo il loro rientro a casa, un algozino venne a minacciare il pittore e la figliuola di non permettersi più di presentarsi a sua Eccellenza il duca della Motta, se non nel solo ed unico caso che avessero qualche notizia da dargli intorno a don Girolamo Ammirata. "Ah? fece il pittore come uno che non ha ben capito; "notizie? Ma sicuro, gliele darò... purchè non si parli di Vicaria!"
Pellegra ebbe paura; da quel giorno segregò il padre in casa sua e non gli permise di uscire solo. Nè don Raimondo lo vide più. Ma qualche volta, ora con un pretesto, ora con un altro, andava a trovarlo Matteo Lo Vecchio, il quale con racconti terribili di punizioni e agitando sempre lo spettro della prigione, della tortura, della morte, cercava di strappare dalla bocca del pittore qualche indizio.
Sforzi inutili. In realtà il pittore non sapeva nulla. Egli era diventato così scemo, che se dapprima don Girolamo aveva avuto poca fiducia in lui, ora non ne aveva più alcuna.
Verso gli ultimi di luglio donna Gabriella ritornò a Palermo. Il re si sarebbe trattenuto ancora un mese a Messina, poi, tornato per uno o due giorni nella capitale del regno, sarebbe ripartito per i suoi Stati di terraferma, lasciando in Sicilia un vicerè. Queste notizie, che già circolavano come dìcerie, riconfermate ora, producevano delusioni e malumori; il sogno di coloro che avevano creduto a un risorgimento della monarchia, e di vedere il re in quella reggia che, come diceva la lapide apposta nel portico del Duomo, aveva decorato della corona reale le auguste chiome, era svanito; giacchè era evidente che il sotto il principe sabaudo il regno rimaneva nelle condizioni politiche medesime in cui era stato sotto il dominio spagnolo, con questa differenza che allora, almeno era aggregato a una grande monarchia, a uno Stato per estensione, per potenza, per tradizione storica e politica più importante del regno di Sicilia; ora, invece, diventava una appendice di una monarchia di minor grado: il che feriva l'amor proprio dei Siciliani.
A questo davano esca i metodi di governo introdotti da Vittorio Amedeo, che erano più rigidi e miravano a migliorare le condizioni sociali e politiche e a mettere un freno alla strapotenza dei baroni; ma parvero violazioni di privilegi o, per lo meno, interruzioni di vecchie consuetudini camorristiche, entrate nei vari rami dell'amministrazione, che parevano o avevano assunto la forza di diritti, per il rispetto o la tolleranza dei governanti spagnoli, i quali andavano dicendo qua e là, a ogni menoma occasione, che si stava meglio sotto la corona di Spagna, e che la situazione si era mutata in peggio. Questa voce andava ridestando vecchi amori e formando una corrente di aspirazioni al vecchio regime.
Si aggiungevano le insinuazioni e le suggestioni del clero, per la questione con Roma, la quale diventava più aspra, e si dava a vedere come una guerra all'autorità spirituale del Papa e come un'offesa alla religione. Già l'interdetto pesava sopra due province, quelle di Catania e di Girgenti, dove nè si amministravano sacramenti, nè si celebravano funzioni religiose; i pochi preti e frati, che gelosi dell'antica autonomia della chiesa siciliana si tenevano fedeli allo Stato, erano colpiti dalla scomunica e il popolo non si accostava a loro; gli altri, la gran maggioranza, per tenersi ligi al Papa, erano esiliati e cacciati via dalle loro sedi, cosa che li faceva apparire come martiri e dava agio al clero di dimostrare come la Corte di Spagna si fosse comportata verso la Chiesa molto più ossequente della Corte piemontese.
Nei riguardi di questa, però non mancavano fautori: v'erano gli uomini nuovi; uomini di sapere, che avrebbero voluto rinnovare il vecchio e decrepito regno di Sicilia. Giacomo Longo, Nicolò Pensabene, Ignazio Perlongo, il marchese di Giarratana, Francesco d'Aguirre, Giambattista Caruso e altri, gelosi della preminenza dell'autorità civile nelle faccende dello Stato, erano fra questi: e v'erano gli ambiziosi, che miravano ad ascendere ai posti più alti e fra essi era don Raimondo Albamonte.
Donna Gabriella, di ritorno da Messina, aveva recato la bella promessa che il marchese di S. Tommaso aveva incluso il nome del duca fra quelli dei personaggi che il re aveva intenzione di condurre con sè a Torino.
Se di questa notizia don Raimondo fu lieto, non è da dire; seguire il re a Torino significava due cose: entrare nelle grazie della Corte, e quindi uffici di maggiore responsabilità; liberarsi, senza parere di fuggire, dalle possibili vessazioni dei Beati Paoli, dei quali sospettava e temeva il risorgere più violento e più pericoloso. Mai egli fu così gentile verso donna Gabriella, come quando apprese da lei questa notizia. Le strinse le mani e le disse che le era grato, e che ella era non soltanto la più bella dama del regno, ma anche la più fine e brillante diplomatica.
"Voi verrete a Torino con me ed eclisserete tutte le dame di quella capitale. Voglio comprarvi altre gioie e farò trasportare la vostra carrozza dorata e la vostra lettiga di gala..."
Donna Gabriella non rispose. Un lieve pallore le coperse il volto a questo annuncio. A Torino? Andare a Torino anche lei? Perché? Lei non era dama di Corte, e ora che aveva salvato, come credeva, il marito, che aveva allontanato il pericolo dalla sua casa, pensava di non avere più nulla a dividere con la Corte; nè aveva intenzione di diventare l'amante del marchese di S. Tommaso, lei che per un istante aveva sognato d'essere quasi la seconda regina di Sicilia! Altre idee erano entrate nel suo spirito mobile e contraddittorio: segrete aspirazioni, desideri occulti, tormentosi e acuti e forse quella partenza del marito entrava in quelle segrete aspirazioni, forse vedeva nella partenza di lui una liberazione: la liberazione da un pensiero cupo, grave e opprimente come un incubo. Dubbio, sospetto, ripugnanza: lei non poteva guardare il marito senza sentire dentro di sè tutti questi sentimenti ridestarsi e combattere.
Don Raimondo seguiva troppo il suo pensiero ambizioso, per accorgersi che la proposta non aveva destato nello animo della moglie alcuna gioia: interpretò il silenzio come accettazione o, in ogni modo, come sottomissione e da quel giorno cominciò a fare i preparativi per la partenza.
Vittorio Amedeo partì da Messina il 29 di agosto, per mare, con due galere, sette vascelli inglesi e quattro di Malta, e giunse a Palermo il 2 di settembre; il giorno innanzi era arrivato da Messina il conte Mattei da lui eletto Vicerè di Sicilia. Nè il vicerè, nè il re sbarcarono; il re scese a terra soltanto la mattina del 3 per udire la messa nella Cattedrale e tenere baciamano.
Due giorni dopo con una flotta di dodici vascelli, salutato dalla salva dei bastioni, partì.
Don Raimondo, nominato consultore di Sicilia nel consiglio del re di Torino, seguì il sovrano.
Prima di partire, nel congedarsi dal conte Mattei, gli espose quello che aveva fatto per distruggere la setta e concluse che vi erano ancora da prendere due affiliati: don Girolamo Ammirata e Andrea Lo Bianco. Gli indicava e gli raccomandava Matteo Lo Vecchio.
Egli partì solo; donna Gabriella, o finzione o realtà, si disse ammalata, e si rifiutò ostinatamente d'andare a Torino e minacciò di romperla. Don Raimondo ebbe paura e si contentò di una promessa vaga, e la lasciò a Palermo. La loro separazione non ebbe lacrime nè baci. Egli le raccomandò soltanto una cosa:
"Tenetevi vicino al Vicerè, dal momento che rimanete, e non tralasciate di spronarlo a proseguire le ricerche di quei malandrini. Voi sapete quanto ciò importi."