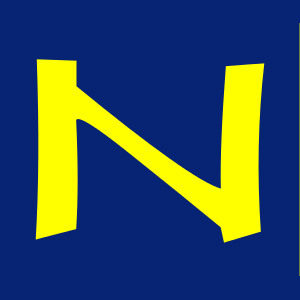Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte terza, capitolo 21
| Italiano | English |
Le monache del magnifico e nobile monastero di S. Caterina uscivano dal coro, dove avevano recitato l'uffizio della sera, quando vi giunse la carrozza di don Raimondo, non senza stupore della suora della ruota e della fattoria, o "Mamma". Sebbene nel monastero avesse due sorelle, maggiori di età, il duca della Motta non aveva la consuetudine di andarle a visitare spesso; salvo che nelle grandi solennità religiose o per qualche monacazione, egli non si vedeva mai nel parlatorio del monastero. La sua venuta, e più l'ora insolita, dovevano destare naturalmente lo stupore delle suore.
Egli pregò la suora, accorsa dietro le grate al suono del campanello, di pregare la signora madre badessa perché insieme con suor Clementina e suor Maria Rosaria - le sue sorelle - favorisse al parlatorio.
"Che cosa sarà mai?" esclamarono le tre suore spaventate, accorrendo.
Don Raimondo non si perdette in molte parole: dopo aver lodato il monastero e la saggezza della madre che lo governava e avere ricordato il pericolo corso dalla figliuola, libera per un vero miracolo della Vergine, pregò le suore che la trattenessero nel monastero fin da quella sera.
"È tornata qualche ora fa, ma non voglio tenerla in casa, nè ricondurla all'educandato di Montevergini: voglio che si consacri a Dio e prenda i voti, e non trovo migliore monastero di questo."
Violante non apriva bocca; pallida, col volto basso, lasciava scorrere in silenzio le lacrime; le ultime parole del padre le avevano dato una stretta dolorosa al cuore, ma non poteva fare altro che lacrimare e tacere. Un atto di ribellione a queste coercizioni, a queste violenze contro la volontà e la libertà individuale, in quei tempi non si sognava neppure e le fanciulle sapevano fin dalla loro tenera età di essere destinate al monastero.
Ella entrò quella notte nel chiostro, come forse le antiche vestali colpevoli entravano nella tomba. Suo padre non la baciò, non le disse una parola amorevole; duro, freddo, impassibile l'accompagnò sulla porta della clausura, la spinse nel vano apertosi e ritornò nella carrozza senza dare alcun segno di commozione.
Altre idee, per lui assai più gravi, preoccupavano l'anima sua. Le allusioni e la ribellione di donna Gabriella gli rivelavano un nuovo nemico, temibile non solo perché egli medesimo, sebbene negandone la verità, aveva confessato di quali colpe i suoi occulti nemici lo accusavano, ma anche perché capiva da quale sentimento ella fosse stata mossa: il sentimento che più d'ogni altro toglie a una donna la percezione della realtà e il dominio della coscienza: la gelosia. Che cosa erano per lei gli interessi della famiglia, il decoro del nome, dinanzi al tarlo che le rodeva il cuore? E risalendo all'origine, sentiva crescersi l'odio contro Blasco.
Obbligo verso di lui, per avergli ricondotta libera la figliuola? Non ne sentiva alcuno: la loro libertà non era che il prezzo di una convenzione le sue donne egli le aveva comprate in cambio dei suoi nemici. Ma del resto, pensava, a quell'ora Blasco doveva essere in luogo sicuro; si meravigliava anzi che Matteo Lo Vecchio o il capitano Mangialocchi non si fossero fatti vedere. Forse erano rimasti a Misilmeri o, chi sa per quale ragione, indugiavano per venire durante la notte. Che Blasco non fosse sfuggito all'agguato, non dubitava. Già, appena arrivata, donna Gabriella gli aveva detto dell'incontro fatto, e anzi si era vivamente doluta che quel villanaccio del capitano d'arme non si era arreso alle sue ingiunzioni, giacchè supponeva che don Raimondo non avrebbe mai tollerato una ingiuria a persona da lui inviata. Violante, poi, aveva aggiunto che aveva avuto una grande paura, perché tiravano delle fucilate. Dunque Blasco era caduto in potere dei compagni d'arme e, o vivo o morto, lo avrebbero portato a Palermo. Forse morto o ferito gravemente, pensava; ma intanto a quell'ora Matteo Lo Vecchio sarebbe dovuto venire.
Blasco morto o preso, le famose carte in potere suo, e la setta sorpresa, colta nel suo covo, come aveva già concertato... di che cosa poteva temere? Aveva posto tutto per giocare quell'ultima e più grossa partita e si sentiva in petto la cieca fiducia di vincere, giacchè nulla più gli rimaneva occulto di quella società segreta, dei suoi fini, delle cause della guerra spietata, implacabile, incessante contro di lui.
Intanto Antonino Bucolaro gli voleva parlare, a mezzanotte, dinanzi la bettola dello zi' Alessio, sotto S. Cristina la Vecchia. Perché? C'era qualche novità? Non erano forse stati presi tutti gli accordi?
Ritornò al palazzo; il suo cameriere fidato gli disse che la signora duchessa era uscita da un quarto d'ora nella sua portantina e s'era fatta condurre al palazzo dei La Grua, ordinando alle cameriere di portarle, al più tardi l'indomani mattina, il suo guardaroba e tutto ciò che le apparteneva.
"Sta bene!" rispose seccamente. S'aspettava che gli dicessero che era venuto qualcuno a cercarlo, ma invano.
"Che diavolo fa Matteo Lo Vecchio?" disse fra sè, preoccupato; e a quell'inesplicabile ritardo si associò la idea dell'abboccamento domandatogli da Antonino Bucolaro. C'era qualche relazione? Quel demonio del bastardo era forse sfuggito all'agguato e aveva mandato a monte ogni cosa?
Il dubbio lo fece rabbrividire. Aspettò la mezzanotte con impazienza, contando le ore all'orologio del Monte di Pietà.
Quando gli parve il momento uscì, a piedi, armato, facendosi accompagnare da due servi fidati, armati anch'essi. Non dovevano percorrere che l'ultimo tratto della strada di S. Agostino e piegare per la discesa dell'Angelo Custode, fin giù al Papireto.
Salvo le case che fronteggiano anche ora la via del Papireto, non v'erano allora tra la discesa dell'Angelo Custode e il Duomo altre abitazioni, e il luogo deserto serbava tuttavia le tracce dell'antica palude prosciugata. Il poggio, ora ridotto a stercobate sul quale sorge l'ospedale dei sacerdoti, s'alzava selvaggio sull'antico bacino, sparso di piccoli canneti sparuti. Alcune strade sboccavano dall'interno della città, quasi perpendicolarmente al piano. In fondo a una di esse, dietro la storica cappella della Incoronazione, c'era la chiesetta di S. Cristina la Vecchia, piccolo edificio normanno che ancora serba gli archi e le ogive della originaria architettura. Un piccolo orto si stendeva allora accanto alla chiesa, limitato da un vicoletto, che scendeva in già verso una strada, e al cui angolo s'apriva la taverna dello zi' Alessio: una taverna così famosa che aveva fatto dare il nome alla strada.
La notte era orribilmente buia: non una stella, ma una densa volta di nubi nere e impenetrabili. Non v'erano fanali e le strade erano nere e non si vedeva a un passo di distanza.
Don Raimondo scendeva per la ripida strada dell'Angelo Custode, male acciottolata, lubrica per l'umidità notturna e per la fanghiglia che le piogge e la sporcizia dei cittadini vi spandevano. Uno dei servi precedeva col lanternino per indicare la via e non fare inciampare il padrone fra le immondizie, che sul far della notte dalle case, prive quasi tutte allora di cessi, le massaie rovesciavano dai balconi e dalle finestre.
L'ampiezza della pianura incolta e squallida, della quale pareva che la notte cancellasse i confini, rendeva ancora più spaventevoli le tenebre.
Giunti all'imboccatura della strada dello zi' Alessio, don Raimondo ordinò ai servi di fermarsi.
"Aspettatemi qui e chiudete la lanterna."
Entrò solo nella strada e la percorse con un passo frettoloso fino alla taverna dello zi' Alessio. Si voltò per vedere se i servi potessero vederlo, ma l'ombra era così fitta che egli non vide neppure l'imbocco della strada.
La porta della taverna era chiusa; egli si avvicinò e picchiò dolcemente; nessuno rispose; picchiò un po' più forte ma, nel momento in cui tendeva l'orecchio per ascoltare, si sentì travolgere come da un turbine, da una furia, da qualcosa di indescrivibile, di inconcepibile, che gli coprì gli occhi e la bocca, gli avviluppò le braccia e le gambe, lo sollevò da terra, lo balzò nel vuoto. Non ebbe il tempo di sorprendersi, di muoversi, di gridare. Non potè neppure capire da quale forza ignota e misteriosa fosse travolto.
Si dibattè come per liberarsi, e allora soltanto riconobbe di essere avviluppato in una specie di rete fitta, come avvinghiato da mille cinghiette; non sentiva alcun contatto di mani; non era dritto sui piedi, non disteso; non capiva neppure come era raggomitolato. Certo si sentiva trasportato. Dove? Come? Da chi? Voleva gridare e non poteva; la sua bocca era come serrata. Chi lo aveva imbavagliato? Ma dunque era caduto in un agguato? Quel cieco venuto ad invitarlo da parte di Antonino Bucolaro era un emissario, forse uno degli aggressori; forse Antonino Bucolaro stesso l'aveva attirato in quel tranello... Si vide perduto.
Non udiva intorno a sè alcun rumore di passi. Coloro che lo trasportavano forse si erano tolte le scarpe, per non farsi sentire. Avvertiva però che essi percorrevano delle strade un po' in pendio e che svoltarono due o tre volte. Dalla taverna dello zi' Alessio alla piazza di S. Cosmo la strada non era lunga; egli che fin da principio aveva capito in quali mani fosse caduto, calcolava il tempo che avrebbero dovuto impiegare per giungere alla grotta dei Beati Paoli. Desiderava arrivare presto per togliersi da quella posizione.
E poi aveva un pensiero per la mente: contava i passi e le ore; fra un'ora e mezza, forse, tutto sarebbe stato definito. Bisognava avere l'arte e l'astuzia di giungere fino a quel momento.
Dopo un quarto d'ora, dalla difficoltà e irregolarità dei passi sentì che entravano in un andito. Erano arrivati. Aspettò che venisse liberato da quella rete e poco dopo, infatti, sentì che gli toglievano gli involucri nei quali si sentiva imprigionato, la benda e il bavaglio.
I suoi occhi dovettero richiudersi, colpiti dalla viva luce di alcune lanterne che rischiaravano quel luogo, a lui già noto. Era la rotonda sotterranea dove era stato condotto una notte, col suo banco di pietra, i corridoi laterali, la cupola, le nicchie. V'erano in piedi, armati, vestiti di un sacco nero, col volto celato dalla maschera, una ventina di uomini. Due altri sedevano al banco. In mezzo alla sala, presso un tavolo, un piccolo tavolino fornito dell'occorrente per scrivere. Don Raimondo non ebbe nessuno stupore per quell'apparato, a lui già noto, e che già si aspettava; non seppe però dominare il senso di paura che gli percorse il sangue al cospetto di quegli uomini ignoti, immobili e minacciosi nel loro taciturno atteggiamento.
Passato l'attimo necessario perché ciascuno prendesse il suo posto e si preparasse, il capo fece un gesto, dal banco dov'era, e cominciò non senza un lieve tono d'ironia:
"Duca della Motta, il mezzo scelto per farvi venire questa notte fra noi non è certo il più adatto e conveniente alla vostra persona e ai vostri meriti: vogliate perdonarlo, ma eravamo sicuri che, se vi avessimo invitato con mezzi cortesi, voi, forse, non avreste creduto di arrendervi. Necessitas non habet legem; e per noi è una necessità ineluttabile avervi qui stanotte."
Don Raimondo non rispose. Aveva subito ripreso la sua maschera fredda e impenetrabile e stringeva le labbra sottili, per impedire qualunque contrazione nervosa che potesse tradirlo.
"Duca della Motta," riprese il capo tralasciando l'ironica gentilezza, e assumendo un tono aspro e imperioso "duca della Motta, voi avete avuto la prova evidente che noi possiamo tutto, e che manteniamo le promesse. Bisogna ora compiere l'opera incominciata."
Prese dal banco alcune carte, i cui orli erano qua e là bruciacchiati, e continuò:
"Queste carte, don Raimondo Albamonte, contengono il processo che il nostro tribunale ha istruito contro di voi..."
Don Raimondo non potè dominare un senso di freddo nel sangue. Come? Dunque quei documenti che egli sperava già in potere di Matteo Lo Vecchio erano nelle mani del terribile tribunale? Era stato ingannato?...
"Voi conoscete il contenuto di questi documenti, almeno nel loro insieme, perché qualcuno ve l'ha fatto sapere e non è il caso di dire a voi, uomo di legge, quali conseguenze produrrebbero, per voi, se fossero presentati alla giustizia del re... La vostra testa, signore, non è più sicura sulle spalle."
Il duca provò il brivido freddo della mannaia sul collo.
"Ma noi siamo generosi. Noi non consegneremo queste carte a sua Maestà, se non quando ci costringerete a farlo. Domani un vascello partirà per Genova. Converrete con noi, che ci sarà facile far partire con esso un cavaliere o un uomo di legge o un procuratore, per andare a Torino e presentare al re, Emanuele Albamonte e questi documenti... Quest'uomo potrebbe inoltre accusarvi di aver fatto assassinare Giuseppico da Matteo Lo Vecchio; di aver avvelenato nelle carceri Peppa la Sarda; di aver fatto strangolare in carcere, senza regolare processo, due presunti rei; di aver tentato di fare avvelenare nel carcere di Messina da Matteo Lo Vecchio il signor Blasco da Castiglione; di aver tentato di farlo assassinare stamane sulla strada di Misilmeri, dalla compagnia d'arme del capitano Mangialocchi..."
"Non è vero!... balbettò don Raimondo.
"Non smentite!" rimproverò severamente il capo "non smentite quello di cui possediamo le prove... La menzogna aggrava la vostra condizione... Don Raimondo Albamonte, siete voi disposto a riconoscere dinanzi a noi le vostre colpe?"
Il duca tentò un colpo d'audacia:
"Non vi riconosco il diritto di giudicare" disse con uno sforzo.
Il capo guardò un orologio che aveva sul banco.
"Vi concedo cinque minuti per riflettere sulla vostra condizione. Badate a voi. Siete nelle nostre mani e non uscirete più di qui, se non quando sarà il momento di consegnarvi alla giustizia. Riflettete."
Successe un grande silenzio, nel quale si sentiva soltanto il tic-tac degli orologi; nessuno si moveva, ma don Raimondo sentiva sopra di sè tutti gli occhi lampeggianti dai buchi delle maschere. Egli non rifletteva; pareva contasse i minuti, tendendo l'orecchio, quasi aspettando un segno, un rumore. Ma il tempo trascorreva silenziosamente senza nessun indizio.
"Ebbene," riprese il capo "i cinque minuti sono trascorsi. Don Raimondo Albamonte, la vostra risposta?"
Il duca si riscosse, ebbe un nuovo brivido, sentì vacillare qualche speranza. Si afferrò all'espediente da lui escogitato: perdere tempo.
"Che cosa volete che io faccia?" domandò.
"Nulla di più o di meno del vostro dovere: riconoscere Emanuele Albamonte, vostro nipote, duca della Motta."
"Io? Riconoscere un ragazzo che non so chi sia? Chi prova che egli sia mio nipote?"
"Don Raimondo, non cercate di eluderci con cavilli: qui vi sono venti persone che lo proveranno, ma ricordatevi ancora di un fatto, che quando sedici anni or sono, voi, fingendovi accasciato per la sparizione di vostro nipote, promettevate con pubblici bandi grossi premi a chi l'avesse trovato, fornivate, sulle dichiarazioni della sora Maria la mammana, qualche indizio sicuro: il bambino aveva un piccolo segno bruno a forma di cuore sulla scapola sinistra. I bandi di quel tempo esistono ancora: eccone uno, stampa to, con le vostre armi. E il segno rivelatore c'è... Quale prova chiedete maggiore di questa?"
Don Raimondo si sentiva perduto. L'atto che il capo gli chiedeva con tanta semplicità importava la confessione dei suoi delitti ed equivaleva ad una volontaria offerta della sua testa al carnefice o ad un suicidio. Egli vide in una rapida visione tutti gli orrori della miseria, del disonore, del patibolo. L'istinto della vita urlò dalla sua bocca:
"No!... no!... Sono tutte imposture!"
"Don Raimondo Albamonte, badate a voi. Non siamo qui per perdere tempo inutilmente, ma per fare giustizia. Volete con un atto regolare sottoscritto da voi e da testimoni riconoscere Emanuele vostro nipote e reintegrarlo nel suo stato e nel suo grado?."
"No!...."
"Ebbene, domani don Girolamo Ammirata porterà al Vicerè il vostro bando e la fede di nascita di Emanuele, e gli presenterà vostro nipote, intanto che qualcuno partirà alla volta di Torino. Voi aspetterete qui..."
E rivoltosi a due di quegli uomini taciturni e immobili, aggiunse:
"Aprite la fossa."
Quelli si chinarono per terra e, agganciato con una corda un grosso anello di ferro, sollevarono una lastra. Un vano quadrato nero e putrido apparve agli occhi di don Raimondo, che si ritrasse indietro con un moto di spavento.
"Calatelo!" ordinò il capo.
I due Beati Paoli lo sollevarono di peso, nonostante che egli puntasse i piedi a terra e tentasse di resistere.
"Un momento!... un momento!..." urlò disperatamente.
"Calatelo!"
Gli esecutori gli trascinarono i piedi nel vuoto; egli perdette quasi la ragione: quel vuoto sotto i suoi piedi gli dava l'impressione dell'infinito che si spalancasse sotto per inghiottirlo; gli parve che la morte lo avesse acciuffato per i capelli per gettarlo in quel baratro nero, senza fondo. Il terrore, la ansia della vita, la disperazione, soffocarono in lui qualunque altra voce, che non fosse quella di vivere.
"Acconsento!" gridò con voce strozzata "acconsento!..."
Il capo fece un gesto, e i due esecutori ritrassero don Raimondo e lo rimisero in piedi. Durante questa rapida scena uno degli uomini mascherati aveva dato segno di impazienza e di sdegno a malapena repressi, ma visibili al fremito delle mani.
"Se... se acconsento," domandò don Raimondo, "mi darete poi quei documenti?..."
"Si vedrà. Non è il tempo di imporre condizioni. Del resto, non temete, la dichiarazione che voi scriverete e firmerete e che sarà ratificata da un notaio e da testimoni, non vi comprometterà per nulla; vi procurerà anzi lode di magnanimità, e la vostra maschera aggiungerà un'ipocrisia di più alle altre che la compongono. Fate entrare il maestro notaro del signor duca."
Un Beato Paolo uscì e rientrò quasi subito traendosi per mano un uomo pallido e tremante, nel quale don Raimondo riconobbe con stupore e collera il notaro della sua casa.
"Don Raimondo," ordinò il capo "scrivete."
Il duca sedette a tavolino, prese la penna e scrisse sotto la dettatura del capo:
"Nel nome di Dio benedetto e della Santa Vergine, io qui sottoscritto don Raimondo Albamonte, in atto duca della Motta, con lieto animo dichiaro di riconoscere, per prove non dubbie e per noti segni, nel giovanetto Emanuele, orfano raccolto e allevato da don Girolamo Ammirata, il mio caro amato e ricercato nipote Emanuele Albamonte, figlio legittimo del fu duca Emanuele, mio fratello, e della fu donna Aloisia Ventimiglia; e dichiaro e riconosco che a lui soltanto, come legittimo erede, in virtù delle regie prammatiche e delle nostre costituzioni, appartiene il titolo e l'investimento della duchea della Motta e delle altre terre e feudi pertinenti alla casa Albamonte; e nel rinunciare formalmente al possesso di detti feudi e terre coi titoli annessi, da me ora indebitamente tenuti, in favore di esso mio nipote Emanuele, lo riconosco per capo e signore della casa. E ringrazio la Divina Provvidenza di avermi concesso la grazia singolare di aver ritrovato questo mio lacrimato nipote, e di potergli restituire il patrimonio. Con che, oltre a provvedere alla salute dell'anima mia intendo anche rinfrescare le anime benedette del fu mio fratello don Emanuele e della fu donna Aloisia. Questa dichiarazione, scritta e sottoscritta di mio pugno, oggi, giorno della gloriosa vergine Santa Lucia, che si è piaciuta illuminarmi, affido al mastro notaro don Antonino Di Bello, perché la conservi nei suoi atti, e ne curi l'esecuzione per tutti gli atti legali che ne conseguono".
"In Palermo, addì 13 dicembre 1714.
Don Raimondo Albamonte
dei duchi della Motta".
"A voi, mastro notaro," ordinò il capo.
A sua volta il notaro sedette al tavolino e in fondo alla dichiarazione di don Raimondo appose le formule giuridiche occorrenti. Quattro degli uomini mascherati firmarono quel documento, a cui il notaro appose il suo sigillo e la firma.
"Portatemi quell'atto;" ordinò il capo e avutolo lo lesse, fece un segno di approvazione e lo posò sul suo banco, dicendo: "Sta bene. Ora passiamo ad altro, don Raimondo."
Il duca alzò il capo con spavento. Egli era davvero irriconoscibile e terrificante: la testa di Medusa non doveva provocare un effetto diverso.
"Che c'è ancora?" gemette con voce quasi spenta.
"Una cosa semplicissima;" disse il capo con un sorriso nel tono della voce "voi avete degli obblighi verso un vostro congiunto: Blasco da Castiglione. Se noi ci limitiamo verso di voi a chiedervi una dichiarazione, invece di consegnarvi al boia, gli è unicamente per un riguardo a questo giovane leale e generoso, che voi non avete saputo apprezzare e non avete neppure riconosciuto. Don Raimondo Albamonte, vi domando la mano di vostra figlia per Blasco da Castiglione."
Allora quell'uomo tremante e terrorizzato ebbe un fremito impetuoso per tutta la persona, si rizzò con gli occhi sfavillanti ed esclamò:
"No!... questo no. Mia figlia è mia! mia!..."
Dal cerchio degli uomini neri e mascherati uno si avanzò, e stendendo la mano con gesto solenne, disse:
"Blasco da Castiglione rinuncia."
Tutti gli occhi si voltarono verso quell'uomo con un moto di stupore; lo stesso don Raimondo non potè padroneggiare una certa commozione. Quegli continuò:
"Blasco da Castiglione rinuncia, e dice a voi del tribunale: Che la giustizia sia fatta! e che il pupillo riabbia il suo nome e la sua fortuna, ma non spogliate una innocente per vestirne un altro! ... Egli dice a voi, giusti, dice a voi, don Raimondo Albamonte: date vostra figlia a Emanuele, perché la corona ducale rimanga sul suo capo innocente!..."
Un mormorio di approvazione percorse le labbra sotto le maschere: don Raimondo sembrò illuminato da un raggio di luce; egli vide in un baleno tutto il vantaggio che poteva ricavare da una proposta, in cui la generosità e l'abnegazione sopraffacevano il freddo raziocinio e oscuravano la percezione dell'avvenire. Giunse le mani con un gesto di assentimento e di gratitudine, ma in quel punto un colpo di pistola rimbombò di fuori e una voce gridò:
"Abbarra! Abbarra!"