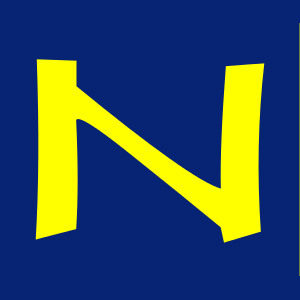Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte quarta, capitolo 1
| Italiano | English |
La mattina del primo luglio del 1718 la cittadinanza fu vivamente commossa e agitata per una grande notizia, della quale si erano avute le prime avvisaglie durante la notte. I "fani" o fuochi delle torri di guardia, infatti, avevano trasmesso l'avviso che una gran flotta solcava i mari di Sicilia, e un messo del principe di Carini aveva poco dopo portato al Vicerè conte Mattei una lettera, con la quale, in fretta, lo stesso principe gli comunicava che quella flotta attraversava il golfo di Castellamare.
Al mattino la flotta era apparsa in vista della città; era così numerosa che empiva l'orizzonte. Nessun dubbio che si trattasse dell'armata spagnola, che si sapeva concentrata in Sardegna ed era forte di quattrocentotrentadue legni fra bastimenti da combattimento e navi da sbarco, con ventiduemila uomini e cinquantamila cavalli, artiglierie, vettovaglie e tutto ciò che occorreva a una invasione, sotto gli ordini del Marchese de Lede, sperimentato capitano.
Non si sapeva però se l'armata venisse in Sicilia da amica o no; la maggioranza dei cittadini l'avrebbe desiderato, per sbarazzarsi del dominio savoiardo che, pur mirando a migliorare le condizioni del regno e ristabilire la piena e intera autonomia e precedenza dell'autorità laica sulla ecclesiastica, in fatto di temporalità, come nei bei tempi dell'antica monarchia, non aveva forse saputo adeguare i mezzi; aveva creduto di poter mutare d'un tratto e con la violenza pregiudizi, prerogative, vantaggi materiali inveterati e aveva, di più, spogliato i regnicoli di uffici e dignità per investirne i piemontesi.
Sia per la lunga e aspra discordia con Roma, che turbò le coscienze, sia per il fiscalismo rigido degli agenti del governo, la Sicilia attraversò tale pericolo di strettezze da suscitare un vivo malcontento; tanto che qualcuno dal nome Victorius Amedeus fece lo anagramma Cor eius est avidum; e in un canto popolare il nome di Casa Savoia servì a rappresentare la devastazione e la desolazione:
Pari ca cci passò Casa Savoia.
A fomentare il malumore non era stata estranea l'opera del clero che, salve poche eccezioni, durante la lotta fra lo Stato e la Chiesa aveva parteggiato apertamente per il papa, contro i diritti secolari della monarchia, altre volte difesi strenuamente dallo stesso clero. Ma forse non era il clero siciliano tanto ligio al papa per sentimento gerarchico e spirituale, quanto per osteggiare il re sabaudo, il cui governo non pareva disposto a largheggiare verso i conventi e le chiese in prerogative, privilegi, esenzioni, lasciti ecc. come il precedente governo spagnolo.
Tutte queste cose, e i dissesti che il mutamento di monarchia doveva inevitabilmente recare, avevano reso desiderabile quel governo spagnolo, la cui opera in Sicilia si era esplicata secondo una formula semplicissima: fare denari, arricchire clero e nobiltà, impiccare quanta più gente si potesse, e non curarsi di nulla. Poichè allora quelli che comandavano erano liberi di fare quello che volevano, e il popolo aveva feste, spettacoli, atti di fede, processioni, baldorie carnevalesche, e i malandrini potevano infestare le campagne e dispotizzare nelle città, come non rimpiangere il dominio spagnolo?
Per questo l'annunzio e poi la vista dell'armata, e il saperla di bandiera spagnola, propagandosi per la città l'avevano commossa e avevano attirato alla Marina una folla di curiosi, tra i quali coloro che nutrivano qualche timore, non già per l'invasione straniera, ma per pericoli di un conflitto, di cui la città sarebbe stato il campo. Tuttavia recava non poco stupore la nessuna preoccupazione del Vicerè, e il vedere che i soldati piemontesi se ne stavano mescolati tra la folla a vedere sfilare le navi spagnole.
A quei signori che erano andati, come al solito, a riverire sua Eccellenza, il Vicerè aveva detto parole rassicuranti.
"Non abbiano alcuna paura, signori; il re nostro signore, che Dio guardi, m'aveva già avvertito con suo corriere del passaggio di questa flotta, che va a Napoli; ho anzi ordine di offrire rinfreschi e quanto altro possa occorrere. Stiano tranquilli."
Ma verso l'Avemaria giunsero altre notizie, che misero la città in apprensione. Il principe Lanza era tornato in fretta dalla sua villeggiatura nel villaggio dell'Aspra, annunziando che dalle navi sbarcavano milizie in pieno assetto di guerra e che l'abate suo fratello, avvicinatosi a un ufficiale superiore e domandatogli che cosa significasse, ne aveva avuto risposta che sua maestà Filippo V si ripigliava il regno, non avendo re Vittorio mantenuto i patti. Quasi nel tempo stesso un campiere del principe della Cattolica portava al suo signore la medesima notizia, e il principe si affrettava ad informare il pretore conte di S. Marco, il quale, senza indugiare, corse al Palazzo Reale dal Vicerè.
Il povero conte Mattei cadde dalle nuvole. Come? Sbarco? Invasione? Così di sorpresa, a tradimento, senza dichiarazione di guerra, contro il buon uso? Non c'era da fare altro che prepararsi, in fretta, a munire la città.
"Io non ho forze sufficienti per respingere l'attacco; bisogna che la città si armi."
"Ma, Eccellenza, non si improvvisa una difesa contro un esercito forte di artiglierie!..."
"E allora non resta che un partito. Vostra signoria illustrissima patteggi per la resa, onorevolmente; io intanto ordinerò la difesa del regno."
"Sta bene; ma desidero che questo vostra Eccellenza me lo scriva."
La stessa sera il pretore cavalcò per la città impartendo ordini ai consoli delle maestranze, perché andassero in pieno ordine ad occupare i baluardi e la città fu piena del suono dei tamburi che battevano la generale, e spargevano la trepidazione e lo sgomento dei grandi avvenimenti.
La mattina dopo, i bastioni erano occupati e guarniti dalle maestranze; le artiglierie pronte, ma più per una necessità di messa in scena, che per opporre una vera resistenza. Una ricognizione era stata ordinata dal Vicerè nella notte, ma le truppe non l'avevano eseguita che la mattina, e ritornando in fuga scompigliate dicevano che la difesa sarebbe stata inutile, perché gli spagnoli erano numerosissimi. Correvano le dicerie più strambe e più diverse; i lodatori del passato, tutti coloro che avevano già goduto benefizi dal governo spagnolo, quelli che fino allora non avevano osato palesare i loro sentimenti ostili al governo sabaudo, ora, incoraggiati dalla speranza, scioglievano lo scilinguagnolo; qualcuno paragonava il marchese de Lede a Gedeone.
"Appena squilleranno le trombe, le mura di Gerico cadranno!"
"E don Gaspare Narbona? Dov'è, dov'è don Gaspare Narbona?"
"Quello lì? Ma se n'è andato al campo. Sapeva tutto lui; vecchio furbo!"
Don Gaspare Narbona era il pro curatore di re Filippo V per la contea di Modica; perché, giusta i patti del trattato di Utrecht, Filippo V, nel cedere la Sicilia a Vittorio Amedeo, ritenne per sè quell'antica e vasta contea, e vi teneva un suo presidio e un procuratore. L'anno innanzi per una questione fiscale era nata una gran lite; il Narbona sosteneva che la contea fosse esente da qualunque obbligo verso il regno di Sicilia; l'avvocato fiscale don Ignazio Perlongo, invece, sosteneva che essendo la contea feudo del regno, re Filippo, conte di Modica, era vassallo della corona di Sicilia e le doveva tutti gli obblighi del vassallaggio. Vi si volle perciò mandare un presidio savoiardo, ma i Modicani si rivoltarono; onde le ire del Vicerè contro il Narbona.
Era dunque spiegabile che ora il procuratore del re di Spagna levasse il capo e si prendesse la rivincita.
Tutta la giornata passò in grande agitazione. Il Vicerè convocò la nobiltà in palazzo per giustificarsi, mostrando la lettera del re, e proponendo la difesa, che tutti però respinsero, perché ormai era troppo tardi. Qualcuno più ardito mormorò che gli pareva una commedia.
"È tutta una finzione, una commedia, per coglierci improvvisamente; credete sul serio che re Vittorio e re Filippo non siano d'accordo? Questo dice: io fingo di venire da amico e sbarco le mie truppe; tu fingi di non sapere nulla e di essere colto in inganno: quattro cannonate, e poi ci aggiusteremo!.. E i minchioni siamo noi!... Difesa? Che difesa?" Non ebbe miglior effetto il bando del Vicerè, col quale quel giorno stesso "stante l'imminente necessità della difesa del regno" s'intimava "che tutti li baroni e feudatari soggetti al servizio militare debbano esser provvisti d'uomini, armi e cavalli a tenore della loro obbligazione, fra il termine di giorni dodici precisi v e si ordinava loro di concentrarsi a Piazza Armerina armati "con due pistole, spada e carrubina o scopetta" minacciando "l'indignazione di S. M." ai disubbidienti. Nessuno se ne diede per inteso, perché, prima ancora che il bando fosse inviato, dal campo spagnolo erano stati spediti corrieri dappertutto ad annunziare che da quel momento non ubbidissero che al re Filippo; e anche perché nessuno aveva voglia di combattere gli spagnoli, dato che i capi si erano concertati in Senato per patteggiare la resa della capitale e avevano formulato la proposta di capitolazione da sottoporre al marchese de Lede. L'agitazione della città per questo andava perdendo quel po' di sgomento, nato dall'incertezza e la curiosità, più che altro, suscitava quel rumore insolito, quel chiacchierio, quel chiedere e dare notizie, giacchè al popolo, che dei cambiamenti dinastici non traeva nessun vantaggio, non interessava ora che il doppio spettacolo dell'uscita delle truppe savoiarde e del Vicerè e l'entrata delle truppe spagnole. La Marina era piena di gente che andava per vedere se l'armata entrasse nel golfo e s'avvicinasse in città: popolani con la moglie e i figli, dame in carrozza, in portantina, signori a cavallo; umili vesti e abiti di seta, giubbetti di popolani e livree di lacchè e volanti; tonache da frate e vestiti corti da abati; carri da trasporto e magnifiche carrozze tirate da poderosi cavalli frisoni si intrecciavano, si confondevano, si separavano di nuovo.
Tre giovani signori, il più vecchio dei quali poteva avere ventidue anni, facevano bizzarramente caracollare i loro cavalli che, ora rinculando, ora impennandosi contro la folla dei pedoni, mettevano in scompiglio le donne, che con alte strida si sbandavano e fuggivano. La scena pareva divertire grandemente i tre cavalieri, che invece di passeggiare nell'ampio stradale, col pretesto di guardare i vascelli che ormeggiavano e facevano evoluzioni verso Capo Zafferano, cacciavano i cavalli in mezzo al popolo.
"Ebbene," domandava uno di essi, palpando il collo del suo bel sauro, "ebbene, Emanuele, quando mangeremo questi confetti?"
Il più giovane, Emanuele Albamonte, duca della Motta, rispose con un'aria di malcontento:
"Per conto mio, più tardi che si potrà..."
"Non è di questo parere tuo nonno."
"Non tanto il mio, quanto il nonno di lei."
"Dicono che sia bella," disse il terzo.
Emanuele fece una mossa con le spalle.
"La vidi poche volte, due o tre, credo, quando morì suo padre... Sì, forse sarà bella e piacerà; a me non piace punto..."
"Ha una bella dote..."
"Lo so. E una Branciforti e basta."
"Adesso bisognerà vedere come si metteranno le cose della guerra..."
"Ecco, vedete," disse Emanuele, "il nonno ha gettato via il bando del Vicerè per il servizio militare, ma, se io fossi stato maggiorenne, per conto mio avrei arruolato le mie milizie feudali. Perché questa, la guerra, mi sarebbe piaciuta farla. Mi dicono che mio padre era così..."
"Avresti servito il re Vittorio?"
"Lui come un altro; è la guerra in se stessa che mi piace!..."
"Si sa. All'arringo sei il migliore giostratore..."
"Ma quella è guerra da burla. A me piacerebbe di più fare sul serio. Chi lo sa? Se tutto quello che si dice sarà vero, non mancherebbero le occasioni!... Ah, avere ventun anni, essere libero e padrone di sè, potere amministrare le proprie rendite senza esser costretto a domandare un tarì al tutore... Ci vuol molto ancora: sei mesi e quattordici giorni!"
"Per bacco! tieni un mastro razionale perché ti faccia il conto giorno per giorno?"
"Lo faccio da me: ogni giorno che passa ne sottraggo uno dal conto, ma penso che ancora me ne rimangono troppi; centonovantasette giorni!..."
Così chiacchierando, spingevano i cavalli qua e là, ridendo della paura della folla e motteggiando, con l'insolenza di giovani ricchi e di famiglie potenti, coloro che borbottavano.
Emanuele si era fatto alto e possente e sembrava maggiore della sua età; il nonno gli aveva fatto dare una educazione confacente al suo stato: cavalcare, tirare di scherma, ballare; di cultura letteraria non occorreva, sia perché vi aveva provveduto don Girolamo, sia perché Emanuele non sentiva una grande predilezione per i libri... La sola cognizione che Emanuele desiderò fu la conoscenza del suo patrimonio.
Gli atti di riconoscimento e il suo diritto all'eredità furono fatti valere, subito appena morto don Raimondo e la tutela e l'amministrazione del vasto patrimonio erano stati affidati al principe di Geraci, oltre che come nonno, per la sua autorità. Erano però stati riconosciuti i beni dotali della prima moglie, madre di Violante, e di donna Gabriella; e per evitare litigi, tanto coi Branciforti, come coi la Grua, si era venuto ad amichevoli accordi.
Per un eccesso di galanteria il principe aveva dichiarato che donna Gabriella poteva, se le gradiva, continuare ad abitare nel palazzo della Motta, ma ella ricusò di abitare da ospite la casa dove era stata signora e padrona e si ritirò provvisoriamente in casa del fratello, ma di lì a poco, acquistata una palazzina dietro il convento di S. Domenico, v'an'dò a nascondere la sua vedovanza e i suoi tormenti. La sua dote e un assegno annuo datole dalla sua famiglia erano sufficienti a farla vivere con quella prosperità che richiedeva il suo grado.
Violante, posta sotto la tutela del principe di Branciforti, ritornò al monastero. I due nobili avevano trovato naturalissimo che i due cugini, orfani entrambi, la cui ricchezza era stata fino allora accumulata nelle mani di don Raimondo, si sposassero e così la mantenessero intatta.
Nella trattazione e conclusione del matrimonio i due giovani non entravano nè punto nè poco; e non era necessario, perché, sebbene ciò dovesse interessare loro più di ogni altro, le convenienze e la buona usanza non consentivano che essi se ne occupassero, o che fossero consultate le loro inclinazioni prima di fare il gran passo. I matrimoni d'amore non erano frequenti e abituali nella nobiltà, si concludevano per interessi e per convenienze dei parenti e, secondo la buona usanza, i giovani non si vedevano, nè avevano fra loro alcuna relazione. La futura sposa ordinariamente stava in un monastero dove completava la sua educazione, e donde sarebbe uscita qualche giorno prima delle nozze, per passare bruscamente dalla vita claustrale alle tempeste del mondo.
Di comune accordo, i due signori avevano stabilito che le nozze sarebbero avvenute quando Emanuele avrebbe raggiunto la sua maggiore età e che Violante avrebbe aspettato quel giorno in monastero. La dote di Violante era costituita oltre che dall'eredità materna, anche di quello che era patrimonio personale di don Raimondo, frutto del suo lavoro, della sua economia, di qualche speculazione vantaggiosa, come la usura, che egli aveva esercitato discretamente con prestiti e mutui a signori: ed era una dote cospicua, veramente principesca, che avrebbe fatto di Emanuele uno dei più ricchi signori della città.
Emanuele dapprima non aveva opposto nulla a questi progetti: sebbene la cugina non avesse esercitato sopra di lui alcun fascino e neppure destato simpatia, pure l'idea di un matrimonio con una dama di nobiltà pari alla sua e ricca gli pareva la cosa più naturale del mondo. Ma a poco a poco il gusto della nuova vita, le imprese galanti alle quali si era dato assai per tempo con l'avidità di un piccolo satiro, e più un sentimento di ribellione, di prepotenza, di autoritarismo, gli avevano fatto apparire quel matrimonio, concertato senza la sua volontà e impostogli, come una cosa pesante e antipatica, alla quale si sentiva decisamente avverso.
Egli non provava alcuna simpatia per quella cugina il cui aspetto freddo e sostenuto lo aveva urtato. Fra l'uno e l'altra c'era qualche cosa di insormontabile, una specie di alta barriera e un abisso profondo e così largo che li faceva sentire lontani ed estranei.
Nella primavera di quell'anno egli aveva voluto visitare le sue terre. Gli eletti e i giurati delle grandi terre, i segretari dei borghi, i capitani, erano andati a incontrarlo, ricevendolo sotto archi trionfali di verzura, allo sparo dei fucili e dei mortaretti; nelle parrocchie, i parroci e i curati gli avevano dato la benedizione col Santissimo, dopo un discorsetto col quale auguravano, anzi erano sicuri, che egli avrebbe avuto lo stesso zelo per la religione dei suoi maggiori. Nella gran sala del castello aveva ricevuto gli omaggi della magistratura delle terre feudali ed il baciamano non finiva mai; i vassalli improvvisavano giuochi di tori e fuochi di artifizio e qualche letterato del luogo improvvisò versi latini encomiastici, nei quali Emanuele era paragonato ad Ercole o ad altro eroe antico, ovvero, giocando sulla etimologia del nome, era senz'altro chiamato il mandato da Dio, come un altro Messia.
Tutte queste feste - che gli davano la misura della sua potestà e gli facevano conoscere come c'era della gente, una folla, che dipendeva da lui, che aveva il dovere di lavorare per lui, che gli doveva venerazione come a un nume, che egli poteva fare impiccare dai magistrati eletti da lui - lo avevano ubriacato. Perché mai se egli era così potente e padrone di fare e disfare, se aveva una volontà da imporre, perché doveva ubbidire a suo nonno e accettare quel matrimonio non voluto, non desiderato?
A Pellegra non aveva più pensato, se non come a una graziosa e piacevole avventura, che non aveva lasciato nel suo cuore alcuna traccia di passione. Soltanto, paragonandola a Violante così fredda e riservata, egli la trovava deliziosa e desiderabile.
La povera fanciulla aveva invano aspettato il suo principe, sebbene la improvvisa fortuna che aveva trasformato agli occhi suoi, da un momento all'altro, il povero nipote del razionale del Monte nell'erede del duca della Motta, le avesse dato una stretta dolorosa al cuore, e le avesse troncato la speranza dell'avvenire.
Dal balconcino aveva veduto partire il giovane nella carrozza del nonno e aveva sperato uno sguardo, un saluto, un cenno: ma invano. Egli era partito senza ricordarsi che v'era lassù un cuore che soffriva, ed ella aveva sentito che il suo cuore se ne andava per sempre con quella carrozza.
Tuttavia lo aspettò. Sperava? Non sperava, in verità, ma non sapeva rassegnarsi all'abbandono e non voleva credere che Emanuele l'avesse dimenticata del tutto. Invece egli non si fece più vivo.
Qualche volta, uscendo col padre già mezzo imbecillito e trascinantesi sui piedi vacillanti, ella lo vedeva in carrozza o a cavallo o con l'aio o con altri giovani; il suo cuore picchiava, tumultuando, ma invano. Egli passava via senza neppure guardarla.
Dopo due anni Pellegra partì per Roma, condotta dai parenti della madre, giacchè don Vincenzo era divenuto del tutto scemo, e convenne affidarlo alle cure di una sua lontana parente, con un compenso mensile. A Roma, Pellegra s'era messa a studiare, infervorandosi della poesia, e aveva cominciato a dare sfogo all'anima sua, componendo dei sonetti nei quali fingeva di esser Laura e di rispondere al Petrarca: sonetti che erano piaciuti a un prelato suo parente, e che più tardi dovevano meritare alla fanciulla la ammissione in Arcadia, la mano di un avvocato romano e, completati, dovevano venire pubblicati e lodati come un miracolo di poesia.
Dopo la sua partenza, Emanuele pensò qualche volta a lei, soltanto come termine di paragone con Violante, ma non altro. Altre aspirazioni aveva ora il suo cuore, o meglio la sua vanità, e troppe belle dame egli vedeva nella nuova società nella quale era entrato. Quella zia, per esempio, così giovane, così bella, rimasta sola... Oh, perché mai aveva voluto abbandonare il palazzo della Motta?
Non si vedevano quasi mai, eccetto nelle occasioni solenni, come a capo d'anno, a Natale, a Pasqua e in generale in tutte le ricorrenze nelle quali era obbligo andare a baciare la mano ai parenti più anziani o ai superiori per augurare loro le buone feste. Erano visite brevi che non oltrepassavano i limiti della più stretta buona creanza, per volontà di donna Gabriella, che si era chiusa in un riserbo e in una solitudine veramente singolari, e che forse trovava antipatico e vuoto quel giovanotto alto e possente, il cui volto aveva, in certo modo, qualcosa che ricordava quello di Blasco. C'era l'aria di famiglia, l'impronta della stirpe; ma quale differenza fra lui e Blasco! Ella non poteva fare a meno di riconoscere che il bastardo valeva assai più del legittimo, e che nel paragone questo perdeva quanto quello guadagnava. Forse questo confronto le impediva di usare a Emanuele accoglienze cordiali e simpatiche, che invogliassero all'intimità e alla confidenza. Così il giovane si asteneva dal frequentare la casa della zia, sebbene la trovasse bella e piacente e, in più, piazza sguarnita.
In queste condizioni si trovava Emanuele alla vigilia della sua maggiore età e la noia e il fastidio di quelle nozze, che minacciavano di imprigionare la sua giovinezza, gli si rinnovavano, quando cavalcava coi suoi amici, il tono delle cui parole gli pareva contenesse una leggera ironia.