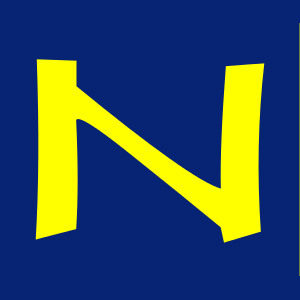Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte quarta, capitolo 2
| Italiano | English |
Il 3 di luglio la capitolazione della città, formulata in sei articoletti, era conclusa tra il marchese de Lede e gli ambasciatori del Senato don Francesco Gravina principe di Palagonia e don Girolamo Gravina principe di Montevago; e quello stesso giorno il Vicerè conte Mattei, con la viceregina e i familiari, gli impiegati della corte, i consultori, lasciò la città uscendo da Porta Nuova, dove lo aspettavano la cavalleria e i fanti, coi quali si avviò per la Piana dei Greci. Nessuno dei signori lo accompagnò, per cortesia, fino a un certo punto; nessuno gli diede un cortese saluto di congedo: gli animi si erano rivolti al nuovo sole che ritornava dopo cinque anni di assenza.
Le maestranze, per ordine del pretore, presero possesso del Palazzo Reale, dove non si trovò nulla dell'archivio, avendo il conte Mattei fatto bruciare tutte le scritture ed anche gli esemplari della opera sui Parlamenti di Sicilia, fatta dal Mongitore.
La piazza del Palazzo Reale, sgombra di soldati dopo la partenza della corte, parve un paese disabitato: il quartiere di S. Giacomo era deserto; tutte le famiglie piemontesi di impiegati e soldati erano andate via quella mattina con le loro robe: esodo triste e senza compianto.
Solo nel Castello a mare rimase un presidio di quattrocento soldati, con l'ordine di non molestare la città, ma di difendere la bandiera reale e non cedere che quando la difesa sarebbe stata impossibile. Sei soldati cercarono di evadere; due però furono presi e messi a morte.
L'esercito spagnolo entrò a Palermo la mattina del 4, con un codazzo di famiglie, fra le acclamazioni della cittadinanza, che salutava chi, come enfaticamente aveva detto, era venuto a liberarli "dalla tirannide del Faraone Savoiardo"; e non sapevano che con quegli osanna preparavano alla patria la più nefasta delle servitù. La flotta, seguendo il movimento delle truppe, entrava nel golfo schierandosi in ordine di battaglia e allora cominciò un violento cannoneggiamento, fra il presidio del Castello e le navi, che richiamò la popolazione alla marina e sui baluardi, per ammirare lo spettacolo di quel duello, che si ripercoteva nella città, destando trepidazioni e timori.
Intanto le truppe spagnole, per opprimere il Castello, piantavano il campo a S. Oliva e, per difendersi da possibili aggressioni e tagliare a quelli del Castello ogni comunicazione, stendevano la loro linea fin sotto il convento di Baida. E da questi luoghi a poco a poco si spinsero, restringendo sempre la linea, fino a stabilire le batterie negli orti fuori Porta S. Giorgio, dove ora sorgono popolosi rioni.
Un giovane soldato dei dragoni spagnoli, quella stessa sera del quattro, probabilmente con un permesso del suo capitano, entrato in città da Porta Carini, si avviò verso il Capo e, svoltato per la Mercè si fermò un minuto a guardare il palazzo della Motta.
I balconi erano chiusi, il portone chiuso; v'era nell'aspetto della casa qualche cosa di sinistro e di cupo, quasi il segno esteriore di una storia torbida e scura. Di lì, scendendo lentamente, passò per S. Cosmo, e si fermò di nuovo a guardare il portone della casa Baldi; poi, girando per la piazza, risalì il vicolo degli Orfani e si fermò ancora davanti a una porticina murata. Scosse il capo e riprese il cammino: pareva che nel suo volto le memorie, che si andavano ridestando, lasciassero un'orma del loro susseguirsi.
Dalla strada della Guilla, per quella dei Sette Angeli uscì nel Cassaro, che pareva in festa. Qua e là si vedeva qualche ritratto del re Filippo V e dei preti che parlavano animatamente, con aspetto rassicurato, come gente che vedeva giunto il tempo in cui avrebbero avuto fine tutte le sue tribolazioni. Si sperava, infatti, nel ritorno dell'antico regime, per vedere cessato l'interdetto e le persecuzioni delle quali essi si credevano vittime. Una folla di gente, signori e dame in carrozza, popolani a piedi, accorreva alla marina per assistere allo spettacolo del cannoneggiamento fra il Castello e le navi spagnole: qualche vecchio diceva che quello era un giuoco a paragone della famosa battaglia navale combattutasi nel golfo tra olandesi e spagnoli da una parte e francesi dall'altra, più di quarant'anni addietro. Quello sì era stato uno spettacolo terribile e grandioso. Tutto il golfo era pieno di vascelli avvolti fra nubi di fumo squarciate a ogni istante dalle cannonate; vascelli grandi come montagne che bruciavano, diventavano immensi crateri, o scoppiavano con fragore che faceva tremare la città; e che stragi, che morti, che distruzioni! Che cos'era quel duello? Qualcosa di simile ai fuochi d'artifizio!.. Nondimeno era sempre uno spettacolo da ammirare. Si poteva seguire la traiettoria delle bombe e divertirsi a indovinare dove sarebbero cadute. Sia quelle dei vascelli, che quelle del Castello cadevano spesso nell'acqua, sollevando delle colonne di spuma e di fumo, cosa che divertiva di più gli spettatori.
Il dragone scese giù per il Cassaro ammirato da quanti lo vedevano e se lo segnavano come uno dei liberatori, ma si accorse che molti occhi si fermavano con insistenza sopra di lui, con quell'espressione particolare che significa: "Mi pare di conoscerti". Giunto ai quattro Canti si fermò, dando un'occhiata alle quattro strade che se ne dilungavano e che gli parevano così belle, ma, mentre stava in quella muta ammirazione, improvvisamente trasalì, e un vivo rossore gli imporporò il volto. Una voce, a lui ben nota, gridò accanto a lui: "Ferma!"
Da una carrozza, tirata da due cavalli, che a quell'ordine si fermò con un grande scalpiccio di ferri sul lastricato, si affacciò un volto che guardò con una espressione di stupore il dragone. Per un istante si guardarono entrambi, riconoscendosi, senza parlare, immobili, ma non senza commozione; e pareva che fossero combattuti da sentimenti diversi e più da una specie di ripugnanza o di riserbatezza, che forse impediva loro di mostrarsi cordiali.
Il signore della carrozza smontò e, avvicinatosi al dragone, gli disse con gravità:
"Non m'inganno dunque nel riconoscere il signor Blasco Albamonte?"
"Sono io, appunto," rispose Blasco con freddezza ostentata.
"Ebbene, poichè la fortuna ci fa incontrare dopo quattro anni, se volete riprendere quella partita che abbiamo interrotto negli orti, sono a vostra disposizione."
Coriolano diceva così, ma un lieve sorriso sfiorava le sue labbra e dai suoi occhi brillava uno sguardo che rivelava desideri ben diversi da quelli cui alludevano le sue parole.
Il dragone o Blasco, che è tutt'uno, non rispose subito, ma ad un tratto, scotendo il capo col volto raggiante e stendendo le mani, disse:
"Blasco da Castiglione aveva con voi qualche conto da regolare, ma Blasco Albamonte, dragone nell'esercito di sua maestà cattolica, vi stende la mano, fraternamente, come prima, senza rancore, senza risentimenti, Coriolano."
"Ah! bravo! Vi riconosco. Abbracciatemi dunque, mio vecchio amico.
E, vinta ogni ripugnanza, si gettarono l'uno nelle braccia dell'altro stringendosi con affetto e baciandosi sulle guance.
"Dove andate?" gli domandò Coriolano della Floresta.
"A zonzo... non ho alcuna direzione..."
"Venite dunque in carrozza, discorreremo più liberamente."
"Volentieri."
Montarono in carrozza, e subito si avviarono per il Cassaro. Coriolano guardava Blasco con compiacimento e stupore.
"Ma guarda un po'! non avrei mai immaginato d'incontrarvi... Come mai vi ritrovo sotto coteste spoglie?..."
"La nostalgia, mio caro: sentivo un gran bisogno di venire a Palermo, e la sola maniera di venirvi senza timore di brutte sorprese era questa uniforme..."
"Eravate dunque sicuri di riprendervi la Sicilia?..."
"Sicurissimi... Sebbene non sia che un semplice soldato, avevo qualche amico a Corte, dal quale appuravo tutto ciò che vi era di più segreto. Cosicchè posso affermare con tutta sicurezza che io solo nell'esercito sapevo lo scopo della spedizione, fin dal suo principio; ciò che il marchese de Lede stesso non seppe che in alto mare, quando aprì il plico segreto che gli era stato consegnato..."
"Diamine! avete dunque conoscenze così addentro nella politica?.."
"Oh, no... Ma ero, e sono, buon amico di sua eminenza il cardinale Alberoni, primo ministro del re."
"Ah, bravo!... Adesso comprendo tutto... E dove alloggiate?"
"Il mio reggimento è al casino del principe di Sperlinga, dove si trova il quartiere generale..."
"Spero che verrete a casa mia; ritroverete la vostra camera..."
"Grazie, ma dimenticate che io non sono più Blasco da Castiglione, ma un dragone, che non può allontanarsi dal campo? E poi, aggiunse sorridendo; - non ricordate l'articolo secondo della Capitolazione, che fra l'altro vieta ai soldati di prendere "alloggio nelle case dei cittadini, o altri particolari abitanti"?"
"Andiamo, via; certo non proibisce a due buoni amici... Siamo amici, non è vero?..."
"Come prima..."
"Bene! dicevo dunque non proibisce a due buoni amici di desinare insieme... Mi farete almeno questa grazia. Avremo tante cose da raccontarci, perché suppongo che vorrete sapere quello che è accaduto in questi quattro anni di vostra assenza."
"Figuratevi!... Se sapeste il giro che ho fatto..."
"Me l'immagino. Sarete andato a guardare le finestre del monastero di S. Caterina!..."
"Il monastero di S. Caterina?..."
"Già, ma soltanto le finestre, perché ella è promessa sposa di vostro fratello, come voi avete voluto."
Blasco impallidì, ma subito riprese il suo buon umore:
"Oh, no, v'ingannate. Il monastero di S. Caterina?... Non ci pensavo e non sapevo neppure che ella fosse là... Ho voluto invece rivedere altri luoghi... E sono andato al vicolo degli Orfani..."
"Ah!... è murato."
"L'ho veduto; cosicchè siete come gli ebrei, dispersi!"
"No. Le sedi non mancano e gli animi sono gli stessi... Ma parliamo di altro. Avete veduto nessuna delle vostre conoscenze?..."
"Nessuno. Sono entrato in città da qualche ora soltanto..."
"Toh! guardate!..."
Venivano incontro a loro due giovani cavalieri montati su magnifici cavalli e seguiti dai lacchè. Coriolano ne additò uno.
"Ecco vostro fratello."
Blasco non potè trattenere un grido di meraviglia.
"Quello? Come s'è fatto alto! non l'avrei riconosciuto... Ed è anche un bel giovane..."
"Sì, è quello che dicono tutti. Credo che vada all'arringo di Villafranca ad esercitarsi. È un forte cavaliere e buon giostratore."
"Davvero?... Ne sono contento."
"Andrete a trovarlo?"
Blasco si rabbuiò un pochino e rispose seccamente:
"No."
"Avete ragione; forse c'è un po' troppo di orgoglio nel vostro no; ma avete ragione... E non contate di rivedere nessuno dei vostri antichi conoscenti?"
"Nessuno. Perché dovrei rivederli Caro mio, ora non sono che un povero soldato dei dragoni che vive della sua paga, quando gliela danno, o di quello che trova, e fa la guerra allegramente, aspettando che una palla di cannone gli porti via la testa che non ha mai avuto a posto!... Andiamo!... Ho assunto il mio nome e cognome di battesimo soltanto per una convenienza, e perché agli occhi di tutti Blasco da Castiglione sia morto, bandito e perseguitato come Saltaleviti o qualche altro malandrino della stessa specie; ma quando sono solo con me stesso, allora io mi sento e sono quel Blasco medesimo, che entrò a Palermo a cavallo di un ronzinante da fare vergognare quello di don Chisciotte, attaccando briga col principe di Iraci!... Ah!, come vorrei ritornare indietro e cancellare quei due anni di vita!... A proposito, e che ne è del principino di Iraci?
"Credo sia a Roma, nell'ambasciata del re Vittorio: fate conto che ritornerà..."
"Povero diavolo!... E della duchessa, donna Gabriella?"
"Sopporta con molto decoro la sua vedovanza."
"Una Maddalena pentita?..."
"Forse..."
"E i vostri amici?... don Girolamo?"
"Don Girolamo vive a Napoli con un altro nome; la moglie è morta di dolore. La povera donna amava profondamente il suo figlio di latte e si accorò tanto del distacco e dell'avere abbandonato Palermo che ne ammalò. Il suo figlio di latte, Emanuele, non la vide mai più, non le mandò neppure un saluto..."
"Oh! possibile?"
"È così purtroppo... Andrea è al servizio di Emanuele: egli lo ha preso con sè, non per gratitudine o per altro sentimento, ma per fare un gesto da signore."
Erano arrivati, così parlando, al palazzo della Floresta, dove smontarono. S'udiva ancora il rombo delle cannonate, frequente e minaccioso, dalla parte del mare. Le due parti non parevano disposte a cedere, sebbene il presidio savoiardo fosse esiguo e riconoscesse che la sua sarebbe stata più una difesa pro forma, che una vera resistenza con speranza di successo, nè poteva fare assegnamento su soccorsi, giacchè il conte Mattei con le poche migliaia di soldati si ritirava sopra Caltanissetta, lasciando che quei trentamila spagnoli, circa, ingoiassero il piccolo presidio savoiardo.
Durante il desinare, Blasco e Coriolano udivano quel cannoneggiamento e parlavano. Blasco dava informazioni sulle forze dell'esercito, sul generalissimo, sugli ufficiali, sul reggimento di stranieri, la più parte italiani; le artiglierie avevano piantato le trincee fra gli orti fin giù a Porta S. Giorgio. Dopo l'ingresso ufficiale del marchese de Lede, nella qualità di Vicerè del regno di Sicilia per parte di Filippo V, si sarebbe venuto a un'azione decisiva per impadronirsi del Castello.
Queste notizie, che pareva interessassero Coriolano, si avvicendavano con altre sulla vita condotta da Blasco in quei quattro anni. Egli era vissuto per poco a Genova, d'onde era partito alla volta di Barcellona. Poi si era recato a Madrid, e non se n'era allontanato più fino al giorno in cui il cardinale Alberoni non aveva deciso di riconquistare il regno di Sicilia, adducendo che Vittorio Amedeo non aveva ottemperato agli obblighi impostigli dalla cessione del regno, fattagli col trattato d'Utrecht. Era vissuto facendo il maestro d'arme e, ammaestrando il figlio giovinetto di una dama, amica del cardinale Alberoni, era entrato in dimestichezza con lei, a tal punto, che per partire e seguire l'esercito spagnolo aveva dovuto ricorrere a una astuzia.
Anche Coriolano della Floresta dava delle notizie sulle vicende della vita cittadina, fornendo particolari curiosi e interessanti e sulle sue consuetudini di vita.
Un'ora dopo Blasco si congedò; aveva forse fatto un po' tardi e s'aspettava qualche punizione. Egli riprese la via del campo, risalendo questa volta verso Porta Maqueda per fare la strada più breve. Sullo stradale che, nobilitato più tardi dal marchese di Regalmici, dava origine ai quattro canti di campagna, e che più tardi prese nome da Ruggero Settimo, s'imbattè in quei due cavalieri, in uno dei quali Coriolano gli aveva fatto riconoscere Emanuele.
Egli lo guardò attentamente non senza qualche tristezza, e con l'animo oppresso da tutti quei nuovi pensieri che l'incontro e la conversazione di Coriolano gli avevano destato, ritornò al campo.