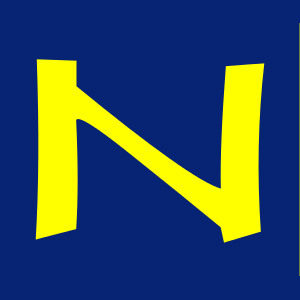Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte quarta, capitolo 12
| Italiano | English |
La cittadella di Messina si era resa agli spagnoli il 29 settembre e per tutto il regno il fatto suscitò grande allegrezza; restavano però in potere dei savoiardi alcuni luoghi fortificati, di non poca importanza, come Siracusa e Milazzo e conveniva subito espugnare quest'ultima città, per avere libera tutta la linea fra i due maggiori centri dell'isola.
Il vicerè marchese de Lede, quindi, concentrò tutte le forze disponibili contro Milazzo, intorno alla quale già fin da luglio era stato disposto un blocco, impotente per la tenuità delle forze a impedire che la città si rifornisse di nuovi difensori.
Nei primi di ottobre l'esercito spagnolo mosse su Milazzo a tappe successive e a vari intervalli; dalla parte del mare, giunsero altri rinforzi tedeschi al presidio, cosicchè pareva che a Milazzo si dovessero decidere le sorti del regno.
Gli spagnoli cominciarono a costruire le batterie, le quali avrebbero certo danneggiato il forte, se avessero potuto entrare in azione. Ciò riconobbero i comandanti delle truppe savoiarde e tedesche, che decisero di attaccare gli spagnoli e di distruggerne le batterie.
Il presidio di Milazzo non si poteva più dire savoiardo, giacchè i savoiardi erano una piccola frazione. Su undici reggimenti di fanteria, dieci erano germanici. Col pretesto di aiutare re Vittorio Amedeo e fare mantenere i patti del trattato di Utrecht, l'imperatore Carlo VI, che già era padrone di Napoli, mirava a impadronirsi e ad estendere il suo dominio anche sulla Sicilia.
All'alba del 14 ottobre, gli undici reggimenti di fanteria austro-savoiardi, e sei squadroni di cavalleria, sotto gli ordini del generale Caraffa, uscirono da Milazzo per assalire a sinistra le trincee spagnole, difese da meno di quattromila uomini.
L'inferiorità degli spagnoli era notevole. Essi dovettero abbandonare le trincee, pur ritirandosi ordinatamente, e senza cessare di combattere; quand'ecco un rapido movimento si propagò nelle file, e come se un torrente, rotti gli argini, irrompendo avesse spinto e trascinato ogni cosa nella sua furia, gli spagnoli si videro risospinti all'offensiva.
Entrava in battaglia il vicerè marchese de Lede con sette battaglioni di fanti e due reggimenti di cavalli.
Il marchese de Lede era partito il 13 da Messina e aveva posto il campo a S. Pietro. Udito il cannoneggiamento di quattro galere di Napoli che appoggiavano la mossa delle truppe tedesche e intuendo il combattimento, mosse rapidamente, e giunse per invigorire gli spagnoli, arrestare la ritirata, riprendere l'offensiva.
La zuffa diventò asprissima e terribile.
Uno squadrone di cavalleria alemanna, appoggiando il reggimento piemontese Susa, faceva grande strage de gli spagnoli, dalla destra. Il marchese de Lede ordinò allora che due squadroni di Numanzia respingessero la cavalleria tedesca e cercassero di aggirare i fanti.
I due squadroni si lanciarono all'assalto con le spade in alto, serrati, pesanti, formidabili.
Blasco era in prima fila, all'estremità.
Con le narici dilatate, curvo sul collo del cavallo, sceglieva il posto per assalire.
Di fronte avanzava di galoppo la cavalleria alemanna. L'urto fu terribile. Blasco si trovò trasportato dal suo impeto oltre la linea dei cavalieri nemici, e fu tosto circondato da tre o quattro cavalieri germanici. Ne atterrò uno con un colpo di pistola, un altro con una stoccata. Due dragoni corsero in suo aiuto. A quella estremità la zuffa diventò gagliarda e micidiale: uomini e cavalli parevano invasati da uno spirito ferocissimo di distruzione; i colpi di spada si alternavano con gli spari; tra il fumo che avvolgeva ogni cosa, un balenio di lame, uno sfolgorare di fiamme, un procombere di cavalli e cavalieri e grida e gemiti...
Lo squadrone tedesco battuto, decimato, ripiegò indietro, ma la fanteria piemontese col suo fuoco arrestò e sgomentò un istante i dragoni. Blasco disse fra sè: "Qui guadagnerò la mia sciarpa di capitano o morrò".
Si slanciò. Una palla gli ferì il cavallo; fu sollecito a saltare giù dalla sella, mentre l'animale finiva a terra; un altro cavallo smontato gli passava da canto, lo afferrò per il morso, vi montò con un salto e riprese la corsa. Tutto lo squadrone, dopo quel primo momento di esitazione, si era slanciato addosso alla fanteria.
Blasco s'era spinto verso la bandiera, intorno alla quale s'era formato un gruppo di difensori, fanti e cavalieri e la zuffa era più aspra e feroce che mai. Pesto, ferito, lacero, insanguinato, egli menava la spada con una furia che sgominava e gli apriva la strada.
La fanteria cedeva; soltanto un gruppo di cavalieri e di ufficiali resisteva. Blasco vide un ufficiale savoiardo, circondato da alcuni dragoni, difendersi disperatamente e valorosamente. Era ferito in più parti; ancora un poco e sarebbe stato ucciso.
"Castellamonte!" gridò stupefatto, gittandosi fra i dragoni.
Era infatti l'antica guardia reale, ora capitano di una compagnia di fanti. Il cavaliere di Castellamonte levò il capo vivamente e guardò Blasco, che gli si era posto dinanzi. Parve riconoscerlo, e allora gli porse la spada e si arrese.
"Conducetelo all'accampamento, e abbiate tutti i riguardi per lui; è un cavaliere valoroso e leale..."
Egli si spinse ancora innanzi: la bandiera era la sua meta...
Dopo quattr'ore di lotta i tedeschi e i piemontesi, sbaragliati, respinti fin sotto le mura, si rifugiarono a Milazzo; gli spagnoli ripresero le trincee. Blasco fu portato a S. Pietro sopra una barella improvvisata; egli però stringeva in pugno la bandiera strappata all'alfiere piemontese.
Aveva il corpo attraversato da due stoccate e una palla nel polpaccio della gamba destra.
Fasciato alla meglio fu con gli altri feriti trasportato a Barcellona, dove donna Gabriella, avvertita, corse per assisterlo.
O per la stagione, o per la natura stessa delle ferite, la guarigione fu lenta, e la convalescenza lunga. Blasco ebbe contemporaneamente il suo brevetto di luogotenente dei dragoni di Numanzia, e un congedo illimitato per guarirsi completamente.
Egli ne approfittò per ritornare a Palermo nei primi di febbraio dell'anno seguente, intanto che il suo squadrone rimaneva ancora sotto Milazzo, che, rifornita di forze e di viveri, resisteva ancora, nonostante fosse assediata da più di cinque mesi.
Durante il periodo acuto delle ferite, temendo di morire, egli aveva manifestato a donna Gabriella il suo desiderio di mantenere la promessa fattale, ma ella ricusò.
"No, non ora;" gli disse "non voglio che le nostre nozze siano benedette nella tristezza. Aspetteremo che tu guarisca..."
"E se io morissi?..."
"Oh non morrai! no! lo sento ne sono sicura."
Per questo, quando sbarcarono dalla feluca, che li aveva portati a Palermo da Messina, donna Gabriella sbarcò prima e se ne andò, sola nella sua carrozza, a casa; Blasco una mezz'ora dopo, ricevuto da Coriolano che lo aspettava nella propria carrozza. Quando giunse al palazzo della Floresta, sebbene stanco, sentì il bisogno prepotente di raccontare all'amico tutte le sue avventure. Egli aveva per donna Gabriella una dolce tenerezza e una grande riconoscenza che era assai vicina all'amore, ma non sentiva quel non so che fra il sogno e l'oblio di sè e di ogni cosa, quella specie di sublimazione dello spirito, quella misteriosa malinconia e quella dolcezza di rapimento di tutta la persona che sono l'essenza e la poesia dell'amore.
Coriolano l'ascoltò non senza compiacimento. Scapolo impenitente, egli non intendeva certi misteri del cuore umano. Quando Blasco finì, disse sorridendo:
"Non potete credere quanto sia contento di sapervi felice! Devo esserne grato anch'io alla signora duchessa, alla quale vi prego di presentare i miei omaggi... E tanto più felice, in quanto sono sicuro che qualche notizia del giorno l'apprenderete senza commozione."
"Che notizia?"
"Una che dovreste aspettarvi..."
"Cioè?"
"Il matrimonio di Emanuele..."
"È dunque avvenuto?" esclamò Blasco impallidendo improvvisamente.
"Oh, no; ma avverrà fra giorni, l'ultima domenica di carnevale, che cade il 19 di questo mese."
Blasco non disse nulla; una nube di malinconia gli era calata sugli occhi.
"Avrebbero dovuto sposarsi prima, per la festa della Madonna, ma Emanuele è tornato da Roma con una malattia... che gli ha impedito di sposarsi... Non so neppure se sia in grado di farlo ora, senza pericolo..."
"Che malattia?" domandò Blasco, tanto per dire qualche cosa, ma senza nessun interesse.
Coriolano gliela disse.
"A Roma nulla di più facile; è la città più corrotta che ci sia in Italia. Credo che Emanuele non si sia risparmiato. A quanto si dice, a Roma ha menato una vitaccia. Cortigiane, giuoco, duelli... è stato chiuso due volte a Castel Sant'Angelo... Il principe di Geraci ha dovuto aprire più volte la borsa e in ultimo ha dovuto richiamare il nipote a Palermo. Egli è giunto in tali condizioni di salute, che non è stato necessario ricorrere a rigori, che del resto non avrebbero potuto avere molta efficacia, perché Emanuele è già maggiorenne..."
"Ah sì?..."
"Il principe gli ha fatto la consegna dei conti e l'ha immesso, come si dice, in possesso del patrimonio..."
"Egli dunque è ora il capo della casa degli Albamonte!" disse Blasco non senza una lieve amarezza.
"Infatti!..."
Passò un istante di silenzio; poi Blasco domandò non senza una lieve commozione:
"E Violante è contenta di questo matrimonio?"
"Se dicessi di sì, mentirei."
"Povera fanciulla!" mormorò Blasco.
"Avete ragione!..."
E ancora un'altra cortina di silenzio si distese fra i due amici e anche: questa volta fu Blasco il primo a romperlo.
"Oh, Coriolano... penso che quando io difendevo Violante, anche contro Emanuele, non avevo torto... La vostra rigida giustizia ha protetto un birbante e ha fatto una vittima..."
"Chi poteva prevedere che quel giovane orfano, reietto, spogliato, perseguitato, minacciato dalla morte, sarebbe stato indegno di tutta la nostra protezione?.. E d'altronde la giustizia misura forse il diritto con la bilancia della dignità?.. La giustizia non vede persone, ma fatti, e dove c'è una violazione di diritto, interviene per proteggere e difendere... Può sbagliare e può anche proteggere un uomo come Emanuele; ciò non toglie che domani il protetto di oggi possa cadere sotto il suo rigore..."
"Ma intanto la vittima rimane...."
"È una fatalità. Potete stare sicuro, però, che io vigilo sopra di lei..."
E aggiunse poco dopo sorridendo:
"Non sarete geloso se io mi sostituisco a voi in questa vigilanza."
"Geloso? Perché?" disse Blasco con amarezza. "Ormai tutto finito. Il destino ha segnato a ciascuno la sua strada; io percorro la mia; non me ne dolgo, perché sarei un ingrato verso una donna che con una vita di devozione e di passione si è quasi redenta agli occhi miei, e alla quale sono ormai legato, più che da una promessa, da gratitudine e da affetto. Certamente, non era questo il mio sogno... Ma io povero bastardo buttato alla ventura, non potevo e non dovevo avere dei sogni!... Ora, voi capirete bene per quali sentimenti di delicatezza devo astenermi dallo spiegare qualsiasi azione in favore di Violante; devo anzi esservi riconoscente di quanto farete per Violante."
"State tranquillo!... Ve ne do la mia parola..."
Tutto quel giorno Blasco stette triste e pensieroso. L'immagine di Violante, trascinata a quelle nozze, fra le braccia di quel giovinastro vizioso e corrotto nell'anima e nel corpo, gli stava dinanzi tormentosa. Donna Gabriella si accorse di quella tristezza e non osò investigare. Anche lei sentiva come un'ombra intorno a sè e aveva qualcosa che le pesava addosso e che non ardiva di dire.
Ella aveva saputo la notizia delle prossime nozze di Violante, alle quali, nella sua qualità di vedova di don Raimondo Albamonte, aveva quasi l'obbligo di intervenire. Quella notizia l'aveva turbata, rievocandole l'immagine di Violante, che non aveva dimenticato. Nei quattro anni della sua vedovanza, era andata a visitare la figliastra solamente nelle feste solenni, più per occhio di mondo, che per affetto. Da quando si era ravvicinata a Blasco, da quando aveva incominciato quella sua nuova vita d'amore, non l'aveva più veduta, nè per la festa di mezz'agosto, nè per l'Immacolata, nè per Natale o per Capodanno. La lontananza aveva potuto scusare la sua assenza, ma era ritornata a Palermo e non poteva certamente esimersi dal compiere un atto di dovere. La sua astensione poteva dare all'occhio ed essere interpretata sinistramente.
In verità, lei in cuor suo era soddisfatta che Violante si sposasse, e più soddisfatta ancora che sposasse Emanuele. In questa sua soddisfazione entrava un po' di malignità, perché sapeva che i due giovani non si amavano, e che Emanuele era già un uomo mezzo disfatto e che quel matrimonio era, per l'uno e per l'altra, un giogo insopportabile. Così lei prendeva una vendetta senza sollecitarla, anzi senza cercarla.
Tuttavia, nonostante questa soddisfazione egoistica e maligna ella era turbata: e il silenzio triste di Blasco aumentava il suo turbamento e le metteva nell'anima una certa trepidazione.
La loro cena quella notte fu silenziosa; le braccia di Blasco non la cercarono con la stessa febbre delle altre volte, ed ella si sentì riempire gli occhi di lacrime.
"Perché sei triste?" gli domandò.
"No, non sono triste," rispose Blasco, "forse sono stanco..."
Donna Gabriella non insistette. Gli sedette sulle ginocchia, gli cinse il collo con le braccia con quel gesto di abbandono e di tenerezza che la rendeva affascinante e gli appoggiò il capo sulla spalla, singhiozzando.
"Non mi vuoi bene!..."
Quei giorni trascorsero presto e la ultima domenica di carnevale era prossima. Donna Gabriella aveva ricevuto un biglietto stampato, e inquadrato in un fregio, che diceva:
"Con l'occasione gratissima del matrimonio che sarà conchiuso fra il signor duca della Motta e la signorina donna Violante Albamonte e Branciforti, domenica 10 febbraio, viene pregata la di lei bontà per accrescere vieppiù la pompa con la sua presenza e si dichiarano alla di lei ubbidienza".
Quell'invito stampato la tolse da ogni impiccio. Ella rispose subito esprimendo il suo gradimento per il grazioso invito, ma dicendosi dolente che le sue condizioni di salute non le permettessero di manifestare "presenzialmente" i "suoi affetti di dovere" e "contrassegnando l'onore dei pregiatissimi comandi" si "ripeteva devotissima e obbligatissima".
Quando ebbe spedito questa lettera si sentì più leggera come se si fosse tolto un gran peso dal petto, perché, in verità l'intervento a quelle nozze avrebbe anche imbarazzato altri, non essendo ormai più un mistero per nessuno quello che era passato tra lei ed Emanuele.
A Blasco non disse nulla: ella gli aveva letto nel profondo dell'animo, ne aveva sorpreso una malfrenata agitazione e il suo cuore di amante ne aveva indovinato i motivi. Lo sorvegliava sospettosa chiudendosi dentro il dolore, ma talvolta i suoi occhi balenavano delle antiche fiamme e un pensiero di odio e di vendetta le offuscava la ragione.
Passarono quei giorni in uno stato di animo angoscioso, celandosi l'uno all'altra, ed evitando di domandarsi il perché di quel loro silenzio malinconico ed eloquente, come paurosi di udire la rivelazione di quello che pur intendevano.
La domenica venne.
Donna Gabriella era febbricitante.
"Quando ella sarà maritata, egli non potrà più pensare a lei, diceva fra sè, - bisogna che la dimentichi. E allora sarà mio, tutto mio!...". Ma mentre pensava così, una voce dolorosa le rispondeva dentro:
"No, no, no! Egli non sarà mai interamente tuo, mai!...".
E a questa voce cupa e segreta, che ella sola udiva, il suo cuore gelava e i singhiozzi le salivano alla gola.
Fece attaccare la sua carrozza, come per andare a passeggiare o a godere lo spettacolo delle maschere, che quel giorno scorrazzavano per il Cassaro, ma in realtà per appurare qualche notizia del matrimonio.
Il Cassaro era pieno di gente che aspettava i carri mascherati. Tra la folla si insinuavano maschere buffe, che provocavano risa e chiasso: correvano, saltavano sulle spalle altrui. Un rullo cadenzato di tamburi faceva voltare le teste da una parte. Un uomo vestito alla moda spagnola del Cinquecento, con un berretto di velluto piumato in testa, con una cappa sulle spalle, una spada di legno in mano, montava sopra una scala, rapidamente, con mille smorfie ridicole e si precipitava fra le matte risate della folla; era il "mastro di campo", una delle maschere più antiche e più care al popolo, che ne aveva dimenticato l'origine storica. Il "mastro di campo" era l'avanzo di una rappresentazione ridicola degli amori del vecchio Bernardo Cabrera, conte di Modica e grande giustiziere del regno, e propriamente dell'episodio assai noto della scalata al castello per rapire la bella e giovane regina Bianca.
Altri tamburi e pifferi irrompevano da un'altra strada nel Cassaro e la folla investita, si apriva per lasciare il campo a un esercito di nuova specie, fanti di non si sa quale epoca, vestiti di corazze e di elmi di carta argentata, armati di ferule, comandati da generali. Si dividevano in due schiere, picchiandosi e rincorrendosi con un chiasso indiavolato.
Più in là era un "ballo di schiavi" dal volto impiastricciato di nerofumo e olio, i quali, pur ballando, correvano addosso a questo e a quello, per baciarlo e lasciargli l'impronta nera in qualche posto del viso; onde un correre di qua e di là per scansare quegli abbracci, un generarsi di episodi comici, che suscitavano un'allegria chiassosa e violenta.
Ma ancor più viva era l'allegria eccitata dalle "mamme Lucie", uomini travestiti nel costume delle cortigiane, che andavano ballando, con dimenamenti di anche o gesti lubrici, abbracciando or questo, ora quell'altro, e provocando motteggi, gesti, commenti licenziosi, che facevano ridere sguaiatamente la moltitudine.
E dappertutto era un rullare di tamburi in cadenza, uno stridere di pifferi, uno scoppiettare di nacchere, un frastuono indiavolato, in mezzo al quale volavano da una parte e dall'altra arance, torsoli, uova piene di cipria o di gesso. Qualche volta si levava un bastone, s'udivano grida, la gente si sbandava impaurita, cento voci si mescolavano in una voce sola, una testa rosseggiava di sangue, un ferito veniva portato via e lo spazio si richiudeva, il fiotto della gioia pazza e spensierata vi passava sopra; il carnevale portava via, travolgeva, disperdeva quell'episodio di sangue.
La carrozza di donna Gabriella era costretta a fermarsi di quando in quando, per la gran ressa di popolo. Delle maschere ne approfittavano, si affacciavano allo sportello con quella libertà che un pezzo di cartapesta o di seta sul volto conferisce, e sciorinavano qualcuno dei motti carnevaleschi:
Ovu di canna
vistuta mi pariti 'na palumma
l'occhiu mio tu si, lu cori inganna!...
Ciuri di linu
'Na turturedda cu l'occhiu baggianu
Vi mancanu l'aluzzi 'nta lu schinu.
Donna Gabriella se ne stava in fondo alla carrozza, mentre i suoi volanti cercavano di allontanare gli importuni che, lasciata la padrona, si attaccavano a loro e ogni tanto facevano loro scoppiare alle spalle una vescica gonfia d'aria.
La carrozza potè a stento percorrere il Cassaro fino all'ospedale di S. Bartolomeo presso Porta Felice; lì si fermò accanto alla chiesa di S. Nicolò ora distrutta e donna Gabriella, sporgendo un po' il capo dallo sportello, guardò in fondo alla via Butera, per vedere qualche cosa.
Vide la strada piena di carrozze e di portantine, e una fiamma di compiacimento le salì sul volto.
"Ah! - disse fra sè, - evidentemente si sposano ora!... Meno male".
In quel momento avrebbe voluto trovarsi in un angolo del palazzo per vedere gli sposi; e v'era nel suo desiderio un malvagio piacere di vendetta, giacchè immaginava che mai nozze erano state così tristi e funeree, come quelle che univano quelle due vite.
Diede ordine di risalire per il Cassaro, quando vide venire un carro che pareva una nave, con l'albero in mezzo, la vela ammainata e una dozzina di marinai, vestiti riccamente alla turca, sul ponte, donde gettavano sulla folla manate di confetti, e lanciavano sui balconi confetture più fini, ravvolte in cartocci dorati. Una turba di monelli si contendevano i confetti caduti e si menavano botte disperate, fra le risa e gli schiamazzi di tutti.
Donna Gabriella si nascose in fondo alla carrozza per non farsi vedere, ma notò con stupore che la finta nave, invece di girare al largo per risalire il Cassaro, o Toledo, piegò a destra, per la strada Butera.
"Dove va dunque?" si chiese.
La nave si fermò sotto i balconi del palazzo Butera; dei musici che erano nascosti nel fondo della nave intonarono un'aria al suono di violini e di chitarre, che richiamò gente al balcone. Ma mentre i musici cantavano e sonavano, i turchi saltavano giù dalla nave con scimitarre sguainate, e salivano su per lo scalone coperto di ricchi tappeti.
Donna Gabriella provò una lieta sorpresa, ma quando vide da carrozze e portantine scendere dame e cavalieri in maschera, capì che il principe dava una festa in costume, seguendo i capricci della sua fantasia vivace e nuova Un pensiero le balenò allora per la mente, che la fece sorridere, e ordinò al cocchiere di ritornare a casa subito, evitando la folla, per fare più presto.
Tre quarti d'ora dopo, da una ricca portantina smontava a piè dello scalone una dama, in domino celeste, con un gran nastro bianco sulla spalla e il volto coperto da una mascherina nera, che lasciava scoperta la bocca rosea e deliziosa.
Ella salì rapidamente, svelta, ma quando giunse nella grande sala, si fermò un po' timida e irresoluta. Il principe le andò incontro, porgendole la mano. Le mani inguantate e i piedini del domino gli avevano rivelato una dama di qualità, ma la legittima curiosità di padrone di casa gli faceva guardare il domino con insistenza, come per riconoscere chi fosse.
"Vostra signoria" gli disse il domino, "mi permetterà di serbare l'incognito, anche con lei..."
"Nè io, bella mascherina, oserò svelarlo. D'altronde si sente che dovete essere una delle più adorabili dame della nostra città e tanto basta...."
Ella lo ringraziò con un gesto, e si cacciò tra la folla degli invitati che gremiva i saloni, in uno dei quali si danzava.
Violante era lì, nel suo vestito di sposa, bianco, col lungo velo appuntato sul capo da una ghirlandetta di gemme. Il suo volto era più bianco del velo e della veste e soltanto gli occhi neri, sprofondati nel livido delle occhiaie, mettevano una macchia scura in tanta bianchezza, e davano al suo aspetto qualcosa di spettrale.
Accanto a lei Emanuele, anche lui vestito di raso bianco ricamato d'oro e di gemme, se ne stava impettito, in un atteggiamento artificioso e ostentato; il suo volto però era rosso, come se il colletto, stringendogli la gola, lo congestionasse. Nel suo aspetto si leggeva una stizza, un dispetto odioso, un desiderio di usare prepotenza e rappresaglie, di vendicarsi di qualche cosa, di sfogare: e nessun lampo di gioia, nessun balenio di sensualità.
Gli sposi avevano finito allora di ballare, e s'erano ritirati in fondo al salone. Avevano ballato, perché toccava a loro aprire le danze, ma senza genio, senza entusiasmo, senza piacere: anzi ad entrambi non era parsa l'ora di ritirarsi. Pareva che le cadenze dei violini mettessero sui loro nervi un senso di molestia indefinibile.
Le maschere si abbandonavano a una allegria frizzante, come un vino spumoso, motteggiando dame e cavalieri, ballando, saltando, ridendo, dispensando confetture e frizzi. Esse prendevano di mira gli sposi e specialmente Emanuele, al quale sussurravano all'orecchio delle cose buffe o dei doppi sensi o delle raccomandazioni un po' libere.
Emanuele si era difeso, ma a poco a poco, per non parere ridicolo col suo sussiego, si era lasciato trasportare, e rispondeva con frizzi, punzecchiando anche lui, anche per suo sfogo.
Poi, domandato permesso a Violante, che del resto non desiderava di meglio, si mescolò anche lui al tumulto della festa, non per divertirsi, ma per sottrarsi a quella posizione incresciosa e imbarazzante, accanto a una sposa che non aveva fino allora mostrato di accorgersi di lui.
Il domino si avvicinò a Violante; la squadrò da capo a piedi, e tentennando il capo le disse piano con voce di falsetto:
"Povera piccina!... Ti compiango!"
Violante trasalì. C'era qualcuno dunque che indovinava o leggeva dentro il suo cuore. Quel domino era il primo che invece di sussurrarle un complimento o uno dei soliti auguri, la compiangeva. Il domino le si strinse più vicino e, abbassando ancor più la voce, le mormorò quasi all'orecchio:
"Di questo matrimonio devi ringraziare due persone: tuo padre, che Dio gli perdoni, e don Blasco da Castiglione..."
Questo nome destò un improvviso e fugace rossore sulle guance di Violante che si riscosse tutta, guardò vivamente il domino come per indovinare dagli occhi lampeggianti sotto la maschera il resto del volto. Che ne sapeva? Come poteva dire una cosa simile? Come conosceva Blasco?
Non soltanto curiosità, ma un bisogno del suo cuore animarono il suo volto. La statua parve compenetrata da un soffio di vita, il cuore, che pareva chiuso, si aprì a un tratto a un cumulo di sentimenti. Avrebbe voluto domandare, e non osava. Chi era quel domino celeste?... Perché le aveva detto quelle parole? Il domino la guardava. Non si poteva dire quale sentimento perverso lo avesse spinto a parlare, perché il suo aspetto era impenetrabile e ci voleva una gran finezza di osservazione, per scoprire nella curva della bocca un sorriso di crudele compiacimento.
"Ti meravigli?" le sussurrò con voce insinuante, nella quale si sentiva qualche fremito; "ma è come ti dico io: senza le colpe di tuo padre, e senza la generosità del signor Blasco, che combinò questo matrimonio, tu saresti felice..."
Queste parole erano ancor più oscure delle prime, ma pure serrarono il cuore di Violante in una stretta gelida. Il domino celeste, sicuro di averle gettato lo sgomento nel cuore, si allontanò. Violante però lo trattenne.
"Aspettate... ascoltatemi..."
Ma il domino fece un gesto di diniego col capo e si cacciò tra gli in vitati, lasciandola stupita, agitata, ansiosa. Blasco aveva combinato quel matrimonio? Perché l'aveva gettata fra le braccia di Emanuele? Quale interesse aveva dunque?.. Ella sapeva che Blasco era un Albamonte. Un pensiero le attraversò la mente: non erano quelle nozze forse un servizio roso dal bastardo al fratello legittimo, per un compenso? Era dunque l'uomo che ella aveva amato con tutta la poesia della prima giovinezza un essere così abietto? Ed Emanuele? Le fece schifo; quell'uomo non le era mai apparso così ripugnante come in quel momento.
Il domino celeste aveva cercato e affrontato Emanuele, mentre alcuni suoi amici lo stuzzicavano.
"Lo lascino stare, signori; il signor duca è in questo istante assai preoccupato."
"Davvero? Preoccupato di che? Gentile mascherina, vogliamo sapere perché è preoccupato..."
"Ah, questo poi no, signori! questo è un segreto, che non posso tradire..."
Emanuele, sorridendo con uno sforzo domandò:
"Nemmeno io potrò saperlo?..."
"Voi?... Volete saperlo da me? Ma il segreto è vostro. Ah! ah! ah!..."
Se ne andò ridendo. Emanuele, che non capiva nulla, rimase sconcertato, ma questo suo sbalordimento fu interpretato come una implicita confessione che egli avesse un segreto e allora lo circondarono, lo stuzzicarono, lo punzecchiarono. Volevano sapere il segreto.
Egli si liberò sgarbatamente, per raggiungere il domino celeste, e lo fermò nel momento che esso, vedendo passare Coriolano della Floresta, gli diceva:
"Offritemi il vostro braccio, signore, e difendetemi dal signor duca della Motta..."
Emanuele abbozzò un sorriso e disse:
"Gentile mascherina, io non sono aggressore di belle e gentili dame..."
"Eh!" interruppe il domino con intenzione. "Siete sicuro che non vi si possa dare una smentita?"
Emanuele si morse le labbra.
"Chi siete?" domandò. "Voi mi rendete curioso da morirne..."
Ma il domino eluse la domanda:
"Dio mio, come potete lasciare sola la vostra adorabile sposina? Vedete? La vostra lontananza l'addolora tanto, che ha un aspetto cadaverico! Andate a consolarla... Non voglio rubarle lo sposo..."
"Oh, non temete...."
"Potrebbe ingelosirsi..."
"Non ci pensate..."
"Non è dunque gelosa di voi?"
"Ma no!"
"No? Ma allora non vi ama? Ah, povero duca!... Come vi compiango!... Guardatevi bene: essa è figlia di don Raimondo... Domandate a Girolamo Ammirata chi uccise vostra madre..."
"Chi siete?" insistette Emanuele, non dominando la collera e il dispetto, e un senso di paura.
Ma il domino spinse il cavaliere della Floresta e si allontanò ancora una volta per ritornare a Violante. Il cavaliere della Floresta aveva udito le ultime parole e non aveva potuto dominare un senso di sorpresa. Guardò la bocca e le mani del domino celeste, e un sospetto gli attraversò la mente. Si chinò e disse a voce appena udibile:
"Badate, duchessa: vi si potrebbe riconoscere."
Toccò al domino trasalire con una aria di sgomento.
"Tacete!"
Ella era giunta presso Violante.
"Addio, sposina, tu non mi vedrai più, ma voglio lasciarti un avvertimento."
E appressatasi al suo orecchio le sussurrò:
"Guardati soprattutto dagli ami ci.. e ricordati che tuo padre fu ucciso."
Più che andarsene, fuggì lasciando Violante coi segni di uno sgomento angoscioso, e la visione del padre, agonizzante nel letto.
Emanuele che la seguiva con gli occhi, appena la vide uscire, chiamò un servo:
"Dieci scudi per te, se seguirai quel domino, e mi dirai chi è."
Mezz'ora dopo il servo era di ritorno. Emanuele, che lo aspettava con impazienza, gli mosse incontro.
"Ebbene?"
"Eccellenza, è la signora duchessa vedova della Motta..."
"Donna Gabriella! Lei!" esclamò Emanuele con accento nel quale l'odio, la collera, la vergogna, lo spirito di rivincita e di vendetta si fondevano, come turbini in un organo.