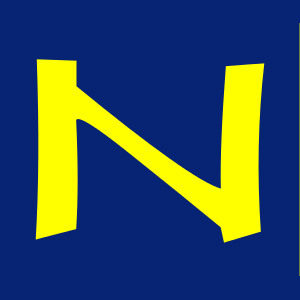Beati Paoli
di Luigi Natoli
parte quarta, capitolo 13
| Italiano | English |
Le feste per le nozze di Emanuele durarono due giorni. Il secondo giorno ebbero luogo nel palazzo del principe di Geraci, che non volle essere da meno del suo illustre congiunto. Il popolo ne ebbe la sua parte. Seguendo le tradizioni delle loro case, i due signori vollero che il popolo partecipasse della loro gioia, più o meno profonda e vi furono nel piano di Bologna, come già sulle Mura delle Cattive, fontane improvvisate che versavano vino, e cuccagne piene di panierini con dentro quanto poteva bastare perché gli ultimi giorni di carnevale un povero diavolo facesse baldoria. Vi furono manciate di monete gettate dal balcone sulla folla che se le contendeva a pugni, tra grandi risa dei nobili magnifici signori, e a gloria degli sposi.
Questi, però, non parevano commuoversi di tutto ciò nè dei ricchi pranzi, nè dei balli signorili, nè dei pugilati del popolo.
Violante vedeva con raccapriccio avvicinarsi l'ora in cui tutte quelle feste sarebbero finite. Emanuele era ancora sotto l'impressione dell'audacia e delle parole di donna Gabriella. La apparizione di quella donna aveva svegliato tutte le sue cupidigie di possesso, di rivincita, di vendetta, d'odio.
Due ore dopo la mezzanotte del lunedì, i due sposi furono accompagnati al palazzo della Motta, che dopo tanto tempo vedeva nuovamente riaprirsi le sue sale ai padroni e vi furono lasciati con gli auguri più fervidi.
Violante rientrava in quel grande e vasto palazzo dove era stata padrona per diritto ereditario, dove ora non era altro che la moglie del padrone; rientrava in quel palazzo così pieno di dolorose memorie, dove era morto suo padre. Nulla avevano rinnovato della antica distribuzione delle sale e del mobilio. La grande camera matrimoniale, con l'alcova incorniciata di fregi e di stucchi, col grande letto in ferro battuto a fogliami smaltati di azzurro, di rosa e d'oro; le cortine di damasco cremisi, il grande reliquiario di filigrana d'argento dentro la custodia di tartaruga e d'oro; lo scrigno intarsiato, con le maniglie di bronzo dorato, la scrivania chiusa, il piccolo canapè di damasco, lo specchio ovale nella sua cornice a cartocci dorati; il quadro della Madonna un po' annerito.... Tutto era lì, come lo aveva veduto lei, nella sua fanciullezza, quale lo avevano tramandato da due o tre generazioni, intatto, come una tradizione di famiglia e da ogni cosa sorgevano le memorie della sua vita.
Lì in quella camera era nata; lì era morta sua madre, della quale lei non serbava alcun ricordo nella mente, ma soltanto una piccola miniatura.
In un attimo tutta la sua vita le si presentò dinanzi alla memoria come una di quelle grandi tele degli antichi pittori, nelle quali d'intorno alla figura principale, sono istoriate in piccoli quadri tutte le vicende della sua esistenza, dalla nascita alla morte. La sua fanciullezza ignara e felice nel monastero di Montevergini; la sua matrigna, il ratto, l'improvviso e miracoloso intervento di Blasco; il castello dove erano state sequestrate lei e donna Gabriella; la morte di suo padre, assassinato... E ogni quadro di questa storia le metteva innanzi Blasco e con lui la matrigna... Ella rivedeva il coltello in pugno di donna Gabriella e rivedeva poi donna Gabriella stessa in molle abbandono sul petto di Blasco... Un dolore vivo e acuto le si rinnovò nel cuore, che pareva in quei quattro anni essersi assuefatto all'idea che tutto fosse morto e dimenticato; la piaga che credeva chiusa si riaprì sanguinando, in quella camera e dinanzi a quel letto, dove le pareva di scorgere i due volti, quello di donna Gabriella e quello di Blasco assopiti sullo stesso guanciale, come si era ritrovata lei una mattina, la più soave delle sue mattine, nella stanza della villa.
Adesso entrava anche lei in quella camera ma con un altro uomo e le mani che ve la sospingevano erano quelle di Blasco!... Blasco che ella aveva amato, Blasco che l'aveva tradita. L'aveva venduta? Venduta a Emanuele, forse, per avere il diritto di chiamarsi Albamonte? Forse per avere uno stato?
Le parole del domino celeste le risonavano ancora all'orecchio: le colpe di suo padre e la volontà di Blasco l'avevano gettata nelle braccia di Emanuele. Quali colpe? Di che cosa era colpevole suo padre? Delle mezze notizie confuse, udite qua e là sulle bocche, si affastellavano o si mescolavano nella sua mente. Ricordava tutto quello che si era detto all'apparire di Emanuele sulla scena della società aristocratica; questo rampollo legittimo, sbucato improvvisamente dall'ombra, il giorno stesso in cui suo padre era assassinato. Le parole: usurpazione, delitto, Beati Paoli, sulle quali lei non si era fermata, e di cui non aveva compreso il significato, le ritornavano alla memoria, agghiacciandole il sangue. Le pareva che nè Emanuele, nè Blasco fossero estranei a quei fatti così spaventevoli, che, a un tratto, l'avevano resa orfana e l'avevano cacciata via da quel palazzo, dove ora rientrava moglie di uno di quei due, per complicità dell'altro.
L'anima sua era oppressa da tutti i dolori e da tutte le disperazioni. Quel matrimonio le appariva ora più odioso che mai e tutte le ribellioni frenate da un dolore rassegnato, irrompevano ora dall'animo con una violenza che la rendeva audace.
Emanuele era lì, sulla soglia della camera, sulla quale ella si era fermata sorpresa da tutte quelle idee; era dietro a lei, così vicino che quasi si toccavano. Giammai le era sembrato così ripugnante, così odioso come in quel momento.
Lo guardò cupamente.
Anche lui pareva sopraffatto da una idea. L'idea di quel matrimonio, di dover passare la vita con quella fanciulla che non gli destava neppure un fremito di sensualità, lo spaventava. Oltrepassare quella soglia, abbracciare quella donna, perché gli era imposto, e perché almeno per quella prima volta era necessario, gli sembrava qualcosa che superava le sue stesse forze.
Egli non sapeva vincere la sua profonda avversione.
Quella casa, nella quale rientrava da signore e che non aveva mai abitato, conservava ancora la memoria di donna Gabriella ed egli provava una specie di ardore rabbioso contro quella donna che non aveva potuto e saputo possedere.
Anch'egli guardò Violante, senza poter frenare i sentimenti che gli agitavano il petto e gli davano un'espressione di riluttanza, di rancore.
Non si risolvevano a dire una parola, che, forse, si leggevano fra le labbra.
Emanuele ruppe il silenzio per primo:
"È superfluo, credo, dirvi che queste nozze io non le ho desiderate e tanto meno sollecitate e che soltanto la volontà dei nostri parenti ce le ha imposte."
"Lo so, signore," rispose Violante, soddisfatta del tono che prendeva il discorso, e a cui quelle parole "volontà dei parenti" richiamava le altre del domino celeste "la volontà di Blasco".
"Ne sono contento; ciò risparmia delle spiegazioni... Fra noi non c'è nessun vincolo di sentimento. Mi dispiace doverlo dire, ma io non provo per voi ciò che si dice amore e vorrei fin d'ora avvertirvi che i nostri rapporti saranno quelli strettamente necessari perché la stirpe degli Albamonte non si estingua..."
Violante non capì. Ella ignorava del tutto quali potessero essere questi rapporti e guardò Emanuele con un certo stupore:
"Non so di che cosa vogliate parlare," disse; "ma è bene che vi dica lealmente, che neppure io vi amo, e che non vi amerò mai..." Emanuele arrossì, punto nel suo amor proprio. Voleva per sè solo il diritto di rifiutare e respingere la fanciulla, e quella dichiarazione lo irritò.
"Non m'importa," disse; "non cerco e non vi domando il vostro amore, nè lo domanderò mai. Anzi, salvo quei rapporti, noi vivremo come due estranei. Io intendo godere di tutta la mia libertà, senza che voi abbiate il diritto di dolervi o di querelarvi di me..."
"Ma io non ho che un dolore, signore: quello di essere legata a voi per sempre... E quanto al vivere come due estranei, è quello che desidero ardentemente. Vi prego anzi di farmi apparecchiare la mia camera di fanciulla: questa la cedo a voi, perché suscita troppo dolorose memorie in me..."
Emanuele fece un cenno col capo.
"Ciò m'è indifferente. Questa o altra è la stessa cosa, sebbene mi paia più conveniente che voi restiate qui, ma di questo si parlerà appresso. Ora che ci siamo intesi, poichè non credo che vogliate passare la notte a discorrere qui, sulla soglia della camera, vi prego di spogliarvi e andare a letto."
Violante arrossì di vergogna: un lembo della realtà le si scopriva. Tremando gli disse:
"Ma io non ho sonno, signore; e starò bene seduta..."
"Non si tratta di avere sonno," disse Emanuele con un sorriso sguaiato.
Stette un minuto aspettando una risposta che non veniva, e ripetè:
"Non possiamo passare la notte così seduti a discorrere..."
La fanciulla intuì il pericolo. Con le fiamme del pudore si confusero quelle dello sdegno e della ripugnanza.
"Non capisco, perché non possa..."
"Ma lo capirete dopo, diamine!... Del resto non sono cose che si dicono..." su, andate a letto...."
Violante si fece cupa, ma prese una risoluzione:
"Ebbene, uscite dunque, signore..."
Emanuele sorrise, alzò le spalle rudemente e disse:
"Ecco una cosa stupida; ma sia pure. Vi accontento."
Uscì, aggiungendo:
"fate presto. Non vorrete lasciarmi fuori..."
Ma Violante chiuse la porta col catenaccio.
Paventando le insidie e le sorprese dei Beati Paoli, don Raimondo aveva munito le porte delle camere e le finestre di stanghette di ferro, che le rendevano sicure. Violante sbarrò lo uscio, ringraziando mentalmente Iddio di quella difesa e si sentì sicura.
Emanuele udì dapprima lo stridere della chiave e del catenaccio e ne rise; udì poi il rumore della stanghetta e si insospettì.
"Che cosa fate?" domandò dietro l'uscio.
Violante non rispose. Egli aspettò un poco, poi bussò e disse attraverso l'uscio:
"Donna Violante... ebbene, perché non aprite ancora?"
Ma nessuna risposta gli giunse. Violante s'era rannicchiata in un angolo, premendosi con le mani il cuore tumultuante per la commozione. La porta era solida, le finestre anch'esse sprangate: per entrare bisognava spezzare le imposte a colpi di scure, e ciò avrebbe messo il palazzo in rivoluzione.
Emanuele aspettò ancora un istante, scosse invano la porta, per tentare di aprirla; chiamò con voce irosa:
"Donna Violante! donna Violante! ma aprite, per dio!" Essa allora rispose.
"Lasciatemi in pace. Non aprirò. È inutile stare a gridare e farvi sentire dalla servitù. Non fate scandali."
Egli serrò i pugni bestemmiando, e fu sul punto di menare un paio di calci che avrebbero sfondato la porta, ma capì che ciò lo avrebbe esposto al ridicolo: sarebbe accorsa la servitù, avrebbero capito di che si trattava, ne avrebbero fatto le più matte risate, e la storiella si sarebbe saputa per tutta la città, aggiungendosi a quelle delle sue disavventure con donna Gabriella. Non c'era che una sola via: quella di andarsene: da marito respinto prendere l'apparenza di marito che respinge; il che, salvando lui, avrebbe anche potuto pregiudicare Violante. Ma il puntiglio, la vanità, l'ira che in lui prendevano il posto di ogni sentimento ragionevole, lo trattenevano lì, dietro quella porta, fra il sì e il no.
Insistette ancora un poco: poi prese una risoluzione, la meno chiassosa che poteva, per non esporsi ai commenti della servitù. Attraversò pian piano due o tre stanze, entrò nell'antico studio di don Raimondo, che serbava l'austero silenzio della scienza tra gli alti scaffali pieni di libri e si sprofondò in una grande sedia a bracciuoli, dinanzi al tavolo, come uno che abbia una grande idea da fissare sulla carta.
La lucerna a tre becchi, che egli aveva deposto sul tavolino, gettava una luce rossastra in mezzo alla stanza, mentre il resto dello studio rimaneva in una penombra incerta. Sul soffitto, in un grande riquadro a stucchi, era dipinto lo stemma degli Albamonte; di fronte al tavolino, fra gli scaffali pendeva dalla parete un grande ritratto di don Raimondo, nella toga di presidente della gran corte criminale con una mano appoggiata sopra un libro, forse le costituzioni del regno, l'altra sul fianco, con un gesto di dominio. Nella penombra non si vedevano bene le fattezze, ma si indovinava nella linea sottile della bocca e nell'angolo della mascella quel non so che di felino e di perfido che faceva gelare il sangue al vederlo.
Egli lo riconosceva. Era l'uomo che l'aveva fatto buttare vergognosamente nelle carceri del Castello a mare e del quale ora, per un gioco del caso, aveva sposato la figlia. Emanuele non aveva mai dimenticato quel "cavallo" ignominioso, e tutte le volte che un risveglio di memorie glielo ricordava si sentiva montare il sangue alla testa. Ora l'immagine di quell'uomo gli stava dinanzi e si associava a quella della figlia, dalla quale riceveva un trattamento che non gli pareva meno ingiurioso di quel supplizio; e nello stesso sentimento di odio avvolgeva il padre e la figlia.
E ora, raffrontando le sembianze di Violante, fredde e tristi, con quelle di don Raimondo, gli pareva di scorgere in entrambe qualcosa di comune: la stessa espressione tagliente e minacciosa. Aveva dunque la fanciulla ereditato dal padre? Era forse capace di cacciargli un pugnale fra le reni, fingendo di abbracciarlo?
"Domani, - pensava, - farò togliere quel ritratto; lo farò buttare in soffitta. Come mai ve l'hanno lasciato? Perché non me l'hanno detto?".
Egli però mentiva. Due giorni prima, invitato a vedere se tutto era bene ordinato nel palazzo che egli andava ad abitare, aveva veduto il ritratto e non aveva fatto alcuna osservazione. Forse lo aveva guardato distrattamente, preoccupato com'era delle prossime non sospirate nozze.
"Lo farò rosicchiare dai topi".
Era la sola vendetta che poteva prendere di quell'uomo. Ma la sposa?
Che avrebbe fatto la sposa? In verità egli si stupiva di non sentire in fondo al cuore altro che una effervescenza di odio per la persona, ma nessun vero profondo risentimento per l'atto. Non lo voleva? Ma in questo erano pari. Neppure egli voleva lei. Ciò che l'offendeva era lo scacco datogli dalla fanciulla del quale voleva vendicarsi, anzi doveva, per tante ragioni, e la vendetta doveva essere piena, aperta, completa.
Intanto bisognava non far trapelare agli occhi della servitù nulla di quanto era passato quella prima notte di nozze, o se mai, far credere tutto l'opposto di quanto era accaduto. S'immerse nella ricerca del come e finì per addormentarsi nel seggiolone, sotto lo sguardo immobile del ritratto che pareva lo sorvegliasse.
I campanacci delle capre che venivano di buon mattino in città a portare il latte lo destarono di soprassalto. Temeva di essere scoperto dalla servitù e di lasciare indovinare che egli aveva passato la notte fuori della camera nuziale. Ritornò nell'anticamera, fingendo di essere uscito proprio allora dalla sua camera, e tirò il cordone del campanello.
Il suo cameriere accorse, meravigliandosi di vedere il padrone col vestito della sera, invece che con la veste da camera, ma ancor più meravigliandosi nel sentirsi ordinare la portantina.
"Vostra Eccellenza esce? A quest'ora?.."
"Zitto!" sussurrò Emanuele, con un sorriso significante; "la signora duchessa dorme; non bisogna svegliarla... Fa' preparare la portantina ordinaria..."
Un quarto d'ora dopo egli usciva dal suo palazzo e si faceva condurre dalla signora Nina Manfredini, celebre prima donna che durante il carnevale aveva cantato al teatro di Santa Lucia dei Travaglini - come allora si chiamava il Bellini - che, sebbene non potesse rivaleggiare col Santa Cecilia, teatro d'opera principale, dava tuttavia bei spettacoli.
Emanuele, frequentatore del teatro, aveva fatto una corte assidua e fortunata alla prima donna signora Manfredini, e fino alla vigilia delle nozze era andato a passare qualche ora piacevole con lei. Scherzando, lei gli aveva detto:
"Quanto pagherei per vedere vossignoria illustrissima nel suo vestito di sposo!..."
Emanuele s'era lasciato sfuggire una promessa:
"Perché non mi vedreste?"
Si era improvvisamente ricordato di quella sua promessa e vi aveva veduto la salvezza. L'avrebbero giudicato uno scapestrato, ma avrebbe scansato il ridicolo e forse si sarebbe potuto trovare una scusante per quella sua scappata.
La signora Manfredini aveva in quel la stagione mandato in visibilio i giovani di Palermo per la sua bellezza e per la sua voce; e parecchi si erano disputati le sue grazie. Ma Emanuele aveva avuto il vantaggio di averla conosciuta a Roma e per ciò era stato scelto come naturale protettore della signora.
Il successo aveva tanto soddisfatto la vanità di Emanuele, che aveva colmato di doni la bella cantante, con gran soddisfazione del marito, il quale dapprima non s'era mostrato contento della scelta fatta dalla moglie.
La relazione doveva troncarsi col matrimonio di Emanuele, il quale coincideva con l'ultima rappresentazione degli Inganni felici musica dello Scarlatti, in cui la Manfredini eccelleva e che era anche l'ultima rappresentazione della stagione teatrale che in quei tempi durava - almeno a Palermo, - per il carnevale soltanto.
L'ultima sera in cui Emanuele aveva veduto la Manfredini, la bella donna aveva versato abbondanti lacrime di dolore, che avrebbero commosso un sasso, ed avevano eccitato a fondo la vanità del giovane: e fu tra quelle lacrime e quella commozione che ella uscì in quella esclamazione, ed Emanuele si lasciò sfuggire quella promessa alla quale si era attaccato.
La signora Nina dormiva, quando fu svegliata dai colpi battuti alla sua porta. Ella non fu meno sorpresa, insonnacchiata com'era, nel vedersi comparire dinanzi Emanuele, che, sorridendo e stendendo galantemente la mano, le disse:
"Eccomi a voi nel mio vestito da sposo..."
Parve commuoversi di questa attenzione, che ebbe il potere di chiudere la bocca al bravo Manfredini marito, che in verità non s'era svegliato volentieri per fare i dovuti onori al mecenate di sua moglie.
Lo stupore della servitù, quando si seppe che il duca della Motta aveva trascorso la notte in casa della cantante, chiudendo a chiave la moglie, non ebbe limite. Le cameriere per poco non piansero la mala sorte della loro padrona. Ma lo stupore crebbe, quando, non sentendosi ancora chiamare, s'avvidero che Violante s'era chiusa internamente e si rifiutava di aprire.
Intanto cominciavano a giungere i parenti intimi, per dare agli sposi la ben levata e gli auguri di prole mascolina. Allora soltanto, quando udì la voce dei suoi nonni, Violante disserrò l'uscio. Le sue prime parole, senza aspettare che i nonni le domandassero spiegazione di quella novità furono:
"Riconducetemi nel monastero, ve ne scongiuro!..."
Il principe rise, interpretando a suo modo lo sgomento e la preghiera della fanciulla.
"Via! cosa è cotesta fanciullaggine? Si capisce che doveva essere così... ma ormai tutto è finito..."
La principessa l'abbracciò sorridendo anche lei, sussurrandole qualche parola all'orecchio, ma, all'aspetto stupito della fanciulla, che non aveva capito niente, e che non sapeva che cosa rispondere, rimase come balorda.
"Ma dov'è tuo marito?" le domandò.
"Mio marito? Ma non l'ho veduto; egli non ha dormito qui; non voglio."
"Oh..."
Si accorsero allora che il letto era intatto.
"Che cosa vuol dire questo?"